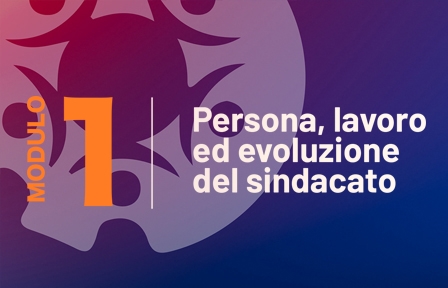A prima vista nessuno si schiera contro la dignità del lavoro. Non rappresenta un ideale controverso. Ma questo in astratto. Perché nella realtà vi sono al riguardo molti buchi nelle agende dei decisori. Un tema scomodo perché affrontato seriamente metterebbe in discussione i sostenitori della globalizzazione basata esclusivamente su logiche di mercato. Tutta sbilanciata sui consumi. La riflessione del filosofo americano tratta dal suo libro La tirannia del merito.
Al crescere della disuguaglianza negli ultimi anni e al rafforzarsi del risentimento delle classi lavoratrici, alcuni politici hanno risposto parlando della dignità del lavoro. Bill Clinton usò il termine più di qualsiasi altro presidente precedente e Donald Trump vi fa spesso riferimento. È diventato un gesto retorico popolare tra i politici di tutto lo spettro politico, benché sia principalmente al servizio di posizioni politiche ben note. Alcuni conservatori sostengono che tagliare il welfare, rendendo la vita più difficile agli indolenti e svezzandoli dalla dipendenza dal governo, onora la dignità del lavoro. Il ministro dell’Agricoltura di Trump affermò che restringere l’accesso ai buoni pasto “restituisce la dignità del lavoro a un segmento considerevole della nostra popolazione”. Difendendo un disegno di legge del 2017 che tagliava le tasse alle imprese e di cui beneficiavano soprattutto i ricchi, Trump dichiarò che il suo obiettivo era far sì “che ogni americano sperimentasse la dignità del lavoro, l’orgoglio di una busta paga”.
Da parte loro, i liberal si appellano talvolta alla dignità del lavoro nel tentativo di rafforzare la rete di sicurezza e aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori, alzando il salario minimo, offrendo politiche per l’assistenza sanitaria, il congedo parentale e i servizi all’infanzia, e fornendo un credito d’imposta alle famiglie a basso reddito. Ma questa retorica, supportata da queste proposte politiche sostanziali, non è riuscita a rispondere alla rabbia e al risentimento delle classi lavoratrici che ha portato alla vittoria di Trump nel 2016. Molti liberal hanno trovato tutto ciò sconcertante. Come potrebbero così tante persone, che hanno tratto beneficio economico da queste misure, votare un candidato che vi si è opposto?
Una risposta comune è che gli elettori bianchi delle classi lavoratrici, influenzati dal timore di uno spiazzamento culturale, hanno messo da parte i propri interessi economici oppure li hanno sottovalutati, per “votare col dito medio alzato”, come hanno detto alcuni commentatori. Ma questa spiegazione è troppo sbrigativa. Distingue in modo troppo netto tra interessi economici e status culturale. Le preoccupazioni economiche non riguardano soltanto i soldi che si hanno in tasca; riguardano anche il modo in cui il proprio ruolo nell’economia influenza la propria posizione nella società.
Coloro che sono stati lasciati indietro da quarant’anni di globalizzazione e di crescente disuguaglianza stavano soffrendo per qualcosa di più della stagnazione salariale; stavano sperimentando ciò che temevano fosse un’obsolescenza crescente. La società in cui vivevano non sembrava più aver bisogno delle competenze che essi avevano da offrire.
Robert F. Kennedy, quando nel 1968 puntava alla nomination a presidente da parte del suo partito, lo capì. La sofferenza dei disoccupati non stava semplicemente nel fatto che non avevano un reddito, ma che erano privati dell’opportunità di contribuire al bene comune.
“Disoccupazione significa non avere nulla da fare, che significa non avere nulla a che fare con tutti noialtri,” spiegò. “Essere senza lavoro, non essere utile ai propri concittadini, è in verità come essere l’Uomo Invisibile di cui scriveva Ralph Ellison.”
Ciò che Kennedy intravide nel malcontento del suo tempo è ciò che i liberal contemporanei non riescono a vedere nel nostro. Hanno offerto agli elettori delle classi lavoratrici e della classe media un grado maggiore di giustizia distributiva – un accesso più equo e più pieno ai frutti della crescita economica. Ma ciò che questi elettori vogliono persino di più è un grado maggiore di giustizia contributiva, un’opportunità per ottenere il riconoscimento e la stima sociale, che va di pari passo con la produzione di ciò di cui gli altri necessitano e apprezzano.
L’enfasi liberal sulla giustizia distributiva offre giustamente un contrappeso a un’attenzione univoca alla massimizzazione del PIL. Nasce dalla convinzione che una società giusta non mira soltanto a massimizzare il livello generale di prosperità, ma cerca anche un’equa distribuzione del reddito e della ricchezza. Secondo questa visione, le politiche che dovrebbero aumentare il PIL – come gli accordi di libero scambio o le politiche che incoraggiano le aziende a delocalizzare il lavoro in Paesi a basso salario – possono essere difese soltanto se i vincitori indennizzano i perdenti. Per esempio, i profitti in crescita delle aziende e degli individui che guadagnano dalla globalizzazione potrebbero essere tassati per rafforzare la rete di sicurezza sociale e per fornire sostegno al reddito o riqualificazione professionale ai lavoratori rimpiazzati.
Questo approccio ha dato forma al modo di pensare dei partiti di centro-sinistra mainstream (e di alcuni di centro-destra) negli Stati Uniti e in Europa a partire dagli anni Ottanta: abbracciare la globalizzazione e l’accresciuta prosperità che essa porta, ma utilizzare i guadagni per compensare la perdita subita dai lavoratori interni. La protesta populista equivale a una rinuncia a questo progetto. Guardando allo sfacelo compiuto, possiamo vedere perché questo progetto è fallito. Prima di tutto, non è stato mai davvero messo in atto. La crescita economica c’è stata, ma i vincitori non hanno compensato i perdenti. Al contrario, la globalizzazione neoliberale ha portato a una crescita senza sosta della disuguaglianza. Quasi tutti i guadagni della crescita economica sono andati a quanti stavano ai vertici e la maggior parte dei lavoratori non ha visto nessun miglioramento o quasi, anche al netto delle imposte. L’aspetto redistributivo del progetto è stato messo da parte, anche a causa del crescente potere del denaro in politica, quello che alcuni chiamano la “conquista oligarchica” delle istituzioni democratiche.
Ma c’era un problema ulteriore. L’attenzione alla massimizzazione del PIL, anche se accompagnata da un aiuto a quanti sono stati lasciati indietro, pone l’accento sul consumo anziché sulla produzione. Ci invita a pensare a noi stessi più come consumatori che come produttori. In pratica, ovviamente, siamo l’uno e l’altro. Come consumatori, vogliamo ottenere il massimo con i nostri soldi, vogliamo acquistare beni e servizi al minor costo possibile, che vengano prodotti da lavoratori a basso salario all’estero o da lavoratori americani ben retribuiti. Come produttori, vogliamo un lavoro soddisfacente e remunerativo.
Spetta alla politica conciliare le nostre identità di consumatori e di produttori. Ma il progetto di globalizzazione ha cercato di massimizzare la crescita economica, e quindi il benessere dei consumatori, con poca considerazione per gli effetti sul benessere dei produttori causati dalla delocalizzazione, dall’immigrazione e dalla finanziarizzazione.
Le élite che presiedevano alla globalizzazione non soltanto non sono riuscite ad affrontare la disuguaglianza che essa ha generato, ma non sono nemmeno riuscite a comprendere il suo effetto corrosivo sulla dignità del lavoro.
Il lavoro come riconoscimento
Le proposte politiche che mirano a compensare la disuguaglianza, aumentando il potere d’acquisto delle famiglie delle classi lavoratrici e della classe media o rafforzando la rete di sicurezza, riusciranno a fare ben poco per affrontare la rabbia e il risentimento che oggi sono molto radicati. E questo perché la rabbia ha a che fare con la perdita di riconoscimento e di stima. Anche se l’indebolimento del potere d’acquisto gioca senz’altro un ruolo, ad alimentare il risentimento dei lavoratori è soprattutto il danno al loro status di produttori, che è l’effetto combinato della selezione meritocratica e della globalizzazione guidata dal mercato.
Soltanto un’agenda politica che riconosca questo danno e che cerchi di dare nuova dignità al lavoro può parlare efficacemente del malcontento che turba la nostra politica. Una simile agenda non può non occuparsi sia della giustizia contributiva sia di quella distributiva, perché la rabbia che circola nel Paese è, almeno in parte, una crisi di riconoscimento: è nel nostro ruolo di produttori, non di consumatori, che contribuiamo al bene comune e che, nel far ciò, conquistiamo riconoscimento.
Il contrasto fra l’identità come consumatori e come produttori indica due modi diversi di intendere il bene comune. Un primo approccio, diffuso tra i decisori della politica economica, definisce il bene comune come la somma delle preferenze e degli interessi individuali. Secondo questo resoconto, realizziamo il bene comune massimizzando il benessere dei consumatori ovvero, tipicamente, massimizzando la crescita economica. Se il bene comune è semplicemente una questione del soddisfare le preferenze dei consumatori, allora i salari di mercato sono un buon modo per misurare chi ha contribuito a che cosa. Coloro che fanno più soldi hanno dato presumibilmente il contributo più apprezzabile al bene comune, producendo i beni e i servizi che i consumatori desiderano.
Un secondo approccio rifiuta questa nozione consumistica del bene comune a favore di quella che si potrebbe definire una concezione civica. Secondo l’ideale civico, il bene comune non consiste semplicemente nel sommare le preferenze o nel massimizzare il benessere dei consumatori. Consiste nel riflettere criticamente sulle nostre preferenze – idealmente, elevandole e migliorandole – affinché possiamo vivere una vita degna e fiorente. Il che non può essere ottenuto soltanto grazie all’attività economica. Richiede di confrontarci con i nostri concittadini su come realizzare una società giusta e buona, che coltivi la virtù civica e che ci permetta di ragionare insieme sugli obiettivi degni della nostra comunità politica.
La concezione civica del bene comune richiede, quindi, un certo tipo di politica, che fornisca spazi e occasioni per una deliberazione pubblica. Ma suggerisce anche un certo modo di pensare il lavoro. Dal punto di vista della concezione civica, il ruolo più importante che giochiamo in economia non è in qualità di consumatori ma di produttori. Infatti, è in qualità di produttori che sviluppiamo ed esercitiamo le nostre capacità di fornire beni e servizi che soddisfano appieno i desideri dei nostri concittadini e che conquistano la stima sociale. Il vero valore del nostro contributo non può essere misurato dal salario che riceviamo, perché il salario dipende, come fece notare l’economista-filosofo Frank Knight, dalle contingenze della domanda e dell’offerta.
Il valore del nostro contributo dipende invece dall’importanza morale e civica dei fini a cui sono tesi i nostri sforzi. Ciò implica un giudizio morale indipendente che il mercato del lavoro, per quanto efficiente, non può dare.
L’idea che la politica economica tenda in via definitiva al consumo è oggi così familiare che ci sembra difficile pensare di andare oltre. “Il consumo è l’unico fine e scopo di ogni produzione,” dichiarò Adam Smith ne La ricchezza delle nazioni, “e l’interesse del produttore dovrebbe essere considerato solo nella misura in cui può essere necessario a promuovere l’interesse del consumatore.” John Maynard Keynes riprese Smith, proclamando che il consumo “è l’unico scopo e fine di tutta l’attività economica”, e la maggior parte degli economisti contemporanei concorda. Ma una tradizione più antica nel pensiero morale e politico sosteneva il contrario. Aristotele sosteneva che la fioritura umana dipende dalla realizzazione della nostra natura coltivando ed esercitando le nostre capacità. La tradizione repubblicana americana insegnava che alcune occupazioni – prima l’agricoltura, poi il lavoro artigiano, infine il lavoro libero inteso nel senso più ampio – coltivano le virtù che preparano i cittadini all’autogoverno.
Nel ventesimo secolo, l’etica della produzione propria della tradizione repubblicana ha gradualmente ceduto il passo alle idee consumistiche di libertà e a un’economia politica di crescita economica. Ma l’idea che, persino in una società complessa, il lavoro avvicina tra loro i cittadini all’interno di un sistema di contributo e di riconoscimento reciproco non è scomparsa del tutto.
A volte, ha trovato una forma di espressione ispiratrice. Parlando ai netturbini in sciopero a Memphis, nel Tennessee, poco prima di essere assassinato, il reverendo Martin Luther King collegò la dignità dei netturbini al loro contributo al bene comune.
Un giorno la nostra società arriverà a rispettare i netturbini se vuole sopravvivere perché, a ben guardare, la persona che raccoglie la nostra spazzatura conta quanto il medico, perché, se non fa il proprio lavoro, le malattie dilagano. Tutti i lavori hanno dignità.
Nella Lettera enciclica del 1981, Sul lavoro umano, papa Giovanni Paolo II affermò che attraverso il lavoro l’uomo “realizza se stesso come uomo e anzi, in un certo senso, ‘diventa più uomo’”. Egli vide anche il lavoro legato alla comunità. “Tutto questo fa sì che l’uomo unisca la sua più profonda identità umana con l’appartenenza alla nazione, e intenda il suo lavoro anche come incremento del bene comune elaborato insieme con i suoi compatrioti.”
Qualche anno dopo, la Conferenza nazionale dei vescovi cattolici pubblicò una lettera pastorale che articolava l’insegnamento sociale cattolico sull’economia, offrendo una definizione esplicita di giustizia “contributiva”.
Tutte le persone “hanno un’obbligazione a partecipare attivamente e proficuamente alla vita della società”, e il governo ha “il dovere di strutturare le istituzioni economiche e sociali affinché le persone possano contribuire alla società con modi che rispettino la loro libertà e la dignità del loro lavoro”.
Alcuni filosofi laici danno voce a punti di vista analoghi. Il teorico sociale tedesco Axel Honneth ha argomentato che i conflitti contemporanei per la distribuzione del reddito e della ricchezza possono essere meglio compresi come conflitti per il riconoscimento e la stima. Anche se Honneth fa riferimento alla filosofia di Hegel – un pensatore noto per la sua complessità –, questa idea risulta intuitivamente plausibile a qualsiasi appassionato di sport che abbia seguito le controversie sugli stipendi che coinvolgono atleti altamente retribuiti. Quando i tifosi si lamentano di un giocatore che, pur guadagnando già milioni, vuole di più, l’atleta risponde immancabilmente: “Non è una questione di soldi, ma di rispetto”.
Questo è ciò che Hegel intende con la lotta per il riconoscimento. Più che un sistema per soddisfare i desideri in modo efficiente, il mercato del lavoro, secondo Hegel, è un sistema di riconoscimento. Non soltanto remunera il lavoro con un reddito, ma riconosce pubblicamente il lavoro di ogni persona come contributo al bene comune. I mercati da soli non forniscono competenze ai lavoratori né conferiscono riconoscimento, così Hegel propose un’istituzione affine alle associazioni di categoria o alle corporazioni per garantire che le competenze dei lavoratori fossero adeguate a dare quei contributi considerati degni di stima pubblica. In breve, Hegel argomentava che l’organizzazione capitalistica del lavoro che stava emergendo ai suoi tempi avrebbe potuto essere giustificata eticamente soltanto a due condizioni, descritte sinteticamente da Honneth: “Primo: il lavoro richiesto fornisca perlomeno un minimo salariale; secondo: l’esecuzione delle attività assuma una forma che possa essere riconosciuta come un contributo al bene comune”.
Ottant’anni dopo, il teorico sociale francese Émile Durkheim si basò sulla teoria del lavoro di Hegel per argomentare che la divisione del lavoro può essere una fonte di solidarietà sociale, a condizione che il contributo di ognuno sia remunerato secondo il suo reale valore per la comunità. A differenza di Smith, di Keynes e di molti economisti contemporanei, Hegel e Durkheim non vedevano il lavoro principalmente come un mezzo per raggiungere il fine del consumo. Al contrario, sostenevano che il lavoro, al suo meglio, è un’attività socialmente integrante, un’arena di riconoscimento, un modo per onorare la nostra obbligazione a contribuire al bene comune.
Giustizia contributiva
Nel nostro tempo profondamente polarizzato, in cui un gran numero di lavoratori si sente ignorato e non apprezzato e abbiamo un disperato bisogno di fonti di coesione sociale e di solidarietà, potrebbe sembrare che queste idee più robuste sulla dignità del lavoro trovino la propria strada nel dibattito politico tradizionale. Ma finora non è stato così. Perché? Perché l’agenda politica dominante è refrattaria all’aspetto contributivo della giustizia e alla sottostante etica incentrata sul produttore?
Potrebbe sembrare che la risposta risieda semplicemente nel nostro amore per i consumi, così come nella credenza che la crescita economica garantisca i beni. Ma qui è in gioco qualcosa di più profondo. Al di là dei benefici materiali che promette, fare della crescita economica un obiettivo prioritario della politica pubblica esercita un fascino particolare sulle società pluraliste come la nostra in cui brulica il disaccordo. Sembra che ci eviti di dover discutere su questioni moralmente controverse.
Le persone hanno opinioni differenti su ciò che è importante nella vita. Non siamo d’accordo sul significato di fioritura umana. Come consumatori, siamo diversi per preferenze e desideri. Di fronte a queste differenze, massimizzare il benessere dei consumatori sembra un obiettivo di politica economica neutrale dal punto di vista dei valori. Se il benessere dei consumatori è l’obiettivo, allora, nonostante le nostre preferenze eterogenee, avere di più è meglio che avere di meno. I disaccordi sorgono inevitabilmente su come distribuire i frutti della crescita economica e, pertanto, sulla necessità di dibattiti sulla giustizia distributiva. Ma tutti possono essere d’accordo, o almeno così sembrerebbe, sul fatto che ingrandire la torta economica è meglio che rimpicciolirla.
La giustizia contributiva, al contrario, non è neutrale rispetto alla fioritura umana o al modo migliore di vivere. Da Aristotele alla tradizione repubblicana americana, da Hegel all’insegnamento sociale cattolico, le teorie della giustizia contributiva ci insegnano che siamo compiutamente umani quando contribuiamo al bene comune e ci guadagniamo la stima dei nostri concittadini per i contributi che offriamo.
Secondo questa tradizione, il desiderio umano fondamentale è quello di essere necessari a coloro con i quali condividiamo una vita in comune. La dignità del lavoro consiste nell’esercitare le nostre capacità per rispondere a tali bisogni. Se questo è ciò che significa vivere una buona vita, allora è un errore concepire il consumo come “l’unico fine e l’unico oggetto dell’attività economica”.
Un’economia politica incentrata soltanto sulla dimensione e sulla distribuzione del PIL mina la dignità del lavoro e contribuisce a un impoverimento della vita civile. Robert F. Kennedy lo capì: “La fratellanza, la comunità, il patriottismo condiviso: questi valori essenziali della nostra civiltà non derivano unicamente dall’acquisto e dal consumo di beni insieme”. Derivano invece da “un impiego dignitoso retribuito con una paga decente, il tipo di impiego che permette a un uomo di dire alla sua comunità, alla sua famiglia, al suo Paese e, soprattutto, a se stesso: ‘Ho contribuito a costruire questo Paese. Partecipo alle sue grandi imprese pubbliche’”.
Pochi politici parlano così oggi. Nei decenni che seguirono a Robert F. Kennedy, i progressisti abbandonarono in gran parte la politica della comunità, del patriottismo e della dignità del lavoro, per offrire invece la retorica dell’ascesa. A quanti si preoccupavano della stagnazione dei salari, della delocalizzazione, della disuguaglianza e della paura che immigrati e robot venissero a prendersi il loro lavoro, le élite al potere offrirono consigli rincuoranti: andate al college. Preparatevi a competere e a vincere nell’economia globale. Quello che guadagnerete dipenderà da quello che riuscirete a imparare. Potete farcela se ci provate. Questi erano ideali adatti a un’epoca globale, meritocratica, guidata dal mercato. Lodava i vincitori e insultava i perdenti. Nel 2016, il suo tempo era scaduto. L’arrivo della Brexit e di Trump, e l’ascesa in Europa di partiti iper-nazionalisti e anti-immigrati, annunciarono il fallimento del progetto. […]
Brano tratto dal libro di Michael J. Sandel, La tirannia del merito, Feltrinelli, Milano 2021
© 2020 Michael J. Sandel © 2021 Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano