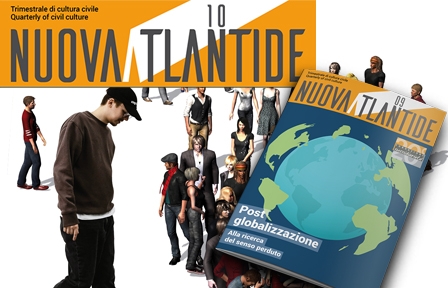Un Paese non ha futuro quando le realtà popolari sono comparse sfiduciate. E non più soggetti creativi, protagonisti che costruiscono luoghi vivi. Oggi prevale un brutto film. Dove la sceneggiatura è nella penna avvelenata dei teorici del neoliberismo selvaggio. Ma la marginalizzazione di un popolo e la grande abbuffata dei pochi ha prodotto crescita di povertà e disuguaglianza. In Italia, nel mondo. Una globalizzazione a senso unico retta dalla cultura dello scarto. Quando si insiste solo su Stato e mercato manca qualcosa. E i problemi, soprattutto sociali, decollano. Occorre riportare al centro della scena le comunità locali, le ricche espressioni culturali che desiderano costruire. E la cultura sussidiaria può fare da cinghia di trasmissione, lievito di un pensiero autenticamente rivoluzionario e partecipativo. Perché scommette sulla libertà della persona.
Di un io che ama partecipare solo ai bei film.
L’articolo è stato pubblicato su la Repubblica il 9 dicembre 2022 con il titolo “Pensare a chi sta peggio è questo il compito della nuova sinistra”
Dove sono finite le realtà popolari, di ispirazione laica e cattolica, che hanno fatto grande l’Italia?
Non credo si possa pensare al futuro del nostro Paese senza porsi questa domanda. Soprattutto guardando alla crescita di povertà e disuguaglianza. In Italia circa un quarto (25,4%) della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale, una quota fra le più elevate in Europa. Nella penisola la povertà assoluta affligge già 1,7 milioni di famiglie, per lo più nel Mezzogiorno.
Il valore del contributo di tutti
Il neoliberismo selvaggio non produce solo scarti ambientali, ma anche scarti umani, come non smette di ripetere Papa Francesco.
A livello globale, l’1% delle persone possiede oltre metà dell’intero patrimonio planetario e ogni giorno un milione e mezzo di esseri umani rischiano di cadere nella miseria. La crescita di povertà e ineguaglianza degli ultimi 30 anni non è solo un problema di welfare, ma anche conseguenza di un modello di sviluppo che ha perso di vista la centralità dell’economia reale rispetto alla finanza. Da questo punto di vista, come afferma l’ex governatore della banca centrale indiana Raghuram Rajan nel libro Il terzo pilastro,
Stato e mercato non riescono da soli ad affrontare questi problemi sociali. Sono le comunità locali a essere indispensabili. Insieme a un mercato regolato e a un sistema politico-istituzionale democratico ed efficiente, va messa in circolo in modo diffuso la cultura della sussidiarietà.
“Sussidiarietà” è una parola decisiva in questo momento storico perché parla di una cosa semplicissima: il valore del contributo di tutti, delle relazioni, della convivenza, in un’epoca di individualismo e disintermediazione. E parla della ricerca della migliore soluzione possibile ai problemi della convivenza, contro massimalismo e incompetenza. Il potenziale rivoluzionario della sussidiarietà consiste nel mettere in moto il dinamismo della coesione, della fiducia, dell’iniziativa costruttiva, solidale, in tempi post ideologici.
Mette al centro la persona come obiettivo e come attore dello sviluppo, tramite il lavoro, la cui la dignità deve essere tutelata, insieme all’obiettivo della piena occupazione.
L’esperienza di un popolo
Sussidiarietà vuole dire riattivare il desiderio di pensare al bene degli altri, non solo al proprio, e nel riattivare canali di comunicazione e di ascolto aperti, possibilisti, non autoreferenziali. Consiste nel rinunciare all’atteggiamento muscolare e difensivo per intraprendere un più coraggioso percorso che affronti la complessità del reale. Pezzi di società, di istituzioni e cittadini, che sono come monadi, persi nei loro mondi, devono potersi sentire parte di un progetto di rinascita, devono continuare a parlarsi, a comprendersi, a valutare le migliori soluzioni concrete possibili ai problemi e poi applicarle. Ma perché questo accada bisogna andare a rintracciare quello che resta dell’esperienza di un popolo. Che ha tante differenze e contraddizioni, ma ha un punto di forza: una ricca storia di realtà sociali di diversa ispirazione ideale, che hanno agito per il bene della collettività.
Quando ero bambino, la parrocchia del quartiere periferico di Baggio Forze Armate a Milano in cui vivevo, era un vero e proprio luogo di “welfare sussidiario”, oltre a svolgere la sua funzione di culto: aiuto gratuito per i poveri, servizi ai lavoratori e a chi aveva bisogno di una casa, sport e doposcuola gratuiti per i bambini. Tutto ciò avveniva anche in realtà di diversa ispirazione ideale, come i circoli socialisti e comunisti. Oggi questo mondo popolare ha cambiato pelle, ed è fortemente impegnato nel non profit e nel Terzo settore e aiuta le tante necessità dei più bisognosi. Il problema è che questa presenza copre il territorio a macchia di leopardo e dove non c’è lascia elevati livelli di ineguaglianza e povertà.
In Italia, come mostra il Rapporto 2022 della Fondazione per la Sussidiarietà, quando è minore la presenza di attività sociali e di volontariato, diminuiscono le possibilità di trovare lavoro, di avere stipendi adeguati e aumentano gli abbandoni scolastici e la povertà.
Cittadini “comunitari”
L’osservazione della realtà conferma questa tesi: basti pensare agli straordinari risultati che genera, per esempio, l’attività di padre Loffredo nel Rione Sanità a Napoli e che cosa accade invece laddove non c’è nessuno che rimetta in gioco capacità e spirito d’iniziativa a difesa dei più deboli. La cultura della sussidiarietà, in sintesi, spinge tutti a dare il meglio: lo Stato a sostenere la società nel dare risposte e a intervenire laddove non emergano; la società ad auto-organizzarsi, grazie al ricostituirsi di luoghi di partecipazione, confronto, apprendimento; i cittadini a concepirsi come “comunitari” e non solo come consumatori. Da questo dipende la tenuta e il rinnovamento del sistema democratico. Ma c’è un punto da cui può ripartire tutto questo circolo virtuoso: la ricostruzione di luoghi di partecipazione della società civile.