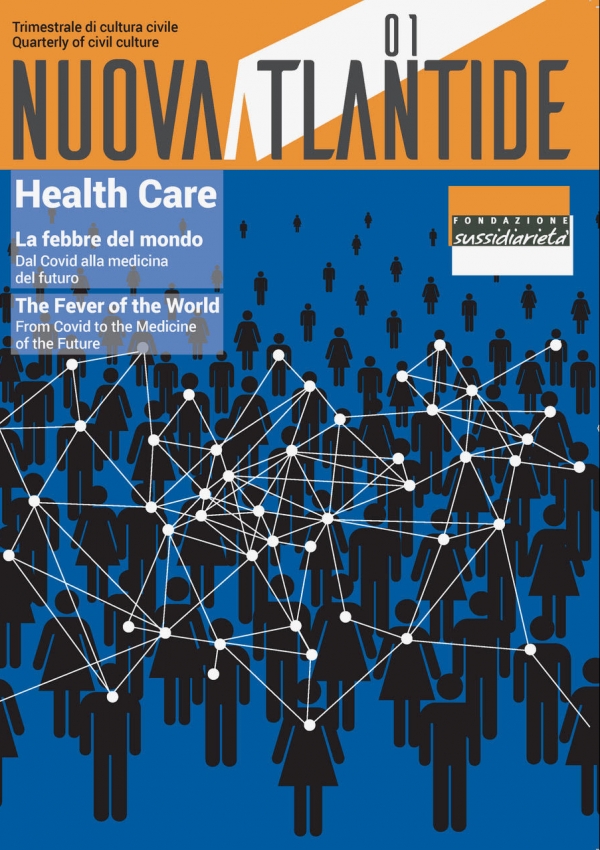Per stare bene come soggetti non possiamo mai prescindere, quantomeno come possibilità e prospettiva, dal rapporto con un altro. Il lockdown ha provato a scardinare questa logica. In realtà il virus ha funzionato da rilevatore dello stato dei rapporti, positivi o negativi che fossero, offrendo nuove possibilità o facendo esplodere situazioni già a rischio.
Sono molte le cose che avremmo potuto imparare dall’esperienza del lockdown. Innanzitutto, cosa non è la famiglia, che cosa non è la scuola, che condivisione e solidarietà non sono facili slogan. Dal lockdown avremmo potuto imparare molto. Non è detto che l’abbiamo fatto. In questo scenario il soggetto ha però una risorsa cui attingere: il suo pensiero. Oggi più che mai abbiamo bisogno di recuperare un pensiero sano.
Di fatto agli appuntamenti ci prepariamo costantemente, anche senza averne piena consapevolezza. Per riuscire ad alzarsi la mattina, lavarsi, vestirsi, pettinarsi, ossia per muoversi e prendersi cura di sé, occorre se non necessariamente avere un altro reale per cui farlo, tenere almeno presente la possibilità di incontrare un altro reale, occorre fargli posto nel pensiero, trattandosi di un posto occupabile da chiunque incroceremo per la via, che sia in modo programmato o inatteso.
Per stare bene come soggetti non possiamo mai prescindere, quantomeno come possibilità e prospettiva, dal rapporto con un altro. In fondo, anche quando ci guardiamo allo specchio la mattina prima di uscire non lo facciamo solo per noi, stiamo controllando come l’altro ci guarderà, quello che vedrà di noi, ossia verifichiamo come arriveremo agli appuntamenti che ci aspettano, tenendo a presentarci bene. All’interno del regime dell’appuntamento ogni soggetto si fa altro per il suo altro del rapporto e ugualmente considera l’altro come esso stesso un soggetto, in un rapporto di libera proposta e libera adesione. I protagonisti dell’appuntamento sono infatti entrambi soggetti che nella loro piena autonomia si fanno interdipendenti gli uni dagli altri.
All’improvviso sono caduti gli appuntamenti tradizionali della giornata. Chiuse le scuole, i negozi, i posti di lavoro, i luoghi di socialità, di cultura e di svago, le frontiere nazionali o regionali, è accaduto che le porte delle nostre case sono diventate delle barriere invalicabili e le mura, nuovi confini di una geografia segregativa, hanno rigidamente distinto un fuori e un dentro. Più nessuna fluidità né possibilità di contatto e interazione con l’esterno.
Le mancate colpe del Covid
Per molti è stato difficile e si sono create situazioni complicate, anche spiacevoli. Tuttavia il Covid-19 non ha causato niente, nonostante sia stato spesso ritenuto responsabile di tutto ciò. Al virus, che non è stato né cattivo né malvagio, dato che questi sono attributi di esclusiva pertinenza umana, non può essere imputato nulla se non il suo ostinato replicarsi in organismi ospiti; ha piuttosto fatto da cartina di tornasole. Come quella tradizionale è in grado di virare al blu o al rosso a seconda dell’acidità dell’ambiente in cui viene immersa, allo stesso modo il virus ha funzionato da rilevatore dello stato dei rapporti. Potremmo anche dire che li ha messi alla prova, nel senso che ha documentato il loro stato di salute, li ha testati sulla tenuta e ne ha provato la solidità.
Nelle case in cui i rapporti erano già tesi, magari in un precario e delicato equilibrio, il trovarsi chiusi dentro, la mancanza di vie d’uscita e di sfogo hanno esasperato la situazione, hanno accentuato i conflitti, hanno fatto deflagrare qualcosa che fino a quel momento era rimasto sottotraccia o si era contenuto nelle conseguenze.
Per i giovani lo abbiamo visto accadere anche rispetto alla scuola e agli amici. Chi già lavorava poco o male ha smesso definitivamente di farlo e la didattica a distanza è stata solo l’occasione per giustificare disimpegno e mancanza di iniziativa. Allo stesso modo chi già faticava nei rapporti con i coetanei, ne viveva un’estraneità di fondo, non riusciva a creare legami soddisfacente e coinvolgenti, ha approfittato del lockdown per isolarsi, per rinchiudersi in casa, se non addirittura in camera, connesso solo a dispositivi digitali che riuscissero a sedare almeno un po’ l’angoscia di un tempo ormai svuotato di tutto, che non passava mai.
Non è detto che in questa situazione si sia sperimentata una sofferenza di tipo psichico, c’è chi al contrario ci si è trovato bene, anzi potrebbe addirittura aver lasciato cadere alcuni sintomi che erano proprio legati al disagio di stare con gli altri. Si è trattato però di un benessere parziale, più dovuto alla rimozione di un aspetto faticoso della vita che alla acquisizione di un reale stato di vantaggio.
Dobbiamo per onestà riconoscere che è stato anche vero il contrario. Laddove i rapporti famigliari tenevano ed erano improntati a un sincero rispetto e condivisione, pur dentro tutti i compromessi e le concessioni che è talora necessario fare, il lockdown ha offerto delle nuove possibilità: le famiglie hanno potuto riassaporare il piacere di sedere a tavola per condividere i pasti, alcuni fratelli e sorelle hanno riscoperto la possibilità di trafficare bene insieme facendosi una buona compagnia, i coniugi hanno potuto riattivare flussi di parola e confidenza che avevano nel tempo perso il loro smalto primigenio. Per i giovani interessati a non mollare sui rapporti con i pari il digitale, invece che mezzo di fuga e isolamento, è diventato uno strumento prezioso di connessione, di condivisione, di scambio, anche per quanto riguarda la scuola e l’apprendimento.
Le cose sono quindi andate meglio a chi, di fronte alla perdita degli appuntamenti tradizionali che scandendo la giornata tornano di aiuto a vivere bene nella città degli uomini, magari dopo un iniziale senso di smarrimento e confusione, ha saputo crearne di nuovi e sfruttare al meglio quelli che erano rimasti.
Sono molte le cose che avremmo potuto imparare dall’esperienza del lockdown.

Cosa avremmo potuto imparare dal lockdown
Innanzitutto cosa non è la famiglia. La famiglia non è un clan, un circuito chiuso, autoreferenziale e autoprotettivo. È risultato evidente come la famiglia chiusa, che assume se stessa come unico orizzonte, soffochi e faccia star male i suoi singoli componenti. La famiglia infatti non è “auto”, è tutta “etero”. Essa è innanzitutto eterotrofa, ossia trae il suo nutrimento dall’esterno, non essendo capace di autoalimentarsi. La vita di ciascuno dei suoi membri, condotta con intensità nei rispettivi e reciproci ambiti, genera spunti di riflessione, occasioni di revisione e cambiamento, offre idee ed esperienze nuove da condividere insieme trasformando la casa in quel luogo dove la ricchezza individuale viene messa a fattor comune, dove l’apporto dell’uno torna di vantaggio a tutti. Ciò che viene da fuori la sollecita, la induce a ripensarsi, a confermarsi nelle proprie convinzioni oppure a correggersi, se necessario.
La famiglia poi è anche eterotropa, nel senso che genera un movimento verso l’esterno di essa. La preoccupazione verso i figli, che poi è la stessa verso il proprio partner del rapporto, non può essere che siano bravi ragazzi ed educati in casa, l’ideale non è la completa assenza di conflitti, ma l’acquisizione di un saperci fare con gli altri che permetta di muoversi, studiare, lavorare e generare nel sociale con apertura e disponibilità.
L’aspirazione di una famiglia non è l’armonia intesa come assenza di conflitti al suo interno, bensì la pace, che contempla la possibilità del conflitto, non se ne scandalizza e si adopera per ricomporlo.
Una famiglia così non ha più paura di niente, non ritiene minaccioso l’esterno, anzi non pensa più nei termini esterno-interno, tanto da poter contemplare la possibilità di una, certo non ingenua, accoglienza. Una famiglia così vede i suoi membri singolarmente impegnati con la propria vita, i propri rapporti, i propri interessi e sa fare della varietà e della diversità un punto di forza e di arricchimento comune.
Dal lockdown avremmo potuto imparare che cosa non è la scuola. La scuola non è il luogo di una trasmissione unidirezionale del sapere, un travaso di nozioni da chi sa a chi non sa. La scuola, lo abbiamo visto bene nella didattica a distanza, sia nella sua forma riuscita sia in quella più fallimentare, è presenza, altra forma per dire che si impara e si insegna solo dentro un rapporto. L’insegnante non è colui che offre e lo studente colui che riceve, non è un meccanismo che vede una parte attiva e una passiva, non si dà infatti insegnante senza studente né studente senza insegnante. Lo scambio è reciproco e perché accada quel profitto particolare che chiamiamo apprendimento, ciascuna delle parti non deve avere obiezioni a esso e deve spendersi attivamente perché accada. Qualunque forma prenda il rapporto, sia esso dal vivo piuttosto che via digitale, non si può prescindere da questa compromissione reciproca per la quale è chiesta una disponibilità personale.
Dal lockdown avremmo potuto imparare che condivisione e solidarietà non sono facili slogan. Ricorderemo a lungo quel senso di vicinanza all’altro che per qualche momento abbiamo provato, quel desiderio di stare insieme e di condividere che ha fatto sì che in molti si trovassero a cantare alla stessa ora sui balconi di casa, quel senso di gratitudine per medici e infermieri che si stavano prendendo cura dell’umanità, quella spinta a compiere qualche gesto di solidarietà nei confronti di chi si dimostrava più bisognoso degli altri. Eppure, nella maggior parte dei casi, tutto ciò è svanito, ben presto i vicini sono tornati a infastidirci con la loro rumorosa presenza, abbiamo ripreso a lamentarci del personale sanitario così insopportabilmente fallibile e talora poco interessato ai nostri reali bisogni, gli indigenti di nuovo ci irritano con le loro richieste. È accaduto perché si trattava di puri slanci emotivi, non di giudizi. Il nostro tempo vede il primato delle emozioni, sembra che dobbiamo per forza accenderci, indignarci, commuoverci, tutto fuorché pensare. L’errore è ritenere che le emozioni siano forze e non forme. Le emozioni non sono elementi autonomi che tirano la giacca dei nostri comportamenti, ma sono le forme che assumono i nostri pensieri. Se la condivisione e la solidarietà sono generate da pure istanze emozionali, esse non tengono nel tempo, per restare e durare devono poggiare su una base più solida quale il riconoscimento dell’altro come un bene per sé.
Insomma, dal lockdown avremmo potuto imparare molto. Non è detto che l’abbiamo fatto. Ci siamo probabilmente adattati, abbiamo acquisito nuovi comportamenti, ma non sembriamo cambiati. I cambiamenti dell’uomo non accadono di scatto, ma passo a passo, hanno bisogno di quella particolare forma di meditazione della e sulla realtà che si chiama giudizio.
Prova ne è che la situazione che si è venuta a creare nel post-lockdown vede spesso più un’esasperazione dei toni che la formulazione di giudizi avveduti e volti alla ricerca di soluzioni efficaci. Il soggetto pare costretto ad assistere a una serie di brutti spettacoli che lo confondono e lo disorientano: quello della scienza con i suoi continui annunci sensazionali o catastrofici mirati, nel migliore dei casi, a garantire la visibilità di chi li pronuncia; quello della politica, che procedendo per editti e proclami dimostra spesso un utilizzo manipolatorio e pretestuoso delle informazioni, dimostrando di non avere a cuore il bene comune; quello del mondo del lavoro che ha iniziato a chiamare smartworking ciò che non è affatto smart per il semplice fatto di non tener conto delle situazioni reali delle persone nelle loro abitazioni, soprattutto delle donne.
In questo scenario il soggetto ha però una risorsa cui attingere: il suo pensiero. C’è sempre una certa impressione di aleatorietà quando si usa questa parola, il sapore di un’astrattezza che sembra rendere il concetto imprendibile e impalpabile. Eppure pensiero è concreto, in quanto pensiero del rapporto, elaborazione di una legge individuale che normi il rapporto con ogni altro incontrabile affinché si produca un profitto per entrambi, un di più che prima non esisteva.
Di fronte a una situazione di incertezza come quella attuale, il pensiero, sempre individuale sebbene dovrebbe essere ridondante precisarlo, giudica ciò che accade ed elabora soluzioni efficaci per garantire comunque la soddisfazione che non è ottenibile né a prescindere né a scapito degli altri. Oggi più che mai abbiamo bisogno di recuperare un pensiero sano.
Nel momento in cui l’altro sembra essere diventato nemico e fonte di mali, il pensiero sano lo rimette al suo posto di socio e compagno.
Nel momento in cui la tentazione è la distruzione dei rapporti per rinchiudersi in un solipsismo narcisistico, il pensiero sano coltiva lo spirito imprenditoriale, si volge a realizzare una società in cui tutti gli uomini possano trovarsi bene.
Nel momento in cui il rischio è quello di chiudersi nel proprio particolare, il pensiero sano ambisce all’universo, si rende disponibile a ogni possibile altro uomo che desideri costruire con lui.
Nel momento in cui ogni regola viene allucinata come una costrizione o una restrizione della libertà personale, il pensiero sano sa riconoscere quelle che sono solo condizioni necessarie per arrivare alla meta comune e si guarda bene dal lamentarsene e fare obiezione.
Ritornare come bambini
A guardarsi intorno, si potrebbe dire che di pensiero sano ce n’è pochino. Eppure c’è.
Possiamo ritrovarlo nel bambino. E non si tratta di una romanticheria.
L’invito a tornare come bambini non è infatti l’invito a un infantilismo di ritorno, e neppure un’esortazione verso l’ingenuità, è piuttosto tornare a esercitare quell’attività intellettuale che ha portato ciascuno di noi a saper stare al mondo con una meta, avvalendosi dei rapporti. Ossia è l’invito a pensare come pensano i bambini.
I bambini non hanno obiezione né a considerare l’altro come partner, da far fruttare al massimo per ricavare ciò che li fa stare bene, né a essere s-fruttati per diventare a loro volta fonte di soddisfazione. È evidente a tutti che un bambino gioca volentieri con un adulto solo a patto che l’adulto tragga esso stesso piacere da questa attività, in quanto la soddisfazione si inscrive sempre dentro una tale reciprocità amorevole. Viene in questo modo superata anche la logica già buona della domanda e dell’offerta, perché il bene della relazione è sempre un di più non prevedibile, né calcolabile a priori, è un accadere che porta frutti per tutti e che configura un caso inedito di s-fruttamento auspicabile e augurabile, senza prevaricazione né soprusi, con moltiplicazione di risorse anziché loro esaurimento, con arricchimento per tutti e non depauperazione.
Durante il lockdown abbiamo avuto l’occasione, forse irripetibile, di scoprire come siamo costituiti, di sperimentare quale forma dei rapporti è più soddisfacente e fruttuosa.
A ciascuno oggi il compito di riconoscere questo pensiero sano, già proprio del bambino: un pensiero che non si ferma davanti agli ostacoli, che non cessa mai di considerare l’altro nel proprio orizzonte e soprattutto che si pensa con un futuro. Dopo averlo riconosciuto arriverà poi il momento di scegliere: farsene qualcosa dell’esperienza legata al Covid-19, farne memoria e investirci per meditare un rinnovato modo di pensare sé, il rapporto e la realtà oppure considerarla solo come un ricordo da rimuovere o cui attaccarsi in modo melanconico o strumentale a seconda del momento. Ci siamo ripetuti tante volte “andrà tutto bene”, ma è stato un inganno pietoso, avremmo dovuto invece dirci “andrà tutto bene se” perché ci sono sempre delle condizioni da porre grazie alle quali il bene accada, non esistono automatismi al riguardo.
Ecco, fare tesoro e memoria di ciò che ci è accaduto rappresenta oggi il primo di una serie di passi che costituiscono questo se sulla strada di un bene possibile.