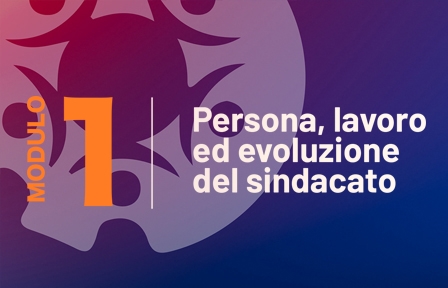I tradizionali punti di forza e debolezza del sistema industriale italiano sono destinati a rimanere tali nel quadro di una situazione globale che domanda coraggio e lungimiranza? L’agenda dei decisori pubblici in quale direzione andrà? Al centro dell’attenzione solo la gamba delle grandi imprese troppo spesso impegnate a soddisfare unicamente gli interessi dei propri azionisti? E nell’epoca del “quarto capitalismo” quale il ruolo delle piccole e medie imprese che ne rappresentano la sostanza e il possibile elemento innovativo? In generale occorre che vi sia uno scatto in avanti per soddisfare tutti i portatori di benessere.
Il PNRR
Il 22 giugno scorso la Commissione europea ha dato luce verde al programma italiano Next Generation EU, altrimenti noto con la sigla PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza1.
Le attese sono positive da parte di tutti gli ambienti, soprattutto perché la dimensione dei flussi europei in entrata nel nostro Paese è cospicua: 68,9 miliardi di euro di contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti per un totale di 191,5 miliardi di euro che rappresentano il 28% del valore complessivo del piano europeo. Si aggiunga che lo sforzo dell’intera Europa ci tornerà favorevole, dati i nostri collegamenti sociali e produttivi.
Sorgono alcuni quesiti: il nostro PNRR sarà capace di dare finalmente una grande spinta alla crescita italiana, ancora indebolita dalle ultime grandi crisi? Saranno favoriti i più adatti a fornire questa spinta? Ed essa sarà adeguata a ridurre le disparità di reddito e di ricchezza nella nostra società?
A mio parere occorre innanzitutto liberare il campo da un equivoco definitorio. Alcuni hanno espresso il timore che l’approccio del Presidente del consiglio sia troppo basato sul liberismo e quindi sul mercato. Ebbene, qui si tratta di spesa pubblica e di spinte all’economia governate da istituzioni centrali e locali. Non c’è dubbio che si tratti di statalismo, con buona pace dei liberisti più o meno convinti.
Gli oggetti delle politiche sono stati fissati da tempo dall’Europa: transizione verde, rivoluzione digitale e riforme che mirano, variamente, a sostenere i servizi essenziali (sanità, giustizia, educazione) e quelli della pubblica amministrazione, promozione di politiche attive del lavoro e molte altre cose tutte desiderabili come l’immancabile lotta alla burocrazia. Il solo sommario del Piano è costituito da 266 pagine nelle quali si elencano progetti e istituzioni. Non serve poi così tanto leggerle (i singoli paragrafi sono dichiarazioni di intenti) quanto attendere che i risultati siano effettivamente raggiunti e, soprattutto, valutare la distanza tra i nostri risultati e quelli degli altri Paesi; ovviamente, contando che il governo ci indichi chiaramente le cause dei divari. Con l’augurio, inoltre, che in Italia ci si parli in italiano, senza cercare continuamente i termini inglesi: ad esempio, key technologies si può tradurre modestamente in tecnologie chiave, ma ci si può sforzare anche in altre casistiche. Singolare la citazione a p. 192 che, per i non addetti ai lavori, sembrerà un capolavoro di incapacità comunicativa: “La struttura dei centri dovrà essere del tipo ‘hub and spoke’… il coinvolgimento degli spoke e delle imprese private avverrà attraverso accordi specifici…”.
Il Piano sembra superare i dualismi e sostiene Centro Nord e Mezzogiorno da un lato e imprese grandi e piccole dall’altro.
Nelle tematiche sulla ricerca ritorna, forse pericolosamente, il termine “campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies” il che significa, senza mezzi termini, aiuti alle grandi imprese. Le principali sono a controllo statale; per quelle a controllo privato bisognerà prestare molta attenzione, visto che in maggioranza sono ormai a controllo estero.
Si prevede anche la “costruzione di leader territoriali di R&S” che potrebbe interessare più da vicino le piccole e medie imprese del Quarto capitalismo: “luoghi di contaminazione e collaborazione tra Università, centri di ricerca, società e istituzioni locali che hanno finalità di formazione di alto livello, innovazione e ricerca applicata definite sulla base delle vocazioni territoriali” (p. 192). A dire il vero sarebbe proprio quello che serve alle nostre medie imprese (similmente a quanto avviene da tempo in Germania per il Mittelstand) se non vi fosse, forse, una sottovalutazione del contesto. Si prevede infatti di finanziare 12 (dodici) “campioni territoriali di R&S (esistenti o nuovi)” (p. 193): mi sovviene la battuta di Enrico Cuccia pipi de papillon…
Imprese grandi e imprese minori
Difficile dire se saranno avvantaggiate le grandi imprese oppure il Quarto capitalismo. Il nostro PNRR è il risultato di numerose stesure, presumibilmente aggiustate ripetutamente qua e là in base alle istanze delle varie lobby. I fondi alle grandi imprese affluiranno soprattutto attraverso le tematiche della ricerca. Ciò può essere corretto, ma occorre vigilare attentamente su soggetti che hanno trascurato a lungo le innovazioni; con i loro azionisti che hanno prelevato risorse indipendentemente dagli esiti di gestioni spesso problematiche.
Questo riguarda gli avidi e opportunisti soci privati, come pure il petulante azionista pubblico sempre a caccia di dividendi e incapace di garantire la gestione efficiente delle imprese sulle quali esercita un controllo forse da ridisegnare.
Vi sarà uno stillicidio di contributi a piè di lista a beneficio di grandi imprese e delle loro controllate e collegate? Con quale garanzia di risultato? Perché non riesumare la famosa massima di Cesare Beccaria? “Premiare l’opera già fatta sarà la massima la più salutare ed il mezzo più efficace per promuovere le manifatture. Il premio è di un solo, ma l’emulazione è di molti: la speranza, che è uno dei più grandi agenti dell’uomo socievole, mette in fermento l’interesse privato di ciascheduno”2. Sarebbe un incentivo fortissimo a raggiungere lo scopo e, in ogni caso, anche i non classificati trarrebbero vantaggio dai frutti degli investimenti fatti.
Le strutture patrimoniali appaiono fortemente indebolite dalla preferenza attribuita ai debiti finanziari in presenza di un costo del denaro irrisorio. La stessa capacità del nostro sistema bancario di valutare il merito di credito dei clienti pare insufficiente. Il sistema è ormai collassato su due o tre protagonisti principali a seguito di un’assurda politica della Banca d’Italia che ci ha portato ad avere grandi banche apparentemente private, ma di fatto pubbliche per via della regola del “troppo grande per fallire” (too big to fail).
Si ripresentano quindi nella nostra struttura economica le due tare del secolo scorso: l’eccesso del debito e l’eccesso del rischio (che, beninteso, si dichiara di poter agevolmente controllare attraverso improbabili formule matematiche).
La stessa politica ha portato a eliminare la maggior parte delle banche adeguate alla nostra struttura produttiva fatta di PMI (le popolari soprattutto). Mi sento di proporre una politica inversa: cominciamo a smontare le banche troppo grandi. Ridurremmo i rischi per la finanza pubblica e riporteremmo coloro che dispongono dei nostri cospicui risparmi a indirizzarli verso le imprese più meritevoli.
Gli impieghi delle grandi imprese, in particolare, sono oggi dominati dai cosiddetti attivi immateriali, costituiti non dagli oneri delle ricerche per le innovazioni, ma dai differenziali negativi di consolidamento di consociate consolidate, evidentemente valutate con troppa disinvoltura al momento della loro acquisizione. Assumendo come riferimento i dati delle imprese operative italiane censite da Mediobanca, gli attivi intangibili rappresentavano nel 2018 il 48% del capitale delle aziende a controllo estero e il 36% di quello dei maggiori gruppi privati a controllo italiano. Di contro, la posta valeva solo il 15% nei gruppi a controllo pubblico e appena l’8% nelle imprese del Quarto capitalismo. Il patrimonio netto nel suo complesso, depurato di tali poste, veri buchi aventi contenuto finanziario nullo, risultava pari al 61% del capitale investito nelle imprese del Quarto capitalismo (il restante 39% essendo coperto da debiti finanziari), le quali pertanto erano le più patrimonializzate, del 44% nei gruppi a controllo pubblico (56% debiti finanziari) e intorno al 40% (60% debiti finanziari) nei gruppi a controllo privato italiano ed estero3.
La situazione appare più grave se, oltre alle imprese operative, si considerano i bilanci consolidati dei gruppi societari. Qui è possibile valutare i dati dei maggiori raggruppamenti che interessano il nostro Paese alla fine dell’esercizio 2019: i gruppi pubblici apparivano meno brillanti esibendo incidenze del patrimonio netto tangibile pari al 18% per l’Enel, il maggiore, al 66% per la ST e al 60% per l’Eni. Per quattro grandi gruppi vi era addirittura un deficit di patrimonio con debiti finanziari al 131% per TIM (115% a media e lunga scadenza), al 119% per Pirelli (87% a m/l), al 112% per Essilor-Luxottica (71% a m/l), al 103,5% per l’esercizio 2018 dell’Edizione/Benetton (95% a m/l), all’85% per Exor/Agnelli (55% a m/l). L’universo delle medie imprese rilevato da Mediobanca e Unioncamere presentava invece nei dati complessivi a livello di gruppo una quota patrimoniale tangibile pari al 63,5% e un indebitamento finanziario del 36,5% (16,6% a m/l)4.
Questi dati mostrano assai chiaramente le forze e le debolezze del settore industriale italiano che rappresenta quello a maggiore capacità propulsiva dello sviluppo economico a motivo della sua più elevata produttività.
I territori
Sotto l’aspetto geografico, l’area che produce la maggiore quota di valore aggiunto manifatturiero è il NEC (Nord Est Centro) che raggruppa il Triveneto, l’Emilia-Romagna, la Toscana, l’Umbria e le Marche: 44,6% del totale nel 2018 (ultimo dato reso disponibile dall’Istat nel dicembre 2020). Segue il Nord Ovest con il 39,4% (il vecchio triangolo industriale con Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria) e il Mezzogiorno che con il Lazio raggiunge il 16% appena.
Il NEC è storicamente l’area di elezione del Quarto capitalismo, dove le imprese sono nate nei distretti subentrando ai vuoti lasciati man mano dalle grandi imprese fordiste in crisi. Si tratta di aree ad elevata vocazione imprenditoriale.
Nel 2019 (ultimi dati Istat) si può stimare che esse comprendessero 319mila imprese manifatturiere attive (l’86% del totale) che contavano 2,6 milioni di addetti; le “grandi” occupavano 1,1 milioni di persone, ma tale dato deve intendersi sopravalutato perché le rilevazioni dell’Istat seguono la norma europea che definisce grandi le imprese con più di 250 addetti. Se si considera il limite più comune nella prassi statistica internazionale (pari a 500 addetti), in realtà la consistenza apparente delle “grandi” italiane andrebbe attribuita alle imprese medio-grandi che sono parte anch’esse del Quarto capitalismo.
Occorre dunque riservare la massima considerazione al Quarto capitalismo che è fatto di imprese “minori”; piccole e medie, ma dove la media dimensione sottintende imprese aventi funzioni di integratori di sistemi locali.
Molti, studiosi e politici, sono ancora fermi alla preferenza per le grandi dimensioni le quali, si dice, sono le sole capaci di sfruttare grandi economie di scala riducendo pertanto i costi di produzione. Questo era vero ai tempi di Henry Ford, quando le fabbriche costituivano grandi e informi assembramenti umani con lavoratori trattati alla stregua di robot: si doveva produrre sempre di più e nel minor tempo possibile beni di massa sino a saturare i mercati e le abitazioni delle famiglie con merci assolutamente anonime.
Oggi le imprese usano i robot applicando di norma procedure automatizzate e la scala produttiva non costituisce più il problema principale.
La rivoluzione tecnologica 4.0 consente la produzione di lotti meno numerosi di merci sempre più personalizzate sulle esigenze del cliente. Per un Paese come il nostro, dove gli imprenditori hanno un DNA artigiano, questa è un’occasione molto interessante di assumere posizioni di leadership in molti comparti.
Ovviamente, si tratta di introdurre la digitalizzazione in misura molto più massiccia, ma non si tratta di una novità e i costi si sono assai ridotti. La digitalizzazione è entrata nelle nostre imprese negli anni Ottanta del secolo scorso, ai tempi della prima ristrutturazione industriale che ha rimediato al declino del vecchio fordismo.

Imprese flessibili, produzioni personalizzate adatte per mercati sempre più variabili. Oggi la produttività si gioca a livello di filiera e di rete dove manifattura e servizi si mescolano sotto la guida di un “integratore” che organizza le economie di scala esterne alle imprese, ma interne alla filiera. Questo integratore potrebbe essere anche una grande impresa, ma non del tipo di quella che ha lasciato inutilizzate preziose risorse di lavoro e capitale nei nostri territori. E nemmeno del tipo GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) che salgono verso dimensioni enormi solo perché monopolizzano i mercati di sbocco e vincolano le imprese che producono realmente i beni.
Ben venga allora la lotta alla concorrenza che si cita nel nostro PNRR. Da cancellare invece la battuta sulla genesi del carente andamento della produttività nel recente passato: “dovuto… sia alla struttura del tessuto produttivo, caratterizzato da una prevalenza di piccole e medie imprese, che sono state spesso lente nell’adottare nuove tecnologie e muoversi verso produzioni a più alto valore aggiunto” (p. 2). Una tale visione dimostra ignoranza profonda dei ruoli, delle funzioni e degli investimenti realizzati dalle imprese del Quarto capitalismo. Le quali sono “responsabili” del cospicuo saldo attivo della nostra bilancia commerciale (export - import): avanzi realizzati ormai da molti anni nonostante le rilevanti importazioni delle grandi imprese. Avanzi che consentono di pagare l’import di energia e di prodotti agricoli e hanno costituito praticamente l’elemento di grande stabilità di un sistema che altrimenti sarebbe collassato sotto il peso dei debiti pubblici e delle politiche scellerate dell’emigrazione e delle delocalizzazioni perseguite dai più importanti imprenditori privati.
Nel 2020, anno problematico, la nostra manifattura ha realizzato un saldo commerciale positivo pari a 97 miliardi di euro, realizzati interamente dalle merci prodotte dalle imprese distrettuali e del Quarto capitalismo.
Nel 2019 non era andata diversamente con un saldo positivo di 108 miliardi (sbilancio di 5 miliardi per le merci delle grandi imprese e surplus di 113 miliardi per quelle delle “imprese minori”). Questa è resilienza! Ovvero la capacità di mantenere e riassumere la propria forma dopo i colpi delle grandi crisi. Quale altra dimostrazione di capacità innovativa e di produttività a valore si vuol cercare se non si capisce ancora il perché e grazie a chi si prevalga sui mercati esteri?
Ci manca la gamba delle grandi imprese. Nella speranza in un nuovo periodo di crescita di tutta la società italiana si deve mettere mano a una nuova governance delle grandi società anonime, ora intrappolate nella ricerca della massimizzazione del valore per gli azionisti.
Occorre fare in modo che esse perseguano il benessere di tutti i portatori di interessi: lavoratori, clienti, fornitori, pubbliche amministrazioni, prima ancora degli azionisti i quali debbono correttamente vincolare la gestione a criteri di efficienza produttiva ed economica.
Per gli amanti delle pratiche anglosassoni, si tratta di trasformare l’attuale shareholders capitalism in stakeholders capitalism, partendo dalla riforma del Codice per le società quotate in Borsa:
“Dove va la fabbrica in questo mondo? […] Come possiamo contribuire col nostro sforzo e col nostro lavoro a costruire quel mondo migliore? […] Ardua è la mia risposta e arduo il cammino per una nuova meta […] Cosa faremo? Tutto si riassume in un solo pensiero, in un solo insegnamento: saremo condotti da valori spirituali. Questi sono valori eterni, seguendo questi i beni materiali sorgeranno da sé senza che noi li ricerchiamo”. Adriano Olivetti5.
NOTE
1 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
2 F. e G. Coltorti, Cesare Beccaria; Luiss University Press, Roma 2007, p. 76.
3 F. Coltorti, Debiti, colpe e vergogne ai tempi del Covid-19, in Nuova Antologia, aprile-giugno 2020, p. 43.
4 Mebiobanca e Unioncamere, Le medie imprese industriali italiane (2009-2018), marzo 2021, www.areastudimediobanca.it, pp. L-LI.
5 A. Olivetti, Il mondo che nasce, a cura di Alberto Saibene; Edizioni di Comunità, Roma/Ivrea 2013, pp. 36-37.