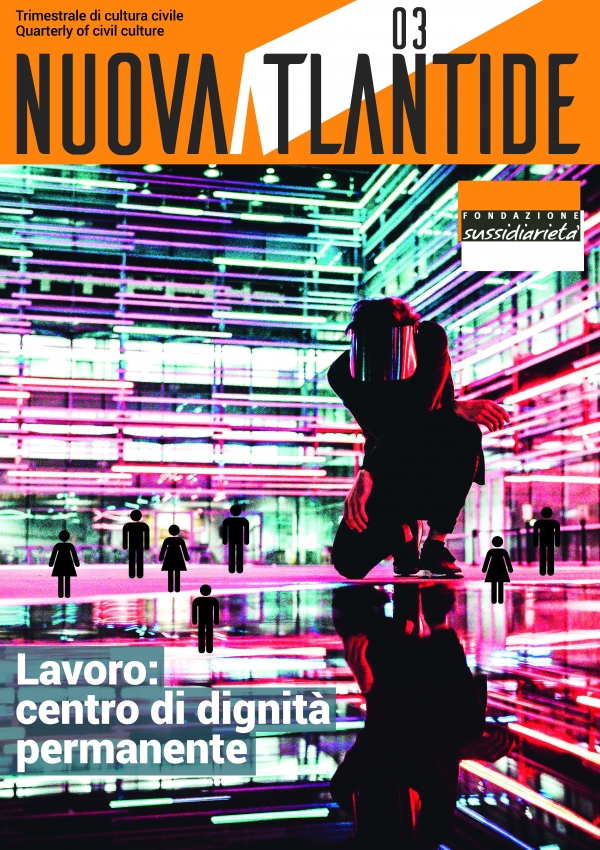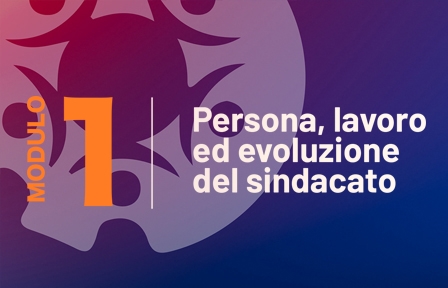La pandemia ha acceso i riflettori sulle enormi zavorre che impediscono al Paese di imboccare la strada della crescita equa e sostenibile. Occorre cooperare per avviare un nuovo modello sistemico. Superando la logica del conflitto per affermare la novità del metodo della partecipazione. Fra tutti gli interpreti. Infatti, le ferite si possono sanare solo “in positivo”. Questo è il tempo di costruire una rivoluzione buona che torni a porre al centro della persona. Il contributo del segretario generale della Cisl.
Insieme alle drammatiche conseguenze dal punto di vista dell’emergenza sanitaria e delle vittime che purtroppo ha mietuto, alle pesantissime ricadute che ha avuto sul piano economico e sociale, la pandemia ha avuto anche un effetto “rivelatore”, sotto molti punti di vista.
Ha messo a nudo, prima di ogni cosa, le nostre fragilità. Ha mostrato quanto possa diventare grande il vuoto della solitudine e come sia delicata la trama delle nostre relazioni, del nostro tessuto sociale.
Al tempo stesso, ed è il rovescio della medaglia, ci ha fatto capire meglio quanto siamo tutti legati e interdipendenti. Quanto sia prezioso – e quanto la nostra quotidianità ne dipenda – il lavoro degli altri. Dei medici e degli infermieri che ci hanno curato, rischiando in prima persona. Degli insegnanti che in presenza o a distanza hanno continuato a seguire i nostri figli. Di chi lavorando nei campi, nei trasporti, nella logistica, nella distribuzione, ha assicurato beni e servizi indispensabili.
Un’altra cosa, poi, ha fatto la pandemia. Ha acceso un gigantesco riflettore sulle tante, troppe tare antiche del nostro Paese. Sulle enormi zavorre che da decenni ci impediscono di imboccare la strada di una crescita equa e sostenibile. Ma anche qui c’è un rovescio della medaglia. La crisi obbliga a partire proprio da questi nodi strutturali. Sta imponendo un’agenda di interventi che possano scioglierli.
Autonomia, pragmatismo, corresponsabilità
Uno dei terreni fondamentali su cui siamo chiamati ad agire è rappresentato dal fatto che questo lungo e durissimo anno ha accelerato i processi di disgregazione e di polarizzazione nel lavoro, così come ha evidenziato tutti i limiti e i ritardi di quelle imprese che hanno investito poco in capitale umano, puntando sulla svalutazione del lavoro. Un’impostazione che, già prima della tempesta sanitaria, ci ha portato vicino al baratro, con centinaia di crisi aziendali, migliaia di delocalizzazioni, marginalità tecnologica, realtà produttive incapaci di esprimere sufficiente resilienza, innovazione, competitività.
Come a dire che, con tutta evidenza, dalla crisi non si potrà uscire semplicemente tornando indietro, a un passato segnato dalle diverse storture che negli ultimi vent’anni hanno portato a crisi sempre più drammatiche. Significherebbe aver sprecato la più grande opportunità di riforma e di riassetto di sistema che in questo momento abbiamo di fronte a noi, con gli investimenti e le riforme da mettere in campo attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Investimenti e riforme che dovranno dare sostanza a un modello nuovo del sistema complessivo di crescita, a una Rerum Novarum dell’economia nazionale ed europea.
Si tratta allora di partire dalla consapevolezza diffusa che le ferite aperte dalla pandemia sono sanabili solo “in positivo”, solo attraverso un metodo nuovo e basato su una più forte unione d’intenti in ogni luogo di lavoro, in ogni territorio, in ogni nazione e all’interno della stessa comunità internazionale.
Certo, una coscienza condivisa è fondamentale, ma non è sufficiente. Servono azioni concrete per impostare nuovi equilibri tra capitale e lavoro, tra decisori pubblici e corpi intermedi. Per avviare un percorso che porti a relazioni nuove, non fondate sull’antagonismo secco e ideologico, ma su valori di autonomia, pragmatismo, corresponsabilità. Un’analisi lucida del presente non può che muovere dai difetti e dai “vuoti” di un sistema di crescita disequilibrato, ancora poco legato all’economia reale, incapace di tenere insieme solidarietà e produttività, nuova occupazione di qualità e valore aggiunto, diritti dei lavoratori, innovazione, ricerca e crescita economica, radicamento delle aziende sui territori.
È questo lo scenario che va cambiato. Abbiamo l’opportunità di farlo, appunto, grazie all’apporto strategico e irripetibile del Recovery Plan e di un pacchetto di altri strumenti nazionali ed europei che vanno dal React-EU al Piano Sure, fino a una flessibilità sul Patto di stabilità che va confermata anche nei prossimi anni.
Un welfare europeo
È fondamentale, infatti, che a questo proposito l’Europa continui a parlare il linguaggio della solidarietà e della condivisione, dopo una lunga “stagione fredda” dominata da un’austerità assoluta e da un rigore a tutti i costi, che hanno allontanato le sue istituzioni dai problemi reali delle persone, alimentando peraltro pericolose e divisive spinte sovraniste e nazionaliste. Questo allora è il momento, per l’Europa, di procedere verso una vera integrazione politica e sociale, con strategie di crescita e coesione condivise, con una visione economica ed estera comuni, con un vero welfare europeo che infonda anima a una comunità dei popoli e del lavoro.
Ed è il momento, per il nostro Paese, di agire rilanciando il protagonismo e il valore sociale del lavoro pubblico e privato, spezzando le catene delle disuguaglianze sociali, geografiche e di genere, costruendo nuove regole che valorizzino il ruolo generativo dei corpi intermedi, a partire dalla famiglia.
Il centro di questa “rivoluzione buona” deve essere la persona, con il suo protagonismo, la sua creatività, la sua capacità e volontà di partecipare attivamente allo sviluppo, anche spirituale, delle comunità.
Riconoscere nella centralità della persona l’impulso fondamentale dell’azione pubblica vuol dire, ovviamente, ritrovarsi nel profondo della dottrina sociale e del grande insegnamento indicato dal magistero di Papa Francesco. Vuol dire sostituire il principio del conflitto con quello della partecipazione, secondo cui tutti i componenti di una comunità, nessuno escluso, sono impegnati a collaborare per il bene comune, assumendosi una parte delle responsabilità nel processo di cambiamento.
Un principio che, elevato a metodo politico, diventa concertazione. Questo dobbiamo fare. Concertare il cambiamento. Animare insieme il cantiere delle riforme verso obiettivi strategici condivisi. Con lo spirito che accomunò i Padri Costituenti, quando si trattò di rimuovere le macerie materiali e spirituali lasciate dalla dittatura e dalla guerra e di ricostruire il Paese. Come abbiamo saputo fare nei momenti più difficili della nostra vicenda repubblicana, durante gli anni bui del terrorismo e anche nell’ultimo decennio del secolo scorso, con le scelte concertate che rilanciarono occupazione e crescita tirandoci fuori dalle secche di una crisi strutturale devastante.
In fondo è seguendo questo solco storico che nei mesi scorsi si sono raggiunti risultati preziosi, a cominciare dal Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale firmato il 10 marzo 2021, per proseguire con il rinnovo del 6 aprile 2021 dei Protocolli sulla salute e la sicurezza e all’intesa sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, per arrivare al Patto sulla scuola del 20 maggio 2021. Ed anche l’inciampo grave del “Sostegni bis” e dello strappo sui licenziamenti, e il successivo accordo del 29 giugno 2021, finisce per confermare che l’unico modo per raggiungere risultati positivi e concreti è seguire la via maestra del dialogo sociale. Quella da mantenere anche nella decisiva fase della “messa a terra” del PNRR, praticando un metodo autenticamente partecipativo.
Un’economia sociale e di benessere
Parlando, peraltro, di “solco storico” e di dialogo, non può non tornare alla mente l’alta e attualissima lezione di un intellettuale come Ezio Tarantelli, di un uomo che resta esempio e simbolo di come l’etica (e la pratica) della partecipazione sia l’unica in grado di portar fuori dalle crisi e di procedere concretamente verso un’economia sociale e del benessere. Cruciale, per Tarantelli, era il passaggio da un sistema conflittuale a un modello incentrato su quello che lui chiamava “scambio politico”, vale a dire la possibilità che attraverso un’azione coordinata tra governo, sindacato e imprenditori si possano non solo governare ma determinare – questo il termine da sottolineare – le dinamiche della politica economica, a partire da sviluppo e occupazione.
Ecco, se c’è uno scambio politico di cui oggi il nostro Paese ha bisogno, è quello in cui al sindacato e all’impresa spetta il compito di estendere la partecipazione, di rinnovare gli ecosistemi lavorativi secondo le regole dell’economia 4.0, di regolare una buona flessibilità negoziata, di rilanciare salari, produttività e formazione costruendo nuove tutele contrattuali e bilaterali per difendere i livelli occupazionali.
Allo Stato, invece, il compito di sbloccare gli investimenti per realizzare le infrastrutture materiali e sociali necessarie a spezzare le diseconomie nelle aree deboli del Paese, e quelli di potenziare i contratti di solidarietà espansivi e difensivi, di rendere universali gli ammortizzatori e collegarli a solide reti di politica attiva. E poi di stimolare innovazione e ricerca, varando un grande piano sulle competenze digitali, sulla formazione e la riqualificazione, sulla promozione. E ancora, il compito di promuovere politiche industriali che rilancino i nostri asset strategici e diano forza alle piccole e medie imprese. Così come di assicurare da Sud a Nord un adeguato livello di servizi pubblici e diritti di cittadinanza, di contrastare povertà e marginalità sociale, di sostenere la non autosufficienza, di promuovere un patto tra generazioni redistribuendo la pressione fiscale a sostegno delle fasce medio-popolari.
È su tutto questo ampio e sicuramente impegnativo fronte progettuale che dovrà essere incentrata la strategia espansiva del governo, che invece dovrà lasciar fuori dal suo ambito di iniziativa quei temi che sono propri delle relazioni industriali e della libera e autonoma contrattazione. Orari, salari, rappresentanza, causali, organizzazione del lavoro, smart working: su queste materie non serve, è bene anzi non ci sia, una supplenza dello Stato.
Dopo di che, certo, se il sindacato non vuole prestare il fianco a ingerenze su ambiti che gli sono propri, deve accettare la sfida sempre aperta del cambiamento e fare fino in fondo la sua parte, impegnandosi ad avvicinare ancor di più la contrattazione alla persona e al territorio, a realizzare accordi nazionali e di secondo livello che innovino l’organizzazione del lavoro, che introducano nuove flessibilità, che spingano sulla partecipazione organizzativa e su un welfare negoziato sempre più esteso, mutualistico e di qualità.
Contrastare l’isolamento delle persone
Nostro dovere conoscere e presidiare i “nuovi mondi” del lavoro digitale, con un occhio di riguardo verso le realtà più fragili ed esposte, sapendo riconoscere le opportunità e contrastando i pericoli connessi al rischio più grave: l’isolamento delle persone. A questo deve servire la capacità di aggiornare gli strumenti della nostra rappresentanza. A trasformare in una comunità di lavoratori consapevole, coesa, proattiva e organizzata una moltitudine che altrimenti rischierebbe di essere solo una “folla” indistinta, senza coscienza di sé e di propri diritti.
Mentre invece c’è, esiste, l’antidoto al declino del lavoro e alla solitudine di massa. Si chiama contrattazione. Si chiama partecipazione.
Una partecipazione che va costruita dal basso e che al tempo stesso va promossa con una legge quadro che dia solidi affidamenti alle relazioni industriali nella implementazione delle sue varie forme. Ecco allora, ad esempio, l’importanza di potenziare e valorizzare la rappresentanza dei lavoratori nelle imprese multinazionali, a partire da un ruolo non meramente informativo dei Comitati aziendali europei e dal rafforzamento della presenza del sindacato nei consessi europei a tutti i livelli.
Sono convinto, per andare al cuore dell’idea stessa di partecipazione, che i tempi siano maturi per una svolta sul coinvolgimento dei lavoratori alla vita finanziaria e alla governance d’impresa, come previsto dall’articolo 46 della Costituzione.
Si possono sviluppare esperienze partecipative attraverso il workers buyout, si può rilanciare la partecipazione finanziaria e costituire organi di rappresentanza nelle assemblee per i lavoratori, riservare parte dei fondi pubblici destinati alla ricapitalizzazione delle imprese per il sostegno a strumenti partecipativi, procedere con la definizione di norme per il coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese a livello sia di gestione sia di organizzazione.
Davvero, è la partecipazione la più grande riforma istituzionale da portare a termine per procedere verso la piena realizzazione, in Italia e in Europa, di quella che Dossetti chiamava “democrazia sostanziale”. Una democrazia in cui la società è responsabilizzata e partecipe a livelli sempre più profondi nei processi economici di controllo e decisione.
È anche su questi nuclei concettuali che il nostro Paese e le principali democrazie liberali dovranno confrontarsi nei prossimi anni. Sapendo che ci troviamo a un vero e proprio snodo della Storia, che stiamo affrontando un tornante in cui la “costruzione del nuovo” non è più una opzione, ma un obbligo.
Una sfida positiva al governo
Le istituzioni, il mondo del lavoro e le rappresentanze datoriali hanno la responsabilità di non mancare l’appuntamento, di assumere impegni comuni e coerenti verso un nuovo accordo di sistema, che faccia recuperare il tempo perso in vent’anni di sterile conflitto e vani tentativi di disintermediazione. Si tratta ora di promuovere la pacificazione e la coesione della nostra società. Di ricostruirla attorno a principi di equità e di legalità. Di rimuovere le disuguaglianze, non solo tra poveri e ricchi, ma tra uomini e donne, tra cittadini titolari di diritti pieni ed effettivi e immigrati che non possono goderne, tra giovani e anziani, accompagnando le nuove generazioni verso i lavori che ancora non esistono e convertendo i meno giovani verso i lavori che stanno nascendo.
Su tutto questo il sindacato vuole lanciare una sfida positiva al governo e ai suoi interlocutori sociali, affinché si converga tutti all’interno di un perimetro di comune impegno e ognuno contribuisca all’obiettivo di realizzare un Paese solidale, produttivo, in cui coesistano piena e buona occupazione, capacità di adattamento, produttività e innovazione. Per costruire un’Italia finalmente unita, fondata sul protagonismo del lavoro, delle imprese, dei corpi intermedi, nella ricerca del bene comune.