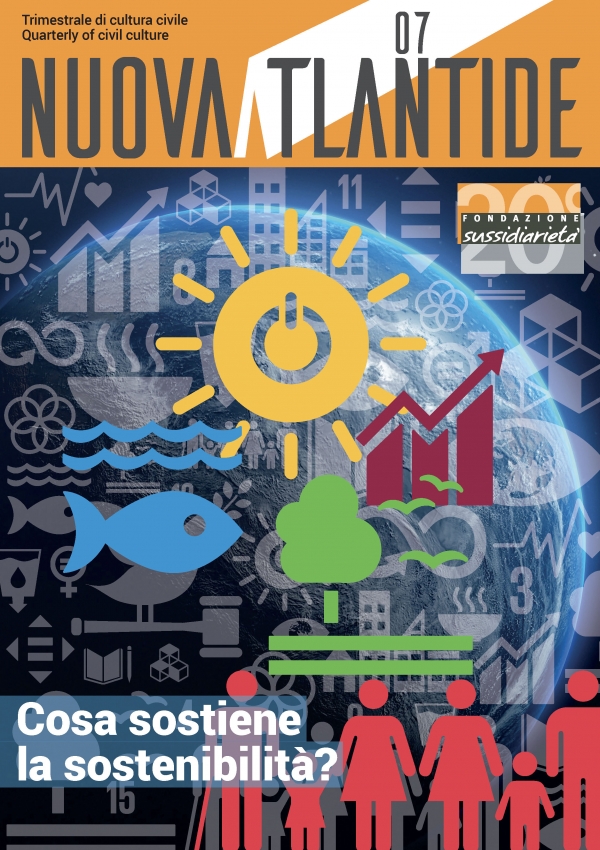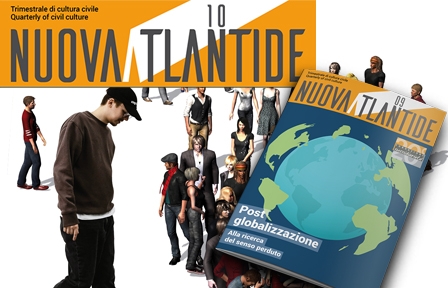Nel corso degli anni sono arrivate le riflessioni preoccupate del mondo scientifico a proposito delle criticità nell’habitat naturale. A cui la politica ha finora risposto in maniera insufficiente. Il che ha portato a un aggravio globale che ha prodotto un disequilibrio nella vita umana del pianeta. Nel frattempo, i rischi aumentano e le risorse naturali vengono progressivamente a mancare. Minacce assai concrete che impattano anche sull’economia e sulla società. Salvare il pianeta e come salvarlo è il passaggio fondamentale di questo presente ad alta complessità. Urge ripartire dal principio di responsabilità. Altrimenti sarà irrealistico parlare di sviluppo umano integrale.
Il paradigma dello sviluppo sostenibile, presentato per la prima volta nell’ambito del Summit mondiale delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro (1992), e poi riproposto nel Summit successivo di Johannesburg (2002), si fonda su un equilibrio armonico delle tre dimensioni che caratterizzano la vita umana sul nostro pianeta: l’ambiente naturale, l’economia e la società.
Le criticità dell’ambiente naturale
I problemi relativi al primo di questi “pilastri” della sostenibilità erano emersi già tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Settanta, quando venne pubblicato dal Club di Roma lo studio del MIT noto come I limiti dello sviluppo1. Pochi anni prima era uscito il libro La primavera silenziosa2 della biologa americana Rachel Carson che presentava il drammatico impatto di alcune sostanze inquinanti sugli habitat naturali, mentre era ancora vivo il ricordo del terribile Big Smoke che aveva causato nella sola Londra oltre 5000 vittime a seguito di un episodio di elevato inquinamento atmosferico durante una settimana di avverse condizioni meteorologiche. Una serie di pesanti impatti sulla salute umana e sugli ecosistemi forestali europei nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso aveva destato un crescente allarme nella comunità internazionale, culminato nella Convenzione di Ginevra del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero. Negli anni Ottanta emergeva un altro grave pericolo per l’intero pianeta, rappresentato dal cosiddetto “buco dell’ozono” cioè dalla drastica diminuzione, a opera di una serie di composti chimici prodotti da attività industriali, di quello strato di ozono della stratosfera che ci protegge dalle radiazioni ultraviolette. In quello stesso decennio la comunità scientifica cominciava a lanciare l’allarme del cambiamento del clima causato dalle crescenti emissioni di gas a effetto serra prodotte soprattutto dall’uso di combustibili fossili.
La comunità politica internazionale cominciava così a farsi sempre più attenta al tema ambientale e, nel giro di pochi anni, dopo la pubblicazione del cosiddetto rapporto Brundtland (1987)3, veniva prima stipulato nel 1989 il Protocollo di Montreal per la messa al bando dei composti responsabili della distruzione dell’ozono stratosferico e poi, nel 1992, venivano approvate le due grandi convenzioni dell’ONU sul contrasto al cambiamento climatico e sulla protezione della biodiversità seguite, nel 1994, dalla convenzione sulla desertificazione. Nei vent’anni trascorsi dal Rapporto del Club di Roma all’avvio delle grandi convenzioni internazionali a protezione dell’ambiente venivano così poste all’attenzione del mondo intero tutte le maggiori minacce verso la sostenibilità dell’ambiente naturale terrestre.
Le tre grandi minacce contro la sostenibilità dell’ambiente naturale
1. Il rischio dell’esaurimento delle risorse naturali
Le risorse naturalmente presenti sulla Terra possono essere esauribili, come le risorse minerarie o i combustibili fossili quali carbone, petrolio e gas naturale, o invece costituire riserve rinnovabili, che cioè si (ri)formano continuamente attraverso processi fisici o chimici alimentati dall’energia solare (quale la biomassa e, in particolare, le specie vegetali e animali indispensabili, tra l’altro, all’alimentazione umana).
Le prime sono per loro natura limitate e fu merito dello studio del Club di Roma sui limiti dello sviluppo l’averci ricordato che alcune delle più importanti di esse – come il petrolio o il gas naturale – sono destinate a esaurirsi entro due o tre generazioni. L’importanza di abbandonare l’impiego dei combustibili fossili, al di là delle necessità di limitare le emissioni dei gas che alterano il clima, si fonda proprio sulla considerazione che non possiamo permetterci di esaurire risorse preziose non solo a fini energetici, ma anche alla produzione di composti chimici, di farmaci o di prodotti industriali come le plastiche.
La recente guerra in Ucraina ha fatto altresì emergere anche la vulnerabilità di queste risorse da un punto di vista geopolitico. Ciò vale non solo per petrolio e gas, ma anche per le cosiddette terre rare, cioè minerali che si trovano nella crosta terrestre in minime quantità, ma che sono estremamente preziosi per le tecnologie elettroniche e informatiche. Gli stessi shock di natura economico-finanziaria legati al prezzo di queste risorse evidenzia la loro inaffidabilità, perché soggette a fluttuazioni di mercato e a speculazioni incontrollabili che possono provocare danni fatali alle economie più deboli o anche generare crisi economiche globali.
Le risorse naturali rinnovabili sono d’altra parte soggette ad altri fattori limitanti. Esse, infatti, possono venir utilizzate solo a un tasso di prelievo non superiore a quello della loro formazione: ovvero la quantità di risorse prelevabili dai sistemi naturali non deve essere maggiore della quantità che si forma attraverso i processi naturali alimentati dall’apporto energetico del sole.
Tra queste risorse ci sono i prodotti alimentari vegetali e zootecnici, i prodotti della pesca, la biomassa legnosa utilizzabile per la produzione di manufatti o per fini energetici. In altre parole, noi dobbiamo mantenere inalterato l’ammontare del cosiddetto capitale naturale e dei servizi ecosistemici che esso può fornirci e, per rendere tutto ciò possibile, dobbiamo anche garantire la stabilità dei livelli di biodiversità, ovvero di ricchezza e varietà genetica delle specie vegetali e animali.
2. La spada di Damocle dell’inquinamento
Negli ultimi due secoli (in pratica dall’inizio della rivoluzione industriale) gli esseri umani stanno rilasciando nell’ambiente antropico e naturale, grandi quantità di sostanze tossiche – solide, liquide e gassose – che inquinano l’atmosfera, le acque superficiali e sotterranee e i suoli agricoli e naturali. Processi industriali, centrali termoelettriche, riscaldamento degli edifici e motori termici degli autoveicoli immettono ogni anno nell’atmosfera o depositano sulle acque e sui suoli milioni di tonnellate di ossidi di zolfo e azoto, di polveri fini, di metalli pesanti, di idrocarburi e altri composti organici che compromettono seriamente la qualità dell’ambiente in cui viviamo.
L’inquinamento dell’aria provoca annualmente la morte prematura di centinaia di migliaia di persone, l’aggravamento di patologie cardio-respiratorie, l’insorgenza di tumori, l’incremento di ricoveri ospedalieri, dell’uso di farmaci e di giornate di lavoro perse, che viene valutato in centinaia di miliardi di dollari e che si ripercuote in misura sensibile sul prodotto interno lordo di tutti i Paesi.
L’inquinamento delle acque compromette non solo le acque superficiali dei fiumi, dei laghi e degli oceani, distruggendo gli ecosistemi acquatici, compromettendo il turismo e la balneazione e, soprattutto, impoverendo le risorse ittiche indispensabili per la nutrizione di gran parte della popolazione mondiale, ma, penetrando nelle acque di falda, ne riduce la qualità e, nelle aree critiche e intensamente popolate dei Paesi più poveri, le rende inutilizzabili per l’alimentazione umana.
L’inquinamento dei suoli destinati all’agricoltura o agli allevamenti zootecnici riduce la loro fertilità ai fini della produzione alimentare, ne compromette la qualità e quindi minaccia la salute di tutti, obbliga talvolta a operazioni di bonifica lunghe, complesse e dai costi estremamente elevati. I suoli delle aree naturali vedono compromessa la biodiversità degli ecosistemi animali e vegetali, e viene altresì minacciata la vitalità delle foreste e la loro capacità di assorbire e conservare il carbonio responsabile dell’alterazione del clima.
3. Gli impatti del cambiamento del clima
Le stesse sorgenti (industria, agricoltura, produzione termoelettrica, mobilità, riscaldamento civile) che emettono i composti tossici responsabili dell’inquinamento dell’aria, delle acque e dei suoli, sono anche in gran parte responsabili delle emissioni di quei composti che stanno alterando il clima del pianeta. In particolare, l’impiego massivo dei combustibili fossili (decine di miliardi di tonnellate annue) immette in atmosfera il biossido di carbonio (CO2), mentre le attività agricole e zootecniche contribuiscono al rilascio di protossido di azoto (N2O) e di metano (CH4). Questi composti gassosi provocano un continuo riscaldamento dell’atmosfera perché assorbono e poi rilasciano verso la Terra una frazione dell’energia solare che sarebbe altrimenti riflessa nello spazio extraterrestre. Il bilancio energetico del nostro pianeta viene cosi alterato e, per raggiungere un equilibrio tra l’energia solare in entrata e quella in uscita dalla Terra, la temperatura della superficie e dell’atmosfera del pianeta deve aumentare.
L’incremento delle temperature produce a sua volta una serie di importanti fenomeni: si sciolgono i ghiacciai e le nevi perenni dell’Artico, della Groenlandia e delle catene montuose, si innalza il livello degli oceani e se ne alterano le correnti, si desertificano i suoli delle regioni più calde del pianeta, aumentano in frequenza e intensità gli eventi meteorologici estremi quali alluvioni improvvise, siccità prolungate, uragani e incendi boschivi.
Tutti questi fenomeni, prodotti direttamente o indirettamente dall’incremento della temperatura del pianeta, producono impatti molti seri sulla salute umana, sulla sicurezza alimentare, sulle infrastrutture, sugli equilibri sociali e sulle relazioni politiche internazionali.
L’aspetto più preoccupante del cambiamento climatico è che, quando l’incremento della temperatura terrestre supera una certa soglia (non facilmente definibile a priori), il fenomeno diventa non solo irreversibile, ma assume il carattere di un “effetto valanga” cioè si amplifica a ritmo sempre più accelerato.
Ciò perché entrano in gioco meccanismi detti di “feedback” come, ad esempio, il fatto che, più diminuiscono le superficie nevose o ghiacciate del pianeta, tanto meno la radiazione solare viene riflessa e quindi tanto più il pianeta si riscalda con un “circolo vizioso” che non si riesce più a interrompere.

La sostenibilità ambientale è la base della sostenibilità economica e sociale
Le criticità ambientali che alterano gli equilibri biologici e fisici del nostro pianeta possono diventare in realtà anche seri fattori di minaccia allo sviluppo economico e causa di gravi instabilità politiche e sociali.
L’esaurimento delle risorse naturali minerarie o fossili e l’impiego di quelle rinnovabili a un tasso di sfruttamento superiore a quello di rigenerazione porteranno prima o poi a incrementi insostenibili dei costi di produzione di beni e servizi essenziali. I fenomeni di inquinamento diffusi dell’aria, delle acque e dei suoli, oltre ad aumentare gli oneri di carattere sanitario e sociale, comporteranno enormi investimenti e costi per interventi di disinquinamento e impianti di depurazione. Il cambiamento del clima può rendere improduttive vaste aree agricole del pianeta, incrementare il rischio di disastri di natura idro-geologica e arrecare danni consistenti alle infrastrutture.
Da un punto di vista sociale, un aggravamento della deriva climatica produrrà emigrazioni di massa, conseguenti tensioni sociali e conflitti politici e perfino militari. Accrescerà il divario tra Paesi ricchi e poveri e, dentro ogni nazione, le disuguaglianze tra ceti benestanti ed emarginati, ovvero tra coloro che possono permettersi di pagare i costi di azioni di adattamento al nuovo clima e quelli che non hanno le risorse per farlo.
Salvare l’ambiente naturale – fisico, geologico e biologico – del nostro pianeta non è solo un atto di rispetto verso il creato o di tutela degli habitat naturali, ma è un riconoscimento di quel principio di responsabilità che può garantire uno sviluppo umano davvero integrale, in cui benessere economico e sociale, qualità della vita e pace restino per sempre valori diffusi e condivisi.
NOTE
1. D.H. Meadows et al., I limiti dello sviluppo: rapporto del System Dynamics Group Massachusetts Institute of Technology (MIT) per il progetto Club di Roma sui dilemmi dell’umanità, Biblioteca della EST (Edizioni Scientifiche e tecniche Mondadori), 1972.
2. R. Carson, La primavera silenziosa, Feltrinelli, Milano 1962.
3. World Commission on Environment and Development (1987), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf