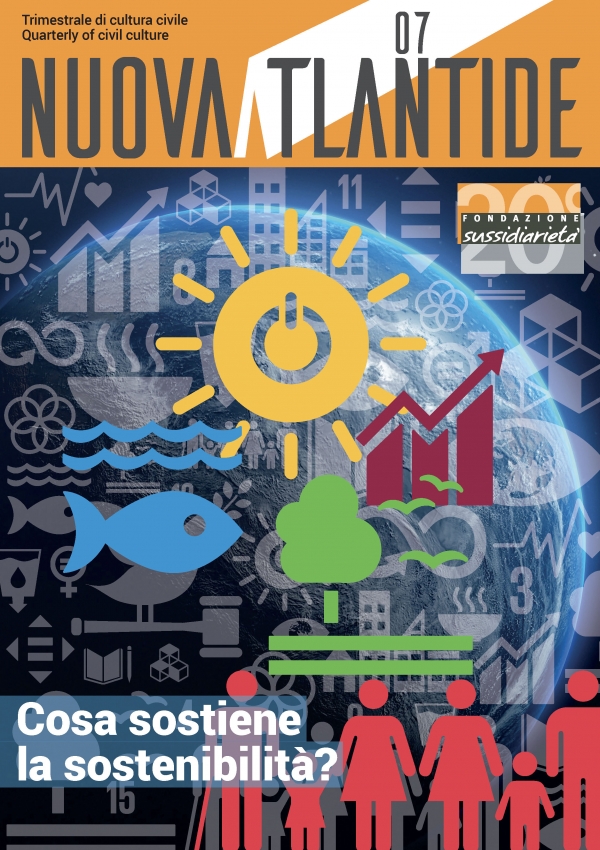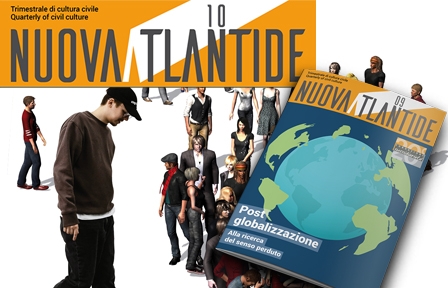Nel tempo dell’antropocene diventa centrale l’influenza dell’uomo sugli ecosistemi. E quindi in un percorso di sviluppo autenticamente sostenibile, non può non entrare in gioco la responsabilità della persona quale soggetto capace di relazione. Una presa di coscienza del valore del bene comune nella direzione indicata da Papa Francesco quando parla di ecologia integrale. “Non esiste realtà più forte di una moltitudine che inizia il cambiamento, questo ce lo dice la storia dell’umanità: quando certe idee vengono condivise, parte un movimento in grado di generare una nuova politica.”
Carlin Petrini a luglio 2022 ha lasciato la presidenza di Slow Food, associazione che ha fondato 33 anni fa e che ormai è un movimento internazionale non profit impegnato a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con l’ambiente e gli ecosistemi.
In tanti anni, lei che idea si è fatto di questa “sostenibilità”?
È una parola che proviene dall’inglese, e non tutti la capiscono: “sustainable” non significa “che sostiene”, significa qualcosa che è in grado di durare nel tempo, a questo bisogna mirare. Il ripieno degli agnolotti, nelle case piemontesi, era fatto con quello che avanzava durante la settimana. La vera sostenibilità ce l’hanno insegnata i nostri vecchi e oggi dobbiamo tornare a considerare queste cose non come una forma di arretratezza ma perché sono il futuro, ne dobbiamo andare orgogliosi. Se non cambia questo sistema, in qualche misura, siamo complici anche noi; ed essere complici di un cattivo affare in cui non si guadagna niente vuol dire anche essere stupidi.
Quali sono i nostri problemi principali?
Sono tre: 800 milioni di viventi soffrono di denutrizione e fame a causa di una crescita demografica di proporzioni incredibili; quando sono nato io, nel 1949, la Terra aveva 2,5 miliardi di abitanti, oggi siamo 8 miliardi. Come è possibile garantire cibo per tutta questa moltitudine?
Forse iniziando a ridurre lo spreco alimentare. Oggi buttiamo via il 30% dei beni alimentari che produciamo, si tratta di milioni di tonnellate di cibo, che sarebbero sufficienti a sfamare 12 miliardi di persone. Secondo punto critico: è in atto un processo di accaparramento delle terre, denominato land grabbing, per cui quasi 80 milioni di ettari di terra fertile dell’Africa sub-sahariana sono stati comprati a prezzi ridicoli, per coltivare in parte cibo che poi viene consumato in altri continenti, ma soprattutto per produrre biocarburanti. La parte destinata al consumo umano di cereali, infatti, è la minima parte rispetto a quella per la produzione di energia o per l’alimentazione animale. Terzo problema: la scarsità crescente – dovuta anche al riscaldamento globale – dell’acqua dolce, il 70% della quale viene usata dall’agricoltura.
Dobbiamo puntare sulla decrescita?
Bisogna intendersi su cosa intendiamo per crescita: se è la crescita della nostra vita sociale, della nostra felicità, del nostro benessere, è giusto perseguirla. Ma se la crescita è solo parametrata al PIL, alla produzione, al consumo, non sarà un vero progresso. Questo è uno dei passaggi più interessanti dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, che è una delle grandi novità di questi anni. Ultimamente, io – agnostico convinto – mi trovo in perfetta sintonia con il Papa, mi sembra l’unica persona che abbia la testa sulle spalle. Il dazio di questo modello di sviluppo – dice il Papa – lo pagano i poveri della Terra, ed è vero! A me non pare che nel mondo cattolico questa enciclica sia così conosciuta, né che sia diventata un elemento forte di riflessione. E anche il mondo laico sbaglia se considera questo testo come un documento ambientalista, una sorta di “enciclica verde”, non ha capito niente. La Laudato Si’ è un documento culturale, spirituale, considerarla un discorso meramente ambientalista è molto riduttivo. Il punto chiave è il concetto di ecologia integrale. Nel momento in cui si crea sofferenza alla Terra madre, automaticamente chi viene a soffrire è l’umanità, e in particolare quella più povera. Quindi non ci può essere giustizia ambientale in assenza di giustizia sociale, e viceversa. Questo è un passaggio dirimente: se non lo comprendiamo, non possiamo pensare di capire fino in fondo la riflessione che fa Papa Francesco.

Il cambiamento climatico peggiora drasticamente la situazione?
Siamo entrati nell’antropocene, parola che indica il fatto che l’influenza dell’uomo sugli ecosistemi è per la prima volta dirimente rispetto alla situazione ambientale. Dobbiamo avere coscienza che lo stato delle cose è grave. Un grado centigrado in più genera uno spostamento delle coltivazioni di 150 chilometri più a Nord e di 200 metri in più in altezza.
Nel mio Piemonte stiamo piantando le vigne in alta Langa, dove un tempo c’erano solo pecore. Si piantano vigne in Gran Bretagna, e nello stesso tempo in Sicilia arrivano le banane. Ma ci sono zone dell’Africa in cui non c’è più un filo d’erba, e difficilmente tornerà a esserci. Le nostre comunità di Terra Madre non possono più abitare certi luoghi perché senza erba gli animali muoiono. Il disastro è di proporzioni bibliche. Le zone aride generano miseria, le zone fertili vengono depredate: e dove può andare questa umanità se non riversarsi a Nord, verso l’Europa? Una delle grandi intuizioni della Laudato si’ è proprio questa: tutto, nel mondo, è collegato.
Il suo movimento insiste molto sulla difesa della biodiversità.
Negli ultimi 120 anni l’umanità ha perso il 70% delle specie viventi, frutti, verdure, razze animali. Tre specie vegetali (mais, riso e grano), forniscono il 60% del fabbisogno calorico dell’intera umanità. Quando le specie muoiono, e si ha improvvisamente bisogno di un ricambio, salta tutto. Faccio due esempi: alla fine dell’Ottocento in Piemonte si diffuse la filossera, un parassita della vite di provenienza americana, e la nostra produzione enologica rischiò di scomparire: se non ci fosse stata la vite americana da innestare, oggi le nostre belle vigne non esisterebbero più. Lo stesso si può dire della carestia delle patate in Irlanda, nel 1835 una sola varietà di patata dominava l’alimentazione di tutti gli irlandesi, un virus la attaccò e il Paese entrò in carestia perché non aveva altre alternative disponibili. Risultato: 1 milione e mezzo di morti, e 2 milioni di emigrati negli Stati Uniti d’America.
Sono esempi che impressionano, ma poi le nostre abitudini sono lente a cambiare.
Non riusciamo a capire la drammaticità di questi pericoli perché abbiamo la pancia piena. Nella penisola sorrentina viveva la mucca agerolese. Da centinaia di anni quelli si chiamano “Monti lattari” per la produzione che offrono: con quel latte si fa un formaggio buonissimo, il Provolone del monaco. La mucca agerolese dà 12 litri di latte al giorno: al prezzo di 60 centesimi al litro che vengono pagati oggi ai produttori, allevarla non conviene. Allora c’è chi dice: perché al posto della mucca agerolese non allevate la frisona olandese, che di litri al giorno ne dà 40? Ma il latte della frisona non fa il Provolone del monaco, non ha il grasso sufficiente. Applicando in maniera miope la logica del produttivismo vocata al profitto, il sistema Paese ha rischiato di perdere una razza bovina e un formaggio.
Non si può avere come obiettivo buttare giù i prezzi a beneficio di intermediazioni parassitarie e a scapito dei coltivatori, e meno che meno dei cittadini. Questi prezzi bassi incidono anche sull’ambiente: quello che risparmiamo perché il cibo costa poco, lo paghiamo poi in un’altra maniera, nella salute che viene a mancare e negli ecosistemi che vengono danneggiati.
Cosa è successo nel nostro rapporto con il cibo?
Ha perso valore, è diventato merce. In Italia negli ultimi vent’anni abbiamo cementificato un’area equivalente a tutto il Lazio, sottraendola ad aree coltivabili: questo perché la produzione agricola ha perso valore ed è diventato più interessante vendere il terreno per edificare.
Non possiamo produrre esattamente come cent’anni fa, però.
Il lavoro che dobbiamo fare è tenere aperto il dialogo fra la scienza e i saperi tradizionali. Penso che siamo arrivati al bivio, bisogna fare delle scelte nuove. Sfruttare la forza dei mercati locali, sostenere questo tipo di economia. La potenza dei consumatori è inimmaginabile. Guardate cosa è successo con l’olio di palma, che distrugge interi ecosistemi: adesso nessuno lo vuole più. E i contadini del Borneo, che qualcuno aveva convinto a piantare palme dappertutto perché erano redditizie, cosa faranno ora? I contadini, in tutto il mondo, devono poter stabilire prezzi buoni per loro stessi. Se vogliamo convincere dei giovani a tornare alla terra non possiamo dire loro che si venderanno carote a 7 centesimi al chilo o latte a 0,60 al litro. Dobbiamo creare valore e per farlo bisogna cambiare mentalità anche a tavola, forse cominciando a pensare di mangiare un po’ meno, ma meglio.
Il rischio però, in questo modo, è che il costo dei cibi aumenti.
Quando io ho cominciato a lavorare, il 30% del mio stipendio era destinato al cibo – e non sto parlando del Medioevo. Oggi è meno del 12%, e ci si avvicina sempre più al 10%. Le famiglie sono in ambasce non perché il cibo è caro, ma perché il sistema nel suo complesso è in tilt e ci si ritrova a dover sostenere economicamente figli e nipoti disoccupati. Abbiamo in casa la prima generazione di giovani che non sanno se riusciranno a lavorare. Noi vogliamo giovani che tornino alla terra, potendo però fare le ferie come tutti d’estate, e anche mandare i figli all’università. In un mondo in cui cresce la fragilità delle reti sociali, e la liquidità delle relazioni pare ergersi contro ogni forma comunitaria, ci sono però nuove forme di coraggio civile: la passione di chi non smette di immaginare e di lavorare per un mondo diverso, il respiro di tanti che si ostinano a stabilire legami di cooperazione, adottando modi di agire capaci di suscitare nuova socialità e solidarietà. La riflessione che va fatta è di tipo politico ed educativo. E il cambiamento non può che passare anche da noi stessi: se dismettiamo certi comportamenti possiamo incidere positivamente sulla salute degli ecosistemi e della società.
C’è qualche segnale?
Negli ultimi anni, grazie a una componente responsabile di cittadini, il consumo di carne (comparto largamente responsabile del cambio climatico) è leggermente diminuito, così come anche lo spreco alimentare. Inoltre, possiamo cambiare le cose proprio riconoscendo il valore aggiunto ai contadini, remunerandoli adeguatamente, e non all’intermediazione. Lavorando perché sia l’economia locale a fortificarsi e non l’economia globalizzata che mortifica i territori. Aiutando i giovani che ritornano alla terra. Se diventiamo soggetti attivi del cambiamento, la nostra potenza è inimmaginabile. Le nostre reti relazionali sono più potenti di qualsiasi multinazionale.
Non esiste realtà più forte di una moltitudine che inizia il cambiamento, questo ce lo dice la storia dell’umanità: quando certe idee vengono condivise, parte un movimento in grado di generare una nuova politica.