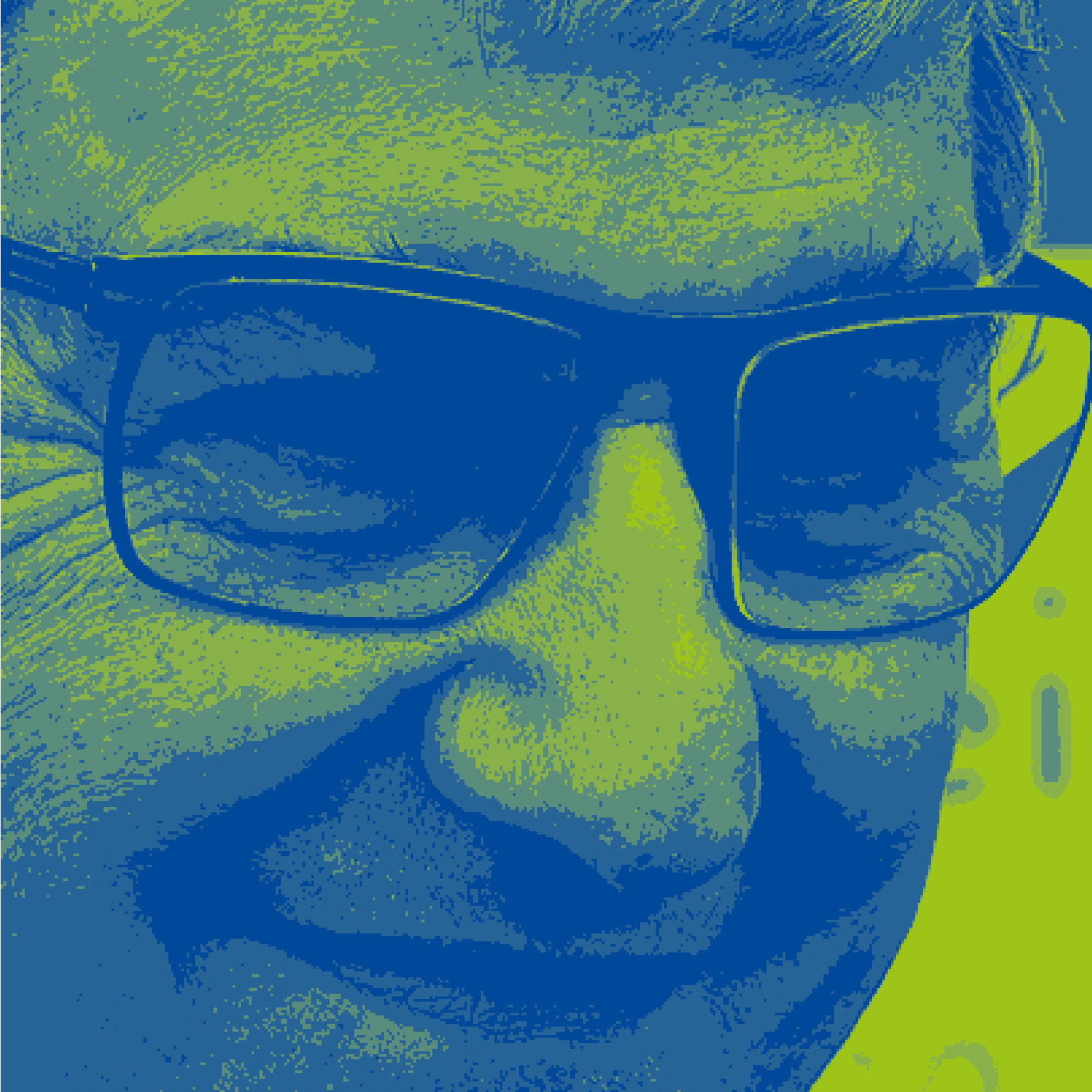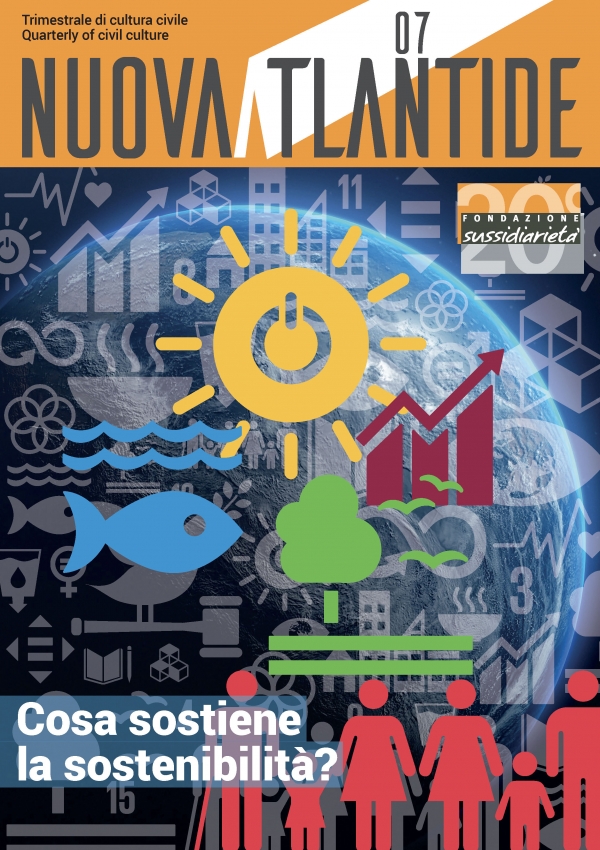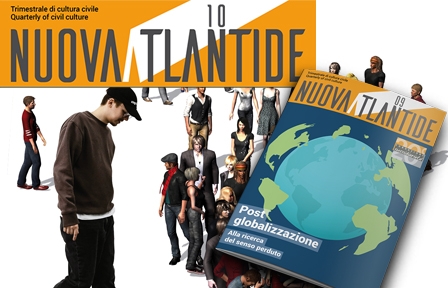C’è una porzione significativa delle nostre realtà imprenditoriali che riesce a esprimere un legame forte: qualità e bellezza con innovazione e coesione sociale. Un approccio sistemico “che vede nell’innalzamento del valore economico e simbolico dei prodotti la nostra chiave produttiva e al tempo stesso un’opportunità importante per ridurre il consumo di energia e di materie prime”. Si tratta di un processo che caratterizza settori strategici e decisivi: dall’industria all’agricoltura; dall’artigianato ai servizi; dal design alla ricerca. Un modo di procedere innovativo e in grado di fornire risultati sorprendenti. Grazie ai rapporti stretti delle imprese con il territorio e la comunità. Un segnale positivo su cui investire perché “l’Italia può essere protagonista della grande sfida aperta per inserire l’uomo in maniera non distruttiva nei grandi cicli della natura ma deve percepirla non solo come una necessità ma come una straordinaria opportunità”.
“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”. (Italo Calvino, Le città invisibili)
Non erano grandi le aspettative per la 27esima conferenza dei Paesi sul clima di Sharm el Sheikh. Purtroppo. La debolezza dell’ONU e le relazioni internazionali difficili, aggravate dall’invasione russa dell’Ucraina, non rappresentavano una buona premessa per un impegno convinto e comune contro la crisi climatica. In queste condizioni è positivo che si sia raggiunto uno storico risultato, atteso da almeno trent’anni: la decisione di istituire un fondo a sostegno dei Paesi più deboli che pagano spesso i prezzi più alti della crisi. L’Europa, che è stata determinante nella spinta per un esito positivo, non è riuscita a ottenere impegni più concreti e condivisi sulla riduzione dei gas serra. Non si tratta ora di attendere il prossimo vertice internazionale tra allarmi e azioni di lobbyng degli interessi fossili. Devono entrare in campo nuovi attori della società e dell’economia. Deve rafforzarsi la convinzione che la sostenibilità è la chiave per mobilitare energie e costruire un futuro migliore che non lasci indietro nessuno.
La sostenibilità non è un algoritmo
Sostenibilità in Italia fa rima con bellezza. Ha radici antiche ed è una chiave per il futuro. Forse la chiusa di quello straordinario libro di Italo Calvino che è Le città invisibili non appare con evidenza connesso alla sostenibilità, ha però molto a che vedere, a mio avviso, con un atteggiamento necessario per avvicinarla ed è questa una di quelle cose che mi accomunano alla Fondazione per la Sussidiarietà e in particolare a Giorgio Vittadini. La convinzione che partire dalla realtà, avere simpatia per le comunità e per gli umani sia il più efficace punto di partenza per lavorare a un futuro desiderabile. Ricordo ancora la piacevole sorpresa di scoprire in un Meeting di Rimini che quella citazione di Calvino era cara a don Giussani.
Impossibile affrontare il tema della sostenibilità senza avere come punto di riferimento l’Agenda approvata dall’ONU, dopo un lungo lavoro, il 15 settembre 2015 e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGS – Sustainable Development Goals nell’acronimo inglese), articolati poi in 169 target da raggiungere entro il 2030. Un minuzioso e prezioso corpus iuris del futuro, per valutare, confrontare, indirizzare politiche e imprese del mondo nei campi più vari: dalla crisi climatica alla pace, dalle città all’istruzione, dai diritti alla povertà. Al tempo stesso è necessario, per dare forza alla prospettiva della sostenibilità, tener conto delle caratteristiche specifiche dei vari Paesi, dei loro modelli sociali e produttivi. La sostenibilità, infatti, fatica a essere protagonista nella costruzione del futuro, se appare come un progetto tecnocratico, quasi un algoritmo, non in grado di mobilitare passioni, speranze, culture e per questo meno capace di orientare la rotta. In particolare, in Italia la realtà e la prospettiva della sostenibilità incrociano alcune caratteristiche del modello produttivo italiano, della nostra società, della nostra identità. Per dirla con Carlo Maria Cipolla, sono coerenti con l’antica missione dell’Italia di “produrre all’ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo”. Con la forza della nostra soft economy, che vede intimamente legata la spinta verso la qualità e la bellezza con l’innovazione e la coesione sociale; che vede nell’innalzamento del valore economico e simbolico dei prodotti la nostra chiave produttiva e, al tempo stesso, un’opportunità importante per ridurre il consumo di energia e di materie prime. Un processo che è presente in tutti i settori, dall’industria all’agricoltura, dall’artigianato ai servizi, dal design alla ricerca. La sostenibilità – e in particolare affrontare con coraggio la crisi climatica – diviene allora non solo una necessità ma, come dice il Manifesto di Assisi1 l’occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo, e per questo più capaci di futuro. E di contrastare anche i nostri mali antichi: non solo il debito pubblico, ma le disuguaglianze sociali e territoriali, l’economia in nero e l’illegalità, una burocrazia spesso soffocante, l’incertezza che genera paure e rancori.
La tensione umanistica dell’impresa
Per Marcel Proust un “vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre ma avere nuovi occhi”. Se provassimo a guardare il nostro Paese con nuovi occhi, le radici di ciò che siamo, e soprattutto di ciò che possiamo diventare, avremmo solo l’imbarazzo della scelta. Un intreccio che emerge carsicamente in tanti tratti della nostra storia. Ricordo che, sempre durante un Meeting di Rimini, trovai conferma del nostro sentire comune in un lavoro avviato a partire dall’affresco del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti. In un suggestivo e fertile passo del Constituto Senese del 1309 si dice che chi governa deve avere massimamente a cuore “la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini”. Una fantastica sintesi tra buona economia, soft power, identità e forza di una comunità. Praticamente la sceneggiatura dell’affresco del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti, dipinto qualche decennio dopo. E un fantastico programma per il nostro futuro.
Ancora a Siena, nella prima metà del Quattrocento, un grande pensatore francescano, san Bernardino da Siena, nelle sue prediche in piazza del Campo, comunicava a tutto il popolo anche la sua teoria sul mercato. Aveva già attaccato frontalmente gioco d’azzardo e prestito a usura. La sua idea era che non fosse lecito vivere di rendita se si era in grado di fare impresa, perché si sottraevano talenti alla comunità. Argomenti molto vicini a un passo della Laudato si’ in cui Papa Francesco critica la finanza tossica che rischia di soffocare l’economia reale. Temi che costarono a san Bernardino un processo, vinto, presso la Santa Inquisizione. Ma soprattutto, san Bernardino descriveva con sintesi ed efficacia le caratteristiche che rendono l’attività dell’imprenditore positiva per la comunità: efficienza, responsabilità, laboriosità, coraggio di intraprendere.
Mancano molti secoli all’elaborazione della Responsabilità Sociale d’Impresa. Ma l’Italia c’è. C’è un filo che porta alla parte migliore della nostra economia e della nostra società. Una parte non minoritaria. Nell’avventura di Adriano Olivetti – ad esempio – la tensione umanistica dell’impresa, la spinta all’innovazione tecnologica e l’attenzione alla comunità, ai lavoratori, alla cultura, sono indissolubilmente legate. Un’esperienza troppo spesso considerata esemplare ma isolata, mentre invece è la punta dell’iceberg di un modo di stare al mondo, di concepire la propria missione di una parte importante delle imprese e dei territori italiani. Il possibile retroterra di una sfida sulla sostenibilità e sulla green economy che ne rappresenta un elemento essenziale.
Nei molti lavori di indagine ed esplorazione di territori, culture, settori produttivi portati avanti dalla Fondazione Symbola con Unioncamere e altri partner, sul rapporto tra coesione e competizione, sull’industria della cultura, sul design, sulla green economy, emerge sempre che, se si guarda l’Italia con un occhio meno superficiale e distratto, con rispetto ed empatia, si scoprono energie sociali, tecnologiche, culturali, istituzionali fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Questo vale, in particolare, per il rapporto GreenItaly2 giunto alla sua tredicesima edizione. L’Italia, o almeno una parte significativa di essa, della sua economia e della sua società, grazie anche alla capacità di produrre cose belle e insieme innovative, grazie ai legami delle imprese con il territorio e la comunità, in molti campi è tra i Paesi più avanzati. Più vicino alle suggestioni dell’enciclica Laudato si’, più in grado di dare non facili carezze, ma embrioni di risposte alla “generazione Greta”. Una leadership dovuta ai nostri cromosomi antichi più che alle politiche, che interessa e produce risultati positivi in tutti i settori produttivi: dall’energia all’agricoltura, dalla chimica verde alla meccatronica, dal Made in Italy alla ricerca e sviluppo. Secondo il rapporto GreenItaly sono 531.000 le imprese italiane che, negli ultimi cinque anni (2017-2021), hanno investito sull’“economia verde” per affrontare il futuro con un aumento del 51% rispetto al periodo di rilevazione precedente (2014-2018). A spingere in questa direzione non solo il pericolo rappresentato dalla crisi climatica o la crescente sensibilità dei cittadini, la verità è che essere buoni conviene: le imprese orientate al green esportano di più, innovano di più, producono più posti di lavoro. I contratti relativi ai green jobs con attivazione 2021 sono il 34,5% dei nuovi contratti previsti nell’anno. Sono imprese che hanno migliori rapporti con lavoratori, comunità e territori. E sono spesso imprese gestite da giovani.
In alcuni campi, come quello dell’economia circolare, siamo poi una vera superpotenza europea. Abbiamo trasformato un vincolo, la mancanza di materie prime, in un’opportunità, utilizzando quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l’intelligenza umana. Dagli stracci di Prato, alle cartiere della Lucchesia, ai rottami di Brescia, abbiamo messo a frutto, prima che esistessero leggi e decreti, la nostra antropologia produttiva. Oggi l’Italia avvia al riciclo l’83,4% del totale dei rifiuti contro il 53,8% delle media europea, molto più della Germania (al 70%). E questo ci fa risparmiare 23 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e 63 milioni di tonnellate di CO2.

Coesione è competizione
È un processo di innovazione che interessa tutti i settori del saper fare italiano: dall’high-tech all’agricoltura, dalle fonti rinnovabili alla chimica verde, dal legno-arredo al made in Italy.
L’Italia ha molto da dire nella direzione indicata dall’Europa per rispondere alla crisi e costruire una nuova economia a partire da investimenti in coesione, transizione verde e digitale. È una sfida di enorme portata che può rafforzare imprese e società ma richiede il contributo e la collaborazione delle migliori energie imprenditoriali, istituzionali, politiche, sociali, culturali, come evidenzia il rapporto Coesione è competizione promosso dalla Fondazione Symbola, Unioncamere e Intesa Sanpaolo.
Anche in un anno difficilissimo come il 2020 la coesione ha rappresentato per le imprese un’occasione per accrescere il senso di appartenenza e soddisfazione di vita dei propri dipendenti (nel 2020 le erogazioni di welfare sulla base di contrattazione sindacale sono cresciute del 19,5 %) per rafforzare le relazioni di filiera e distrettuali (le imprese ricadenti nei distretti, secondo il monitor di Intesa Sanpaolo, negli ultimi anni hanno visto crescere la produttività più delle imprese non distrettuali), ma anche per competere in un mercato che premia sempre di più gli atteggiamenti virtuosi. Sul versante degli investimenti, crescono quelli diretti verso aziende che dimostrano attenzione alla dimensione sociale e ambientale, crescono anche i consumi, laddove appunto i consumatori, votando con il portafoglio, come dice il mio amico Leonardo Becchetti o con i click, scelgono sempre più consapevolmente prodotti rispettosi dell’uomo e dell’ambiente e talvolta con il crowfunding supportano le aziende più sostenibili e coesive. L’Italia in questo ambito ha molto da dire e presenta tante azioni concrete: la Cantina Arnaldo Caprai ha stabilizzato il flusso della manodopera accogliendo nelle sue vigne i richiedenti asilo che si rivolgono alla Caritas in cerca di lavoro; Chiesi Farmaceutici ha trasformato i suoi fornitori partner, scrivendo con loro un documento condiviso di sviluppo, per migliorare insieme la sostenibilità e qualità; COOP Lombardia ha reso i suoi store più inclusivi, realizzando il primo supermercato in Europa “autism friendly” nel settore GDO, grazie al dialogo con un’associazione del Terzo settore e ha coinvolto i suoi dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi di business; Edinnova, la neonata rete per l’innovazione della filiera dell’edilizia, che attualmente riunisce otto imprese, è stata fondata con l’obiettivo di favorire la ricerca e il trasferimento tecnologico lungo tutta la filiera; Enel ha dato vita a una comunità scientifica diffusa, con cui condivide sfide tecnologiche e idee per innovare e migliorare la vita delle persone; IMA, in grado di accrescere la competitività dei suoi fornitori attraverso un percorso basato su confronto, dialogo e sviluppo delle competenze reciproche; LAGO ha superato la figura del cliente per trasformare i suoi utenti in una comunità capace di abilitare la creazione di arredi empatici che rimettono la persona al centro dell’abitare; Loccioni si è posto l’obiettivo di accrescere nei suoi collaboratori una spinta imprenditoriale, motore delle innovazioni dell’azienda e dello sviluppo professionale di ogni individuo; Noberasco, insieme a Coldiretti e Bonifiche Ferraresi ha avviato un percorso di rinascita delle filiere abbandonate del made in Italy; Venchi, insieme a Intesa Sanpaolo ha permesso l’accesso al credito a circa 6.000 piccole e medie imprese del territorio legate alla filiera del cioccolato e alla sua distribuzione in un momento di difficoltà generato dall’emergenza Covid-19. Sono solo alcune storie che dimostrano, come afferma il Manifesto di Assisi, che: “Non c’è nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia”. Storie che si traducono in dati, a cominciare dai risultati concretamente misurati sulle imprese coesive che hanno dimostrato nella crisi di essere più resilienti: anche nel 2020, l’anno più duro, la quota delle imprese con fatturato in riduzione è minore per le imprese coesive rispetto a quelle non coesive (58% vs 66%). Le imprese coesive hanno esportato di più (il 58% contro il 39% delle non coesive); sono quelle che hanno fatto più eco-investimenti (il 39% contro il 19% delle non coesive); hanno investito di più per migliorare prodotti e servizi (il 58% contro il 46% delle non coesive); hanno adottato o stanno pianificando di adottare misure legate al Piano Transizione 4.0 (il 28% contro l’11% delle non coesive).
Se fossimo attenti non solo ai nostri grandi limiti, che peraltro non affrontiamo, ma ai nostri tanti punti di forza saremmo più capaci di mobilitare i nostri talenti senza lasciare indietro nessuno. La più grande acciaieria al mondo che neutralizzerà le emissioni di CO2 è Arvedi, che ha peraltro un rapporto ottimo con il territorio di Cremona. In un altro Paese sarebbe un primato da valorizzare ed esibire.
L’Italia può essere protagonista della grande sfida aperta per inserire l’uomo in maniera non distruttiva nei grandi cicli della natura ma deve percepirla non solo come una necessità ma come una straordinaria opportunità. Per dirla con Gilbert Keith Chesterton: “La vita è la più bella delle avventure ma solo l’avventuriero lo scopre”.
NOTE
1. Un’economia a misura d’uomo contro la pandemia e la crisi climatica, manifesto, https://www.symbola.net/manifesto/
2. GreenItaly 2022. Un’economia a misura d’uomo contro le crisi, 25 ottobre 2022, https://www.symbola.net/ricerca/green-italy-2022/