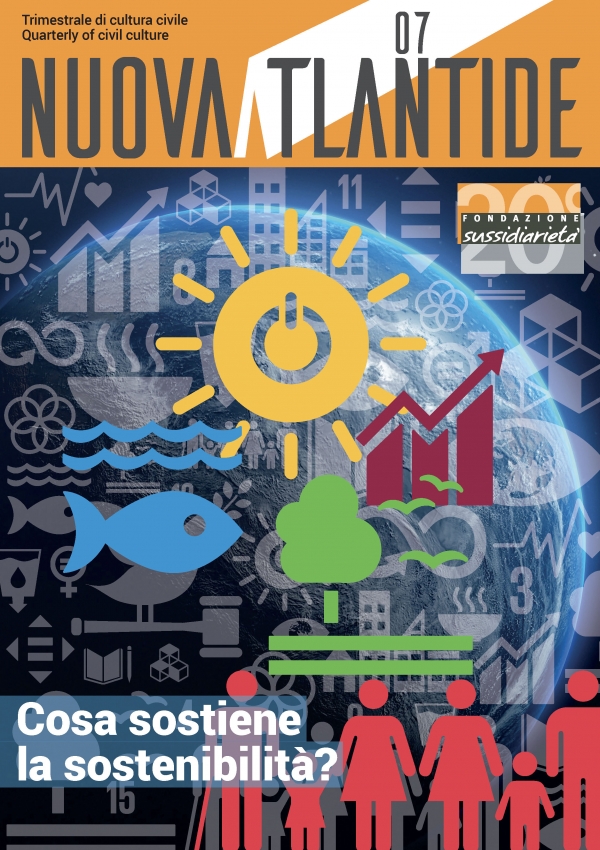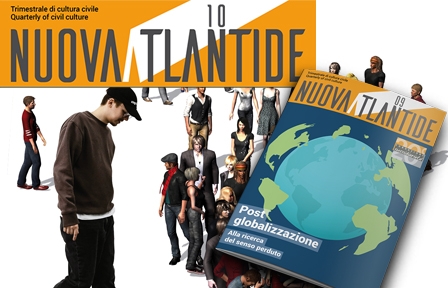Il mito della crescita economica, perseguito nelle società con politiche aggressive in tutto il mondo, sta segnando questa stagione storica. Con il risultato di un’impennata dell’attività economica globale che non sta andando di pari passo con una prosperità che abbia come scopo lo sviluppo umano integrale. La grande sfida è proprio quella di un radicale cambiamento che muova dalla comprensione della natura tridimensionale dell’essere umano. E cioè: materiale, sociorelazionale, spirituale. Dunque, urgono cambiamenti strutturali accessibili e nuove pratiche di vita. Attraverso i quali individuare le misure più efficaci per promuovere e rafforzare la resilienza. Tra le decisive, un investimento in educazione e cultura. La mancanza di una visione “integrale” è stata evidente negli appuntamenti internazionali con a tema “il che fare” davanti alle urgenze che stanno investendo il pianeta. Le politiche dall’alto verso il basso non sono sufficienti. Necessita una trasformazione istituzionale dal basso. Una prima risposta credibile, davanti allo strapotere della finanza e del commercio internazionale, è la creazione di un’Organizzazione Mondiale dell’Ambiente.
Introduzione e motivazione
Ogni società, in ogni tempo, si aggrappa a un qualche mito con cui vive. Quello di questa stagione storica è stato ed è il mito della crescita economica. Negli ultimi cinque decenni il perseguimento della crescita – un concetto da non confondere con quello di sviluppo umano integrale – è stato l’obiettivo politico più importante in tutto il mondo. Come indicato da Tim Jackson1, l’economia globale è oggi quasi cinque volte più grande di quella di mezzo secolo fa. Se continuerà a crescere allo stesso ritmo, nel 2100 l’economia sarà 80 volte più grande. Questa straordinaria impennata dell’attività economica globale non ha precedenti storici. È totalmente in contrasto con le nostre conoscenze scientifiche sulla limitatezza delle risorse e sulla fragilità ecologica da cui dipendiamo per la nostra sopravvivenza: già circa il 60% degli ecosistemi mondiali versa oggi in uno stato di avanzato degrado. La prosperità consiste nella nostra capacità di comprendere la natura tridimensionale dell’essere umano: quella materiale, quella socio-relazionale, quella spirituale. La grande sfida attuale è creare le condizioni in cui ciò diventi possibile. È il compito più urgente del nostro tempo.
Un elemento dell’ambiente di vita è definito resiliente se accresce la capacità dell’ambiente di adattarsi al cambiamento climatico (CC), cioè di limitare, contrastare e ridurre, con interventi adeguati, gli effetti del CC che possono danneggiare l’ambiente. Questa resilienza si manifesta in modi diversi, a seconda del contesto considerato. Ad esempio, la resilienza per un essere vivente è la sua capacità di “autoriparazione” dopo un danno. Per un sistema ecologico, la resilienza è la capacità di tornare allo stato iniziale dopo aver subito un disturbo. In psicologia, la resilienza di un essere umano è la capacità di superare positivamente gli eventi traumatici. Per facilitare questo adattamento al CC, la resilienza deve essere rafforzata e promossa con procedure e tecnologie appropriate.
Finora sono state individuate e attuate due principali strategie per far fronte al CC. La prima è la mitigazione, che agisce sulle cause del CC riducendo sia le emissioni di gas serra (GGE, Greenhouse Gases Emissions) sia l’uso di fonti energetiche fossili. La seconda è l’adattamento, per ridurre gli impatti del CC, mediante la messa in opera di tutte quelle azioni che possono limitare e contrastare gli sconvolgimenti climatici, la riduzione della biodiversità, la fragilità delle coste, ecc. La strategia di mitigazione suggerita dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) nei confronti dei GGE e dei loro effetti sul CC, non ha ancora dato i risultati sperati. È quindi necessario concentrarsi sulle strategie di adattamento, per contrastare quanto prima gli effetti del CC sulle persone e sugli ambienti più vulnerabili, aumentando la loro resilienza attraverso interventi locali e azioni mirate2.
Occorre prendere atto che la nostra economia di mercato ha mostrato una grave mancanza di resilienza. In sostanza, è come se avessimo costruito delle automobili senza pensare alle gomme di scorta, per usare una metafora popolare.
I sistemi del tipo just-in-time sono stati innovazioni meravigliose finché l’economia ha affrontato solo piccole perturbazioni, ma si sono rivelati un disastro, a fronte di eventi straordinari quali la pandemia da Covid-19. Come ha sottolineato più volte Joseph Stiglitz3, i mercati non sono in grado di dare un valore al rischio, per lo stesso motivo per cui non riescono a prezzare le emissioni di anidride carbonica. È in ciò la ragione fondamentale del fallimento del neoliberismo e dei presupposti politici su cui si basa. In verità, i mercati sono miopi e la finanziarizzazione dell’economia dell’ultimo trentennio li ha resi ancora più tali.
Proprio perché i mercati non riescono a tenere conto dei principali rischi, gli interventi sulla resilienza devono tenere in considerazione tale lacuna. La soluzione comunemente proposta è quella di costringere le imprese a farsi carico, in misura adeguata, delle conseguenze delle loro azioni, in particolare delle esternalità negative come le emissioni di gas serra. Senza un prezzo sul carbonio, ci sarà troppo inquinamento, un uso eccessivo di combustibili fossili e pochi investimenti e innovazioni verdi. Ma assegnare un prezzo al rischio è assai più difficile che assegnare un prezzo al carbonio.
Il fatto triste da tenere presente è che il cambiamento climatico rappresenta il più grande caso di “fallimento del mercato” che il mondo abbia mai conosciuto finora. Nel 2022 ricorre il 50° anniversario della storica Conferenza di Stoccolma sull’ambiente delle Nazioni Unite (1972). Da allora, pressochè nulla di significativo è stato realizzato sul fronte della resilienza.
Le ragioni del parziale fallimento del Patto per il clima di Glasgow
La Conferenza COP 26 (Glasgow, novembre 2021) non è stata all’altezza delle aspettative per una serie di motivi. Uno dei più rilevanti è stato la mancanza di fiducia che, a far tempo dalla prima COP1 (Berlino, 1995) ha sempre caratterizzato lo svolgimento di questi negoziati. I Paesi in via di sviluppo considerano il cambiamento climatico come una crisi la cui responsabilità principale ricade sui Paesi sviluppati, che non hanno mantenuto la promessa – risalente alla COP15 del 2009 – di mettere a disposizione 100 miliardi di dollari all’anno a favore dei Paesi più deboli. Questo fondo avrebbe potuto essere finanziato adottando lo schema del Global Carbon Incentive (GCI) proposto di recente da Raghuram Rajan4. La proposta è semplice. Ogni Paese che emette più della media globale di circa cinque tonnellate pro-capite verserebbe annualmente a un Fondo di Incentivazione Globale, un importo determinato moltiplicando le emissioni pro capite in eccesso per la popolazione e il GCI. Se, ad esempio, il GCI fosse di 10 dollari per tonnellata, gli Stati Uniti pagherebbero circa 36 miliardi di dollari e l’Arabia Saudita 4,6 miliardi. Al tempo stesso, i Paesi al di sotto della media mondiale pro-capite riceverebbero un adeguato compenso.
In questo modo, ogni Paese subirebbe una perdita effettiva di 10 dollari per ogni tonnellata aggiuntiva emessa pro capite, indipendentemente dal fatto che sia partito da un livello alto, basso o medio. Non ci sarebbe più un problema di free-riding, perché i Paesi poveri avrebbero gli stessi incentivi a risparmiare sulle emissioni di quelli ricchi. Non solo, ma il GCI risolverebbe anche il problema dell’equità. I Paesi a basse emissioni, che spesso sono i più poveri e i più vulnerabili ai cambiamenti climatici di cui non sono responsabili, riceverebbero un ammontare che servirebbe loro per accrescere la loro capacità di adattamento. Inoltre, il GCI non eliminerebbe affatto la sovranità nazionale perchè riconosce che ciò che un Paese intende fare a livello nazionale è affar suo. Invece di imporre una tassa sul carbonio, misura questa politicamente impopolare, un Paese potrebbe imporre regolamenti severi sul carbone; un altro potrebbe tassare gli input energetici e un altro ancora potrebbe incentivare le energie rinnovabili. Ognuno sarebbe libero di tracciare la propria strada, mentre il GCI integrerebbe gli incentivi morali che già guidano l’azione a livello nazionale.
Una seconda ragione del parziale fallimento della COP26 è la disconnessione tra modelli climatici e modelli macroeconomici. Finora le politiche fiscali si sono basate sull’assunto che, mentre i costi dei danni climatici sono incerti e comunque riguardano un futuro lontano, i costi della trasformazione sono certi e vanno sostenuti nel presente. Questo porta a sottovalutare i danni degli eventi estremi e pure i benefici a lungo termine delle politiche climatiche. Ci si sarebbe aspettati che la COP26 avesse proposto una revisione radicale dei principi e dei modelli utilizzati finora per orientare le scelte dei decisori politici. Non è stato così, purtroppo. Abbiamo dunque urgentemente bisogno di una “regola d’oro verde”, in base alla quale gli investimenti pubblici per la transizione non contribuiscano ad accrescere il cosiddetto debito pubblico “cattivo”.
Terzo. Per combattere il cambiamento climatico, si è proposto che lo strumento più efficace debba essere la tariffazione generalizzata del carbonio. Ma questo strumento è difficile da applicare per una pluralità di ragioni, poiché le condizioni dei Paesi partecipanti alla COP differiscono sia in termini di livelli di reddito sia di mix energetico adottato. Di conseguenza, la COP26 avrebbe dovuto stabilire un “International Carbon Price Floor” (ICPF) per accelerare le riduzioni delle emissioni attraverso un’azione politica efficace, frenando al contempo la crescente pressione per introdurre aggiustamenti fiscali alle frontiere. A questo proposito, va notato che un gruppo di 3623 economisti americani ha recentemente approvato un documento che sostiene l’introduzione di un meccanismo di aggiustamento alle frontiere per il carbonio (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) a integrazione della familiare carbon tax5. L’ICPF dovrebbe basarsi su due elementi: a) andrebbe negoziato tra un numero ristretto di Paesi chiave con alti livelli di emissioni; b) l’accordo dovrebbe includere il prezzo minimo del carbonio che ciascuno di questi Paesi si impegna ad applicare.
Quarto. La progettazione di politiche per il cambiamento climatico richiede analisi che integrino le interrelazioni tra economia e ambiente. Tuttavia, gran parte della modellistica economica standard – compresi i ben noti “modelli di valutazione integrata” (IAM) – non incorpora gli aspetti chiave del problema in questione. Come hanno indicato Joseph Stiglitz e Nicholas Stern6, ci sono difetti fondamentali nelle metodologie comunemente utilizzate per valutare la politica climatica, che mostrano pregiudizi sistematici, con costi dell’azione climatica sovrastimati e benefici sottostimati. La conseguenza è che l’uso dei modelli di valutazione integrata, considerata la loro scelta di calibrazione, ha portato i responsabili politici a concludere che l’ottimizzazione degli interventi è compatibile con l’accettazione di un aumento della temperatura di quasi 4 gradi Celsius, mentre il limite superiore era stato fissato a 2 gradi già alla Conferenza di Parigi (2015).
La Conferenza di Glasgow avrebbe dovuto sottolineare questa grave incoerenza e annunciare la costituzione di un gruppo di lavoro globale incaricato di proporre una metodologia alternativa per orientare le scelte dei responsabili politici. Simon Dietz e altri7 mostrano che molti dei più importanti modelli economici sul cambiamento climatico producono dinamiche climatiche incoerenti con gli attuali modelli della scienza del clima. Queste incongruenze si ripercuotono poi sugli indirizzi e sulle prescrizioni economiche adottate dai governi. Si tratta di un problema veramente serio rispetto al quale la professione degli economisti, nel suo insieme, va ritenuta molto responsabile.

Alcune misure per aumentare la resilienza
Una prima misura utile è quella di ridurre la domanda di beni e servizi ad alta intensità di emissioni. Questa opzione è di gran lunga la più efficace ai fini della riduzione delle emissioni nel mondo industrializzato e può essere attuata in breve tempo, anche se alcuni aspetti, come l’adeguamento della pianificazione territoriale per ridurre le distanze di viaggio, possono richiedere del tempo.
A questo proposito, un utile strumento di analisi è dato dalle Curve di Engel Ambientali (CEA), che descrivono la relazione tra redditi delle famiglie e inquinamento dovuto ai beni e servizi che esse consumano. Queste curve sono utili per stimare la misura in cui i miglioramenti ambientali osservati, che derivano dal cambiamento dei modelli di consumo, possono essere attribuiti alla crescita del reddito. Queste curve presentano tre caratteristiche. In primo luogo, le CEA hanno un andamento ascendente: le famiglie più ricche sono indirettamente responsabili di un maggiore inquinamento. In secondo luogo, le CEA sono concave, con un’elasticità al reddito inferiore a uno. In terzo luogo, le CEA si spostano verso il basso nel corso del tempo: per ogni livello di reddito, le famiglie tendono a produrre quantità sempre minori di inquinamento. Gran parte di questo miglioramento è attribuibile al fatto che le famiglie consumano un mix di beni e servizi meno inquinanti. Ciò suggerisce l’importanza dell’educazione e, più in generale, degli investimenti in cultura8.
Una seconda misura per aumentare la resilienza si basa sulla seguente considerazione. I costi della mitigazione, basati sull’aumento dell’efficienza e sui cambiamenti tecnologici per stabilizzare le concentrazioni di gas serra a livelli corrispondenti al limite dei 2°C, saranno inferiori al 3% del prodotto nazionale mondiale entro il 2030, se la concentrazione di gas serra nell’atmosfera sarà stabilizzata a un livello corrispondente al limite dei 2°C. Questi costi, però, aumentano per ogni anno di ritardo nell’azione. Ecco perchè sono necessari strumenti economici che incoraggino una risposta del mercato alla riduzione delle emissioni di gas serra.
È in corso un dibattito sugli strumenti più adatti; ad esempio, un sistema globale di scambio di diritti di emissione o tasse sulle emissioni di gas serra; ma il punto essenziale è che le emissioni devono avere un prezzo e che questo prezzo deve essere prevedibile. È essenziale tenere presente che il cambiamento climatico è conseguenza dello stile di vita insostenibile, dei modi di produzione e dei modelli di consumo che si sono sviluppati nel mondo industrializzato nell’ultimo secolo. La riduzione delle emissioni di gas serra non risolverà da sola il problema della sostenibilità. Non lo faranno nemmeno le soluzioni di geoingegneria, come la proposta di introdurre aerosol di solfato nella stratosfera al fine di riflettere parte della radiazione solare. Come suggerito da Papa Francesco nella Laudato Si’, se non si affronta il problema alla radice vane saranno le varie misure proposte.
Un’altra misura importante per migliorare la resilienza è quella di ripensare gli indicatori del benessere umano, delle performance macroeconomiche e dei rischi finanziari. Gli indicatori di benessere devono riconoscere l’impatto che l’intervento umano determina sull’ambiente. Gli indicatori di performance macroeconomica devono incorporare l’incertezza insita nelle dinamiche della biosfera per garantire la conservazione del capitale naturale. Le istituzioni finanziarie devono riconoscere una serie più ampia di cambiamenti planetari e sviluppare la contabilità d’impatto come elemento integrante delle decisioni di allocazione del capitale9.
C’è chi sostiene che adottare misure correttive caso per caso, man mano che si verificano gli impatti dei cambiamenti climatici, sia economicamente più efficiente che intraprendere azioni di adattamento per stabilizzare il clima. Nel brevissimo termine, e da un punto di vista puramente finanziario, questo può essere vero, poiché, a causa dell’inerzia del sistema climatico, i principali benefici climatici derivanti dalle azioni di mitigazione e adattamento avranno effetto solamente nel futuro lontano. Tuttavia, questo approccio non è compatibile con lo sviluppo sostenibile, né è eticamente accettabile. Le vite umane perse nei disastri indotti dal clima, o le specie animali e vegetali che si estinguono, non possono essere ripristinate quale che sia la quantità di denaro messa a disposizione. Ancora più importante è il fatto che l’inazione di oggi renderà quasi certamente impossibile evitare il superamento di punti di svolta climatici che porteranno, ad esempio, a cambiamenti nella dinamica dei monsoni in Cina o in India, allo scioglimento dei ghiacciai dell’Himalaya, che forniscono acqua a circa un sesto della popolazione mondiale, o all’innalzamento del livello del mare ben oltre un metro. La conseguente necessità di trasferire milioni di persone dalle zone costiere determinerà sofferenze e lutti che il denaro mai potrà compensare.
L’inazione è dunque imperdonabile perché le azioni necessarie non richiedono sacrifici inaccettabili da parte del mondo industrializzato – al contrario, richiedono cambiamenti strutturali accessibili e nuove pratiche di vita, che possono essere visti come una straordinaria opportunità di tornare ai veri valori della vita.
La scelta non è quindi tra lotta per il clima e lotta alla povertà e alle malattie, come talvolta si sostiene. È vero il contrario: la protezione del clima è un contributo essenziale alla lotta alla malnutrizione, alle malattie e alla povertà.

In difesa di un’Organizzazione Mondiale dell’Ambiente
Dopo la COP26, è più chiaro che mai che gli impegni e le politiche dall’alto verso il basso non sono sufficienti. Abbiamo bisogno di una trasformazione istituzionale dal basso. Infatti, la mancanza di un’adeguata governance ambientale internazionale (GAI) è il risultato di un’ingiustizia fondamentale nell’attuale stato della governance globale: un enorme potere e risorse sono stati concentrati nella finanza e nel commercio internazionale senza pensare a una corrispondente autorità per l’ambiente, e per i diritti umani. L’aumento del potere e dell’influenza delle principali istituzioni finanziarie e commerciali internazionali, come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), verificatosi nel corso degli anni Novanta del secolo scorso, contrasta nettamente con l’indebolimento dei programmi delle Nazioni Unite per l’ambiente e lo sviluppo (UNEP, UNDP).
L’esistenza di potenti regimi commerciali e finanziari internazionali senza un’analoga legislazione e strutture istituzionali per gli standard sociali e ambientali permette all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) di agire come arbitro de facto sulle questioni ambientali. Tuttavia, l’OMC è un’istituzione che non solo non ha una competenza di base sulle questioni e sulle politiche ambientali, ma considera l’ambiente come una merce da sfruttare piuttosto che un bene comune globale, una risorsa che richiede una gestione adeguata. Il risultato è che le questioni ambientali, sociali e dei diritti umani, sono messe in secondo piano rispetto agli interessi finanziari e commerciali. Il che è veramente inaccettabile10. Come noto, la governance di un bene comune non può che essere una governance comune, nel senso di Elinor Ostrom.
Ecco perché ritengo che una risposta credibile alla questione ambientale sia, per un verso, la creazione di un’Organizzazione Mondiale dell’Ambiente (OMA) e per l’altro verso il rafforzamento delle organizzazioni sociali delle Nazioni Unite, in modo che queste istituzioni possano fare da contrappeso alle potenti istituzioni finanziarie e commerciali. Un’OMA sarebbe un avvocato designato e dotato di poteri per l’ambiente, in grado di assicurare la esecutorietà delle decisioni che vengono sottoscritte nelle varie sedi internazionali. È proprio questo il senso di quella che è stata definita “politica dell’innovazione orientata alla missione” (Mariana Mazzucato). Naturalmente, l’Organizzazione Mondiale dell’Ambiente non risolverà da sola i problemi della governance ambientale internazionale, perché è pur sempre necessaria una riforma radicale dell’OMC e del FMI. Tuttavia, l’istituzione di una OMA sarebbe un passo avanti decisivo verso un sistema di governance globale più equo, efficace e responsabile.
Un’ultima osservazione
Una realtà planetaria in continuo cambiamento pone sfide e rischi immensi. Eppure, il passaggio a un futuro giusto per tutti su un pianeta prospero è possibile, a patto che ci si liberi dell’ostacolo più potente sulla strada di un nuovo regime climatico, ossia l’incapacità di immaginare un sistema economico diverso da quello attuale, capace di realizzare un nuovo equilibrio tra mercato e società, e tra umanità e ambiente. Considerare il cambiamento impossibile è il modo migliore per perpetuare l’esistente. La difficoltà di dare una risposta efficace al cambiamento climatico è legata alla difficoltà di immaginare che un altro ordine economico sia possibile. Un ordine in cui l’economia sia una funzione della società – e non viceversa –, in cui gli esseri umani siano consapevoli degli effetti causati dalle loro azioni e in cui la lotta al consumismo non possa essere interpretata come un ritorno alla miseria.
Non voglio tecere le difficoltà che si nascondono nell’attuazione pratica di un progetto culturale che ha come obiettivo niente meno che un “cambio di paradigma” nel pensiero economico e un nuovo modello di sviluppo economico. Come in tutte le attività umane, sarebbe ingenuo pensare che certi cambiamenti non creino conflitti. Le differenze di visione e gli interessi in gioco sono enormi. Non è un caso che oggi la società sia attraversata da una sorta di angoscia diffusa per il futuro. Alcune persone e alcuni gruppi di pressione sfruttano questa angoscia come strumento politico, ricavandone, a seconda delle circostanze, un machiavellismo incentrato sul mercato o un machiavellismo incentrato sullo Stato. È proprio contro questa cultura neomachiavellica e il relativismo etico che da essa discende, che occorre battersi con coraggio e saggezza.
NOTE
1. T. Jackson, Prosperity without growth. The transition to a sustainable economy, Routledge, London 2011.
2. M. Mammarella, G. Grandoni, Azioni di resilienza per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e delle emergenze sanitarie nelle città, Ann. Ist. Sup. Sanità, Roma, 55, 2019
3. J.E. Stiglitz, Making globalization work, W.W. Norton & Company, New York 2006.
4. R. Rajan, A Global Incentive to Reduce Emissions, in Project Syndacate, 31 maggio 2021, https://www.project-syndicate.org/commentary/global-carbon-incentive-for-reducing-emissions-by-raghuram-rajan-2021-05
5. Economists’ Statement on Carbon Dividends, in The Wall Street Journal, 17 gennaio 2019, tinyurl.com/36krn3r2
6. J.E. Stiglitz e N. Stern, The Social Cost of Carbon, Risk, Distribution, Market Failure: an Alternative Approach, NBER, working paper 28472, Cambridge, febbraio 2021, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28472/revisions/w28472.rev0.pdf
7. S. Dietz et al., Are Economists Getting Climate Dynamics Right and Does It Matter?, CESifo working paper no. 8122, 28 febbraio 2020.
8. A. Levinson, J. O’Brien, Environmental Engel Curves, NBER, working paper no. 20914, gennaio 2015, https://www.nber.org/papers/w20914.
9. V. Galaz, D. Collste, a cura di, Economy and Finance for a Just Future on a Thriving Planet, Report, Beijer Institute and Stockholm Resilience Centre, Stockholm, 2 aprile 2022.
10. W. Pace, V. Clarke, The case for a World Environment Organization, The Federalist Debate, 1, 2003.