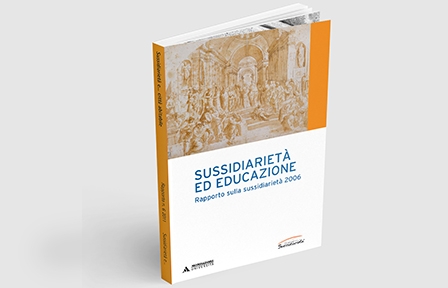In un famoso discorso tenuto nel 2005 per festeggiare i laureati del Kenyon College, in Ohio, lo scrittore David Foster Wallace, divenuto presto un’icona della letteratura americana dell’inizio del XXI secolo, raccontò questo aneddoto da cui mi piace partire. Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all’altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice loro: “Buongiorno ragazzi! Com’è l’acqua?”
I due giovani pesci continuano a nuotare per un po’, poi uno dei due guarda l’altro e gli chiede: “Che cosa diavolo è l’acqua?”.
Il problema è tutto qui. Anche nella nostra attività professionale, come credo nel nostro rapporto con l’esistenza più in generale, il problema è che noi non ci accorgiamo di quello che c’è, non ci accorgiamo di quello che ci accade.
In questo senso posso dire, per esempio, che la cosa più interessante di quello che vi dirò siete voi: mi colpisce che siate in tanti qui, oggi, con uno sguardo pieno di interesse e un’attenzione tesa. Vorrei partire da questo. Perché quello che più mi ha colpito di fronte alla proposta fatta da Julián Carrón[1] l’anno scorso alla convention di Diesse, con il suo intervento Insegnare oggi. Nuovi contesti e nuove sfide[2], è il fatto che per comprenderla e per reagire adeguatamente a essa non basta commentarla o renderla oggetto di mera “discussione”, ma bisogna capire cosa sta avvenendo nella nostra esperienza, ora. È partendo da un’esperienza che tocca il nostro presente, che si può capire quella proposta.
Qualsiasi significato della vita – quello che potremmo chiamare l’ideale della vita – o è qualcosa che la vita ci dà, oppure non vale, è una cosa astratta; un ideale deve esserci restituito dalla vita e nell’esperienza perché sia vero per noi, altrimenti rimane qualcosa che sarebbe anche bello se si avverasse, ma che intanto non c’è.
E invece voi ci siete, come ci sono io – e questo non è un fatto scontato. Non siete semplicemente una platea cui devo ricordare delle cose (sarebbe imbarazzante per me e noioso per voi): il fatto è che in questo momento, come quando voi entrate in classe, accade qualcosa. Accade che ci rendiamo conto di quello che c’è nella nostra esperienza e non diamo per scontato, come i due pesci che nuotavano nell’acqua, che cosa sia l’acqua. This is water[3], questo è il titolo di quella conferenza che vi invito a leggere: è un’esperienza straordinaria.
Ora, tutto inizia in uno sguardo, come dice il titolo della convention di quest’anno. Io mi sono chiesto: questo richiamo di don Giussani, di Carrón, in che modo è operativo nella nostra esperienza, in che modo ci permette di capire quello che ci accade? La prima cosa che mi ha colpito è che io posso guardare, io posso avere quella cura delle persone, come diceva benissimo Giorgio Chiosso[4] e come ci hanno testimoniato in maniera straordinaria gli insegnanti che sono intervenuti. Mi sono chiesto mentre parlavano: che cosa rende possibile loro guardare così i ragazzi? Perché – come abbiamo ascoltato – un insegnante, di fronte all’autogestione nella scuola organizzata dai ragazzi, invece di dire: “Questo è il solito rito, me ne sto in aula professori...”, decide di mettersi in gioco?
Vorrei rischiare questa domanda di fronte a queste esperienze: non dire semplicemente “che bello”, ma chiedermi che cosa ha permesso loro di farle. Tante esperienze che incontriamo sono belle, però l’aspetto più interessante da capire è che cosa le rende possibili, perché è solo questo che permette di fare un passo anche a me che le ascolto. Magari non avrei avuto la stessa idea di fronte a quella circostanza... non perché sono meno bravo e meno intelligente, ma perché loro si sono accorti di quello che stava accadendo nella loro esperienza e non lo hanno dato per scontato.
Allora, se dovessi dire per me, che tutto inizia in uno sguardo, significa che io sono stato guardato. Ciò che è determinante, all’inizio, non è la mia capacità di guardare i ragazzi, come i miei figli o le vicende della vita, con uno sguardo che mi invento io, perché io non sarei neppure capace di inventarmelo. Lo sguardo è un talento naturale, è una capacità, è una competenza naturale, come vedremo tra un attimo, ma anche da un talento naturale – se penso a me, ma credo sia un’esperienza vissuta da tutti – noi tendiamo a decadere. Quindi anche la capacità naturale tante volte si offusca: essa piuttosto “accade”, nel senso che è accesa e viene continuamente ripresa, perché uno è stato guardato. È stato guardato, ha visto uno sguardo su di sé, ha fatto l’esperienza di essere “oggetto” di un interesse, di una cura, sin da quando suggeva dal seno della propria mamma, fino al momento in cui, per esempio (come abbiamo ascoltato), un’ex alunna che viene a sentirti, dice: “Professore, potrebbe venire anche dai miei ragazzi disadattati?”. Quell’alunna è stata colpita da come l’insegnante ha fatto una proposta; ma anche l’insegnante, immagino, sarà stato colpito dallo sguardo di lei. L’essere guardati è un’esperienza che viene sempre prima del guardare, e non ci sta semplicemente dietro, nel passato, perché riaccade continuamente. Vedere e farsi vedere, anche dalla persona da cui meno ce lo aspetteremmo, come l’ultimo ragazzino che è arrivato in prima superiore e che mi guarda in una certa maniera, con una certa attesa nello sguardo.
Insomma tutto comincia da uno sguardo perché la realtà mi guarda attraverso gli occhi di qualcuno, attraverso la cura di qualcuno. Questo non è un mero richiamo edificante o consolante, ma è un principio epistemologico del nostro lavoro: da quale postura noi guardiamo il mondo. Perché il problema del nostro stare al mondo, anche nel mondo della scuola – o meglio nel mondo che è la scuola – non sta innanzitutto nel fatto che dobbiamo mettere a punto strategie per risolvere certi problemi che ci condizionano, ci limitano, a volte ci costringono, ma piuttosto nell’essere disposti a lasciarci toccare, muovere, a volte ferire dalla realtà.
E la realtà ci può ferire solo quando passa attraverso uno sguardo, non avviene mai meccanicamente. Questo non vuol dire affatto negare o sottovalutare i condizionamenti gravi del mondo della scuola (e comunque del mondo tout court): condizionamenti ambientali, interpersonali, “ministeriali”. Il punto è come li guardiamo, cioè la nostra “postura”, cioè se abbiamo la capacità di intelligenza, non per dire “Tutto va bene”, perché no, non va bene affatto: ma nel “Non va bene tutto” la differenza è come io guardo quel “tutto”... Perciò io dico che il modo più interessante di verificare e di rispondere alla provocazione lanciata da Julián Carrón lo scorso anno – e che permane anche quest’anno – è capire come essa sia “operativa” nel descrivere la nostra esperienza.
A tal fine vorrei ritornare su un’osservazione di don Giussani ripresa da Carrón, secondo cui la nostra coscienza originaria... – cioè la nostra dotazione naturale, il nostro talento, la nostra competenza come esseri umani – ...non agisce se non dentro la forma di una provocazione.
Noi siamo “competenti” nel guardare il mondo, siamo capaci di conoscere la realtà, ma tante volte questa capacità è come non attivata, tant’è vero che essa viene fuori, si riattiva, quando qualcuno ci guarda, quando ci imbattiamo in un certo sguardo, e allora ci rendiamo conto di esserci persi tante cose... La nostra coscienza originaria agisce solo nella forma di una provocazione, vale a dire dentro una modalità in cui è sollecitata.
Questo è straordinario a livello di metodo, nel senso che noi abbiamo questa competenza, ma l’aprirci alla realtà e accusare il colpo delle cose è l’unica possibilità, la provocazione è l’unica possibilità per sollecitare, per mettere in moto quella coscienza. Invece normalmente noi diciamo: “Dovrebbe essere in un’altra maniera”; così appiattiamo, riduciamo la coscienza; dicendo: “Dovrebbe essere così, ma non è” ci fermiamo all’analisi e al lamento. Come una cosa dovrebbe essere (ma non è...) è in fondo un valore astratto.
Invece paradossalmente (è un tema assai caro ad Hannah Arendt) la crisi è una chance per capire il problema; la provocazione della realtà è la modalità con cui noi possiamo essere noi stessi, anche qualora il nostro rapporto con la scuola fosse difficile. Non sto dicendo che dobbiamo far finta sentimentalmente che la realtà della scuola sia bella così com’è! Per molte persone essa implica piuttosto un peso che ci fa fare fatica. La scuola – ma lo stesso si potrebbe dire di altri lavori, della famiglia, dei figli, della realtà intera – è spesso un peso. Ma anche in quel caso, o proprio in quel caso, essa è una modalità di provocazione. Perché è un peso? Esattamente perché ci fa capire il problema che ci portiamo addosso, il problema del vivere.
Naturalmente noi possiamo fermarci al peso senza vedere la domanda che esso ci pone, la sua provocazione (che è il fondo vero del “problema”). Ma si tratta di una fatica non inutile, di un lavoro per scoprire la positività e la bellezza del mondo.
Questa era la prima questione che volevo porre alla nostra attenzione, cioè che l’utilità del nostro radunarci, è come una verifica dell’esperienza reale che stiamo facendo, senza sconti e senza censure, ma al tempo stesso disponibili ad ascoltare e ad accogliere la domanda provocata dalla realtà. A che vale ripetere quanto sarebbe bello che cambiasse la scuola o, nei casi più sinceri, che noi riuscissimo a fare delle cose belle nella scuola? È più interessante prendere coscienza di quello che ci sta accadendo nella scuola, non soltanto nei casi eccezionali, ma anche qualora ci fosse una aridità, o una problematicità, una fatica del vivere questo impegno a scuola, perché anche quello è provocazione, anche quello ci aiuta a capire di più che cosa noi possiamo mettere in gioco nell’esperienza, che cosa ci chiede quello che sta accadendo.
Nella seconda parte del mio intervento potrebbe sembrare che cambi registro, passando da una reazione personale o esistenziale a quello che ci ha suggerito Carrón, alla considerazione di alcune problematiche che agitano il dibattito sulla formazione e sulla valutazione dell’apprendimento nelle nostre scuole. Ma ciò che vorrei mostrare è proprio in che modo il contraccolpo dello scoprire nella nostra esperienza quello a cui la realtà ci provoca ci fornisce il metro di giudizio per valutare l’immagine di scuola che nei dibattiti contemporanei viene sempre più fuori.
Per esempio sul problema tra le cognitive e le non cognitive skills, tra le competenze cognitive e le non cognitive di cui si parla da tempo, a partire da Heckman[5] o, come altri dicono, sul rapporto tra flourishing e enhancement cioè tra la fioritura personale nell’apprendimento e il potenziamento disciplinare. Allora vorrei brevissimamente ripercorrere la posta in gioco: mi sembra che in questi dibattiti, che poi, al di là della teoria pedagogia, arrivano fino a determinare gli obiettivi e i programmi, le strutture, le architetture disciplinari, noi ritroviamo la stessa posta in gioco del nostro rapporto con la realtà. Perciò è interessante andarci a vedere dentro. Come sapete, una delle cose più interessanti e sfidanti (ma spesso anche tra le più problematiche) nelle teorie e nelle pratiche odierne riguardanti l’educazione e la formazione, è il ruolo centrale occupato dai filosofi cognitivisti, dai neuroscienziati e dagli economisti, perché si tratta di un fenomeno – il capitale umano – che si può misurare, che si deve valutare, attraverso il nesso tra l’educazione che si riceve nella scuola e la capacità performante che si avrà poi nella società.
Quindi, se volete, è un discorso molto secco, molto scabro, per nulla edificante, che nasce da certi interessi di efficienza sociale, di investimento sociale, anche come politiche governative, nella formazione e nell’educazione.
L’idea appunto del Premio Nobel Heckman, che ha avviato tantissime discussioni, è che l’educazione scolastica non può essere raggiunta solo soddisfacendo certe competenze conoscitive, cioè con l’acquisizione di certe nozioni disciplinari, appunto le cognitive skills, ma deve permettere anche (o soprattutto) l’acquisizione delle non cognitive skills, quelle competenze non cognitive che gli addetti ai lavori chiamano spesso the big five, i cinque indicatori, quali l’estroversione (cioè la capacità di relazionarsi ad altri), l’amicalità, la coscienziosità, la stabilità emotiva e l’apertura mentale.
Attraverso delle rilevazioni statistiche si è visto che, alla fine di un certo ciclo scolastico, a parità di acquisizioni nelle competenze cognitive, erano più performanti studenti in cui erano maggiormente presenti queste competenze non cognitive, dette anche “emotive” o “relazionali”, o “socio-culturali” o “comportamentali”.
Si tratta di competenze trasversali che non sono oggetto di insegnamento di una disciplina specifica, collocata accanto alle discipline classiche di matematica, italiano, inglese ecc., ma che attraversano tutti i saperi categoriali, mirando a formare niente di meno che il carattere della persona.
L’idea è che l’obiettivo dell’educazione scolastica sia l’auto-realizzazione della persona. L’ideale formativo del flourishing, è che ciascuno (secondo una vecchia, grande idea aristotelica) deve compiere se stesso. Ed è senza dubbio un compito affascinante: ciascuno deve realizzare la propria aretè, la propria virtus, la capacità e l’attitudine in cui può dirsi e sentirsi realizzato; ed è evidente che questo non dipende da quanto latino sai o quanti esercizi di matematica sei capace risolvere. Passa attraverso tutto questo, certo, ma è chiaro che è qualcosa di più. È un’educazione che si dovrebbe chiamare, a rigore, educazione personale: non esiste una classe-tipo o in generale, così come è un’astrazione l’umanità in generale; quelli che esistono sono Giovanni, Cristina, Matteo... L’ideale qui non è il generale, ma la formazione dell’individuale. Il grande Aristotele diceva, com’è noto, che dell’individuale non vi è scienza, cioè che vi è scienza solo del generale. E invece a noi interessa proprio la scienza, la conoscenza dell’individuale, anche se necessariamente in senso tendenziale o per approssimazione, perché non si può mai conoscere perfettamente l’imponderabile e l’”ineffabile” del singolo io...
Ditemi se l’ideale (ma anche lo struggimento) di tutti quelli che fanno il nostro lavoro non è forse quello di poter toccare l’individuo, di poter formare quella singola persona, non come un caso dei tanti, ma cercando di provocarlo a capire qual è la sua strada, qual è il suo posto nel mondo, il contributo che lui può dare.
Questa è una tendenza per approssimazione, certo, e qualche volta ci riesce. Ma quando succede? E perché?
Ci succede quando noi, insegnando le nostre discipline (e non necessariamente quelle “umanistiche”, anzi, ma anche quelle più “dure”!), riusciamo a comunicare in che modo siamo impegnati noi stessi con la materia che insegniamo, cioè capiamo noi stessi cosa c’entra quello che insegniamo con il significato del nostro stare al mondo. Cosa c’entra con noi. Per cui può capitare (a me è capitato sorprendentemente diverse volte) che dopo anni un alunno ci dica: quel giorno lì (e si ricorda quale!) ho capito che cosa dovevo fare nella vita. Questo è l’ideale compiuto dell’educazione: scoprire la via per la realizzazione di sé attraverso la provocazione di un altro, che ti fa accorgere di ciò che la realtà e il mondo chiedono (proprio) a te.
Ma accanto a questa educazione del character vi è il “potenziamento” (enhancement) dovuto alle competenze cognitive, i contenuti che si devono “imparare”. A me sembra che il punto veramente interessante sia proprio come possano stare insieme queste due cose. Per questo non ho particolare simpatia per la locuzione non cognitive skills, perché esse, se pure sono “non cognitive” nel senso che non rientrano nei contenuti di una disciplina accanto alle altre, tuttavia costituiscono una formidabile possibilità di conoscere: sono la forma personale della conoscenza. Perciò è ozioso impostare la questione solo come un bilanciamento tra insegnamento di nozioni e formazione di caratteri: per tornare a una delle testimonianze ascoltate prima, la ragazza che ha invitato il suo ex-professore a fare una lezione sull’arte contemporanea con i ragazzi disadattati, in quel momento ha capito finalmente, lei, il senso dell’arte contemporanea.
Ma come possono stare insieme le competenze disciplinari e le competenze trasversali? Secondo me per realizzare questa co-appartenenza o stretta implicazione delle due cose non basta certo proporla come obiettivo nei progetti didattici, perché essa richiede che in qualche modo il contenuto disciplinare diventi oggetto di esperienza, innanzitutto in noi e per noi. Ciascuno di noi lo sa, appunto per esperienza. Anche se, per esempio, insegniamo cose lontanissime nel tempo o apparentemente astratte dall’esistenza quotidiana, il problema non è di attualizzare il passato o di esporre le cose in maniera più accattivante, ma far capire come per noi esse sono un’esperienza: risolvere un problema di matematica, ad esempio, significa fare esperienza dell’ordine del mondo, scoprire che c’è una sensatezza, che c’è una precisione nel mondo, che le cose non sono a caso, o che c’è una corrispondenza tra le parti del mondo... Ma una scoperta di esperienza e di sensatezza la può fare un insegnante di educazione fisica... Non sono cose solo da “ora di religione” o che accadono solo quando spieghi Leopardi o Ovidio. Il problema è che esperienza ne facciamo noi, cioè che gusto abbiamo noi. Come in un felice circolo: se la competenza disciplinare diventa oggetto di esperienza, sarà essa stessa a far fiorire il carattere; a sua volta se il carattere viene sollecitato, guadagnerà un’intelligenza nuova nello studiare le discipline.
Per concludere vorrei fare una sommessa proposta, a proposito di competenze disciplinari e trasversali. Forse ai big five aggiungerei altri due caratteri, competenze insieme cognitive e non cognitive.
La prima è la nostra capacità di mettere in questione le cose, potrei dire la nostra capacità critica, anche se questo bellissimo termine si è un po’ logorato per l’abitudine. Ma cosa significa “capacità critica”? Pensata non a partire da un’idea precostituita o da un’ideologia, bensì dal punto di vista dell’esperienza, avere una capacità critica significa innanzitutto un “mettere in questione”. Forse, azzardando o spiazzando qualcuno, direi che essa si attesta nella nostra competenza di dubitare, nell’esperienza del dubbio. Bisogna aver simpatia per questa parola. Lo so bene che essa è spesso usata come bandiera di una certa prospettiva relativistica e scettica: ma conviene non affrettare il giudizio.
Se la capacità di dubitare, di mettere in dubbio era la prima delle due competenze che aggiungerei al quadro, la seconda è la competenza del desiderare.
Il desiderio è una competenza, non è un meccanismo; il meccanismo è il bisogno. Il meccanismo è che tu avverti un’esigenza, e se hai fame, cerchi di procacciarti il cibo per soddisfarla. Mentre il desiderio è una competenza, cioè fa parte di quella che don Giussani chiamava la competenza originaria, è una dotazione che è enigmatico da dove ci venga. Del bisogno lo sappiamo da dove ci viene, ma del desiderio è problematico. Da dove mai ci viene la competenza propria del desiderio, cioè il fatto che non ci basta mai niente? Il fatto che uno si possa accontentare non è una buona prova del fatto che non è vero che non ci basta niente, perché uno si può accontentare e si rimpicciolisce sempre di più, quindi è la prova evidente che non è un guadagno umano accontentarsi, che è impossibile accontentarsi per un essere umano.
Queste due competenze – mettere in questione e desiderare – io le ho imparate leggendo Cartesio. Cartesio, che è un genio assoluto (uno può essere anche contrario alla sua dottrina, ma non può restare indifferente alla grandezza del problema che pone), aveva identificato l’io come una sfera di puro pensiero (il cogito ergo sum), cioè come una sostanza (res cogitans) che non ha bisogno di nient’altro, neanche del proprio corpo, per cogliere se stessa con piena evidenza. Un io in senso “solipsistico”. Poi però, quando questo “io” comincia ad analizzare le idee presenti nella sua mente, scopre che potrebbe anche averle inventate tutte lui (e quindi tutte le sue idee potrebbero anche risultare ingannevoli o illusorie), tranne una sola idea, innata in noi, e cioè l’idea dell’infinito o di Dio.
Essendo io una sostanza finita – dice Cartesio nella III Meditazione di filosofia prima – non posso essere io stesso la causa di quell’idea, e da ciò necessariamente consegue che io “non sono solo al mondo”. E non vale neanche l’obiezione che l’idea di “infinito” sarebbe in realtà costruita da noi stessi, partendo dall’idea di un essere finito e semplicemente negando i suoi caratteri finiti (così come l’idea di “quiete” sarebbe la negazione dell’idea di moto, e l’idea di “tenebre” la negazione di quella di “luce”). Cartesio afferma invece che la questione sta esattamente all’inverso di quel che si pensa: in me la percezione dell’infinito precede in qualche modo quella di me stesso come essere finito: “In quale maniera infatti sarei consapevole di dubitare, di desiderare, cioè di esser mancante di qualcosa, e di non essere del tutto perfetto, se in me non ci fosse l’idea di un ente più perfetto, paragonandomi con il quale riconoscessi le mie mancanze?”.
È come un’endiadi: dubbio e desiderio sono due termini per dire la stessa cosa. Si dubita perché si cerca la verità, si dubita perché si desidera la verità e quindi il mettere in questione è perché si vuol essere certi, perché si desidera la certezza.
Queste due competenze non possono essere distinte tra loro, vanno insieme perché fanno capire che la posta in gioco del dubbio è il vero, e che il vero ci si dà sempre nella forma di un desiderio.
Una pratica educativa veramente interessante è quella per cui l’insegnante è capace di far venir fuori le domande delle persone, non solo su quello che spiega, ma per così dire la domanda sull’essere, meglio la domanda di essere, di vivere, cioè il “dubbio desiderante”, la messa in questione. Ci deve essere il dubbio.
Non dobbiamo avere paura di esso, perché quando un ragazzo (o un adulto) dice: “Ma sarà proprio così?” o “Sarà proprio come mi hanno detto i miei genitori”, “È vero che la realtà è positiva, cioè che ha un senso?” “Non sarà una fregatura?”, esprime un dubbio desiderante, perché è la forma, impacciata e provvisoria se volete, ma essenziale, di desiderare il vero. Perché il vero possa essere mio, deve strapparci dal dubbio, lo deve attraversare. Se lo nascondiamo come la polvere sotto il tappeto, il dubbio rimarrà sempre al fondo, irrisolto. Il dubbio deve essere posto per poter essere vinto, per poter essere superato. E lo si vince di continuo, mai una volta per tutte.
Ciò che è davvero interessante (e quindi decisivo) nel rapporto educativo è la capacità di far emergere le domande e di abbracciarle, perché se una risposta è vera non chiude mai la domanda ma la abbraccia, facendo sì che quella domanda rimanga sempre aperta. Non è forse questa la cosa più bella delle risposte vere, che ti permettono di continuare a domandare?
_________
L’articolo riprende l’intervento svolto dall’Autore durante la Convention Scuola di Diesse Tutto ha inizio da uno sguardo. La sfida educativa del nostro tempo, Bologna, 22 ottobre 2016
[1] Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione.
[2] http://www.diesse.org/cm-files/2016/09/18/insegnare-oggi.-nuovi-contesti-e-nuove-sfide-(italiano).pdf
[3] Il discorso che David Foster Wallace tenne per il conferimento delle lauree al Kenyon College il 21 maggio 2005 è pubblicato in Questa è l’acqua, Einaudi, Torino 2009. Una trascrizione del discorso si può trovare facilmente in rete (per esempio qui: http://www.tracce.it/?id=266&id2=307&id_n=20058)
[4] Cfr. l’articolo di G. Chiosso in questo numero.
[5] J. Heckman, Formazione e valutazione del capitale umano. L’importanza dei “character skills” nell’apprendimento scolastico, Il Mulino, Bologna 2016.