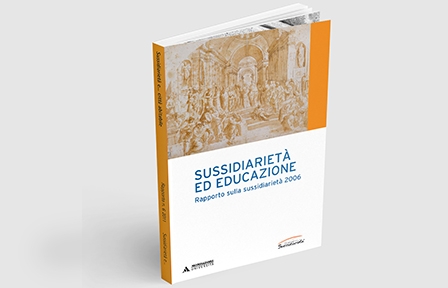Giuseppe Amato Ho assistito incredulo al passaggio dal caldo soffocante dell’estate afgana, parliamo di circa 40-45 gradi, al gelo mordente, al gelo afgano dell’inverno, parliamo di temperature all’incirca di meno 30 gradi. Sono stato impegnato in Afghanistan più volte e vi ho svolto diversi incarichi di comando: ho comandato prima una compagnia, poi un plotone; ho svolto incarichi tecnici e altri che mi hanno visto a contatto diretto con la popolazione del posto.
In particolare, nella mia ultima missione in Afghanistan ho lavorato a stretto contatto con rappresentanti politici, con segretari di ministri afghani, con rappresentanti di organizzazioni internazionali, con lo scopo di elaborare dei progetti che potessero risollevare in qualche modo l’Afghanistan dalla situazione permanente di crisi che stava vivendo. Nel mio percorso quotidiano ho incontrato persone semplici, quelle che io definisco “senza titoli”, ma che hanno una ricchezza interiore che ti lascia stupefatto.
Ancora oggi io mi chiedo spesso: «Giuseppe, ma tu dall’Afghanistan che cosa ti sei portato a casa?» La risposta a questa domanda l’ho riassunta in quattro righe che fanno da epilogo al libro che ho scritto: “Io dall’Afghanistan mi sono portato tante cose: le lacrime di un bambino che piange il suo aquilone, l’orma di piedi nudi impressi nella terra, il profumo del pane, un granello di sabbia intriso di sangue, il calvario di Cristo”.
Ognuno di noi militari che ha servito il Paese all’estero in una missione di pace è tornato a casa cambiato. La vita non è più la stessa e questo avviene perché quello che un militare vive in questi Paesi, in questi posti martoriati, è solo un granello, una minima parte rispetto a quello che la gente del posto vive, respira e sente da sempre; e devo dire che nelle mie tappe afghane il sentimento della paura mi ha accompagnato in modo fedele per tutto il periodo che ho trascorso in quel Paese; così come l’indignazione per la povertà, per le ingiustizie, per i soprusi, per le malattie, per la morte, è stata davvero grande. Spesso mi sono trovato sovrastato da un senso di impotenza per non poter dare di più rispetto a quello che già stavo dando, o non poter fare di più rispetto a quello che già stavo facendo, e i sentimenti che ho provato sono stati molteplici: ho provato angoscia per le sorti di un mio collaboratore afgano, mio coetaneo, che era stato minacciato dai talebani e che dopo un incontro di lavoro è sparito nel nulla, ne abbiamo perso le tracce; ho provato un dolore straziante per la tragica morte di un bambino di 7 anni che procurava da vivere a sé e alla sua famiglia martoriata, vendendo un po’ di tutto in mezzo alla strada e ogni qual volta io passavo da questa strada vedevo questo bimbo e il più delle volte mi fermavo semplicemente per comprare qualcosa e strappargli un sorriso.
Ho assistito, incredulo, a quello che ho definito “il pianto del cielo”, quando in Afghanistan abbiamo dato l’ultimo saluto ai miei commilitoni morti in un attentato, stiamo parlando del 17 settembre 2009. Ma non solo questo mi sono portato dall’Afghanistan; da Kabul mi sono portato l’entusiasmo di un ragazzo mio coetaneo, disperato perché non aveva un lavoro e non poteva sfamare la sua famiglia, davanti a un’offerta di lavoro fatta da un rappresentante di un’organizzazione internazionale che gli aveva appena proposto un lavoro da interprete. La gioia incontenibile di un ragazzo che ha voluto condividere con me la sua prima esperienza di voto: mi ha raccontato tutto, come era andata; e ringraziava il contingente internazionale per avere reso possibile questo, per aver reso possibile questa cornice di sicurezza e quindi alla gente di poter votare liberamente. Mi sono portato dall’Afghanistan il sorriso genuino dei bambini che ti regalavano ogni qualvolta porgevi loro una bottiglietta d’acqua oppure allungavi una penna; addirittura, una volta abbiamo comprato un aquilone nuovo a un bambino.
Mi sono portato a casa l’incontro con i saggi dei villaggi, i cosiddetti malek. Mi sono portato dall’Afghanistan il rito del tè, in ogni occasione di incontro formale o informale; il loro senso dell’accoglienza, la loro apertura verso lo straniero. Mi sentivo quasi a casa quando ero a piedi nudi sui tappeti, seduti in cerchio a prendere il tè. Mi sono portato dall’Afghanistan il piacere di impastare, cuocere e condividere il panjakask – il tipico pane afgano – in compagnia di cinque fornai che avevo appena conosciuto a Kabul e che hanno voluto che io condividessi con loro questo rito: abbiamo impastato insieme il pane, l’abbiamo cotto e, quando stavo per andarmene, mi hanno detto: «No, dove vai? L’abbiamo fatto insieme e lo mangiamo insieme».
Infine, un’altra cosa importante che ho portato con me dall’Afghanistan, che mi fa rabbrividire, è il volto di un bambino che ho incontrato per caso in un ospedale: era seduto su una sedia a rotelle e aveva una coperta che non nascondeva le gambe, ma solo due pezzettini, perché Fazel, questo era il suo nome, era saltato su una mina e aveva perso entrambe le gambe. Per rompere il ghiaccio gli ho offerto delle gomme da masticare e lui ha cominciato a parlare: mi ha detto che era il più veloce del villaggio, che per acchiapparlo c’era bisogno di tre bambini perché uno da solo non bastava. Adesso era sicuro che grazie alle cure di noi militari, grazie alle medicine degli occidentali gli sarebbero cresciute delle gambe ancora più forti e robuste per cui sarebbe diventato imprendibile.
È difficile poter dire tutto quello che ci si porta a casa dall’incontro con queste culture, con questi popoli che hanno semplicemente la sfortuna di nascere e vivere sotto una stella diversa da quella sotto cui viviamo noi. Penso che sia opportuno che un militare che vive queste esperienze le condivida; io sono una persona abbastanza riservata, in più, essendo un militare, la riservatezza acquista un’ulteriore valenza. Al rientro dalla mia ultima missione mia moglie ha scoperto per caso un mio diario segreto. Ogni qualvolta rientravo alla base, io appuntavo tutto quello che avevo vissuto e che avevo visto, perché avevo paura di dimenticare. Quando mia moglie ha letto questi appunti e mi ha chiesto di renderli pubblici io non ero d’accordo, perché in questo diario veniva fuori l’aspetto umano, veniva fuori il Giuseppe uomo e per un militare scoprire la propria parte umana crea un certo imbarazzo. Ma siccome sappiamo che le donne, quando si mettono in testa un obiettivo, alla fine lo raggiungono, questo mio diario non solo l’ho reso pubblico, ma addirittura è diventato un libro: L’eco dei miei passi a Kabul. È stato per me l’inizio di un’avventura inaspettata: dal momento in cui è uscito il libro, tutti i fine settimana vengo invitato a parlare di Afghanistan, soprattutto in scuole dove i ragazzi hanno bisogno di sentire parlare di un popolo così lontano ma così vicino, di sentir parlare di quello che fanno i militari non da un punto di vista tecnico, ma secondo quello che i militari sentono, quello che portano a questi popoli e poi quello che riportano in Italia, ed è una cosa bellissima. Innanzitutto perché ci aiuta a dare rilievo al lavoro di noi soldati, al sentimento di umanità, ai valori che noi italiani portiamo ovunque nel mondo e, soprattutto, riscatta quell’immagine cruenta, crudele, del mondo afgano che per certi aspetti è primitiva, ma che nasconde dei valori molto profondi.
Condividere queste esperienze ci riguarda come italiani, perché è proprio in questi teatri impegnativi che viene fuori il carattere del soldato italiano: un uomo che è pronto a servire la patria senza se e senza ma, un uomo che ha permesso di coniare a livello internazionale il termine “metodo italiano”. Cos’è questo “metodo italiano”? È il cuore, è l’essenza della cultura e delle tradizioni che noi italiani in maniera esclusiva riusciamo a esportare e far apprezzare ovunque, è quel senso umanamente cristiano della vita che ci permette di godere dell’appoggio, dell’amicizia, dell’affetto dei popoli stranieri, anche quando nelle loro terre siamo costretti a girare con mezzi blindati, con un elmetto in testa, con un giubbetto anti proiettile, con un fucile in mano. È difficile da spiegare, ma il metodo italiano è qualcosa che ognuno di noi si porta dentro, che è nel proprio DNA, nella propria cultura.
Queste esperienze ci riguardano come uomini: il contatto con questi popoli semplici, straziati da guerre, lacerati, ci riporta un po’ con i piedi per terra a scoprire la genuinità e ci riporta il senso umano del vivere, che molte volte è anni luce lontano da quello che viviamo noi occidentali. […]
Monica Contrafatto
Io ho soltanto sette anni di servizio, quindi non ho grandissime esperienze all’estero: due in Afghanistan, di cui una durata solo un mese. La prima missione in Afghanistan è stata nel 2009 a Shindand; dopo intense ed estenuanti preparazioni, finalmente potei andare in quel posto a me sconosciuto, di cui tanto mi avevano parlato e che non credevo fosse realmente così.
Ero contentissima, finalmente potevo mettere in pratica ciò che mi avevano insegnato e potevo realizzare il mio sogno, ovvero quello di conoscere nuove realtà e di aiutare una popolazione a me totalmente sconosciuta in un luogo dove la povertà e la fame sono protagonisti assoluti…
Volevo conoscere, aiutare e dare il mio apporto a una popolazione distrutta da decenni di guerre e fame. È difficile trovare le parole per descrivere quello che ho provato. Vi dico soltanto che poco fa ho visto sul monitor un video della base dove stavo in Gulistan e che preferirei in questo momento essere là: mi troverei più a mio agio piuttosto che essere qua a cercare di farvi capire cosa si prova a star là. Comunque è difficile trovare le parole per descrivere la mia esperienza, mi ritornano in mente tanti momenti, come la prima volta che sono scesa dall’aereo e ho visto attorno a me soltanto sabbia, tantissima sabbia e ho pensato: «È impossibile che quello che mi avevano raccontato esista veramente». La prima notte è stata incantata per me: il cielo, le stelle sembravano vicinissime, la luna sembrava che mi abbracciasse…
Quando eravamo di guardia, sentivamo alle prime luci del giorno la popolazione che si svegliava e cominciava a cantare la propria preghiera: faceva venire i brividi. Durante la mia prima uscita avevo molta paura ma la voglia di conoscere era così tanta che quasi non mi rendevo conto di dov’ero; e così ho conosciuto un mondo, una popolazione vasta e desiderosa di conoscerci. Grazie alla mia prima missione, mi sono innamorata di quel posto, non vedevo l’ora di tornarci.
Mi sono innamorata degli occhi dei bambini, di quello che facevano con una pietra: sbattendo due pietre insieme riuscivano a romperle esattamente a metà, un ragazzino ha anche provato a insegnarmelo. Mi ricordo i nostri primi aiuti umanitari, portavamo vestiti, cibo, l’assistenza sanitaria. La gratitudine che vedevo negli occhi degli uomini e dei bambini mi è rimasta nel cuore ed è il motivo per cui continuerei a tornare là.
Dopo sei mesi sono dovuta rientrare e poi dopo altri intensi addestramenti sono ripartita per il Gulistan. Ero contentissima; quando si parte si è coscienti che ti può succedere qualcosa, però al momento non ci pensi perché vivi la vita. Magari la gente che ti aspetta a casa è più cosciente dei pericoli, ma si va per fare del bene, per cercare di costruire qualcosa, per lasciare qualcosa, in modo che le generazioni future possano avere qualcosa in più. Sono state costruite molte scuole, molti ponti, molti pozzi e la gran parte della popolazione ci ha aiutato a non essere attaccati dai talebani; per questo penso che la gran parte della popolazione sia con noi e non contro di noi.
Dopo un mese sono dovuta rientrare perché abbiamo subito un attacco durante il quale è morto un mio collega e un altro è stato ferito. Io ho perso una gamba, ma non la voglia di fare. Dico sempre che a me non hanno tolto la gamba: mi hanno tolto quello che mi piaceva fare davvero, a me piaceva stare in quei posti. Dormivamo pochissimo, stavamo nelle tende, ma io preferivo stare in quelle tende, svegliarmi presto la mattina o dormire poco, ma sentirmi utile, più che stare qua. Spero di essere utile anche qua, ma io ero più il tipo da base avanzata, da militare. Mi sento ancora un militare e spero che un giorno potrò ritornare a fare quello che facevo prima.
Io ritornerei là subito, perché queste esperienze formano il carattere e riempiono l’anima. Il carattere te lo formano perché vivi in condizioni pessime ma belle, perché non hai tutti i comfort; per esempio, durante l’ultima missione in Gulistan non avevamo il cellulare, non avevamo Internet o in misura ridottissima. Comunque vedere come vive la gente ti riempie il cuore, ti fa comprendere come, da una parte, siamo fortunati ad avere tutto, ma, dall’altra parte, come, col tutto che abbiamo, fondamentalmente non abbiamo niente, perché loro con quel poco che hanno riescono invece ad avere tutto.
In realtà non so spiegarvi con chiarezza cosa mi abbia spinto e cosa si provi a stare là. Posso solo dirvi che è faticoso, ma dare il proprio cuore per qualcuno che fondamentalmente non ha nulla e capire di essere rispettato e ricambiato con amore è la cosa più bella che mi sia capitata. Spero un giorno di poterci ritornare.
Luciano Portolano
Vorrei innanzitutto raccontarvi quella che è stata la mia esperienza in Afghanistan e nelle molte altre operazioni a cui ho partecipato.
Prima di tutto però vorrei ringraziare Monica Contrafatto, a lei sono infatti particolarmente legato come persona oltre che come militare. Nel periodo in cui lei è stata vittima dell’attacco proditorio da parte dei talebani, io ero il comandante di tutto il contingente italiano e del contingente internazionale che operavano nell’area ovest, quindi ho vissuto in maniera drammatica le vicende di Monica, del nostro sottufficiale che in quella situazione è deceduto e dell’altro sottufficiale che al momento si trova ancora ricoverato in gravi condizioni. Io ricordo con grande affetto, con grande simpatia e con grande commozione tutti i soldati che hanno agito con me nelle varie missioni in Iran, Iraq, Kuwait, Macedonia, Kosovo e di nuovo in Afghanistan. La recente esperienza in Afghanistan ha rappresentato una missione particolarmente insidiosa e impegnativa rispetto alle altre, sebbene svolta come sempre per contribuire alla ricostruzione di un popolo che oggi si avvia a una maggiore stabilità e sicurezza.
L’Afghanistan è una terra che avevo imparato a conoscere attraverso i libri di scuola, eppure in un periodo particolarmente difficile l’Afghanistan è diventato per me un luogo di incontro e di incoraggiamento reciproco tra noi, i militari italiani, tra i militari degli altri Paesi, con le forze di sicurezza, le autorità governative afghane. Un luogo d’incontro in quello che è il cosiddetto “comprehensive approach” tipico delle missioni internazionali di pace: un approccio omnicomprensivo con i rappresentanti non in uniforme delle organizzazioni governative e non governative, che con noi hanno operato per garantire la sicurezza e successivamente il funzionamento socioeconomico del Paese, ma soprattutto con il popolo di quel Paese che abbiamo imparato tutti quanti a rispettare e a conoscere, lavorando “spalla a spalla”, un termine molto utilizzato ogni volta che gli afghani lavoravano con noi italiani.
Un popolo e una terra alla quale da soldato e da uomo – entità che sono inscindibili in chi indossa una divisa – mi sento oggi ancora più legato, una terra che ha accolto l’ultimo respiro di cinquantatre soldati italiani. Ho parlato dei caduti, ma vorrei ricordare anche i numerosissimi feriti, uomini e donne che non hanno esitato a rischiare la vita nel compimento del loro dovere. È doveroso tributare la nostra perenne riconoscenza a questi uomini e donne. Nella mia esperienza di soldato in Afghanistan ho dovuto fronteggiare numerose situazioni particolarmente difficili, complesse e trovare soluzioni o prendere decisioni immediate per la risoluzione di circostanze non facili.
Ricordo le numerose operazioni condotte insieme agli uomini delle allora nascenti forze di sicurezza afghane contro i nemici della pace, contro coloro che la stessa popolazione non esitava a chiamare nemici degli afghani; e questo per contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l’avvio della soluzione del problema afgano, di quello sviluppo socioeconomico nel Paese in generale e in particolare nell’area in cui noi italiani eravamo impegnati e della quale avevamo la responsabilità, ossia nell’area occidentale. Queste situazioni di combattimento, queste situazioni particolarmente critiche, fanno emergere una forza interiore che porta a galla la natura umana del soldato. Questa forza interiore io l’ho individuata nella fede in Dio, per chi come me è credente, o nella fede nelle proprie capacità, nei propri commilitoni, nei propri cari, nella fede che fa compiere dei piccoli gesti per contribuire al soddisfacimento delle esigenze primarie della gente di quel luogo, in condizioni di sicurezza, tenuto conto che queste condizioni costituiscono il fondamento per l’avvio di tutte le attività necessarie allo sviluppo in un’area di crisi.
Sono sempre stato spinto a instaurare un rapporto con le persone del luogo con cui potermi confrontare, a cui chiedere, a cui domandare, con cui dialogare e imparare; si tratta di un approccio che fa riferimento al cosiddetto “metodo italiano”, che rientra nella formazione, nell’educazione, nell’italianità dei nostri soldati, dei nostri marinai, dei nostri allievi, dei nostri carabinieri che sono impegnati in operazioni appartenenti alle nostre forze armate.
In Afghanistan, così come in tutte le altre operazioni che attualmente svolgiamo fuori area, si è lavorato e si lavora tanto per stabilire il dialogo, strumento fondamentale per chi come noi nelle missioni di pace e nelle missioni internazionali lavora per la stabilità, per una società dove tutti possano vivere rispettando la libertà dell’altro. Il dialogo è un elemento essenziale per far diminuire la discriminazione e fare convivere le diversità, anche se in quella parte del mondo regnano e convivono l’estremismo, il fanatismo, il terrorismo e la violenza, che rendono tale approccio non sempre facile.
Per quanto attiene alle mie esperienze, difficilmente riesco a esprimerle; innanzitutto per carattere, ma anche perché difficilmente riesco a trovare le parole adatte a descrivere l’emozione personale del contatto con gli abitanti di quei luoghi e, per quanto riguarda l’Afghanistan, del contatto con i Pashtun, con i Tajiki, con gli Azara, con gli Izbeki, con gli Armeni, siano essi stati rappresentanti della governance o delle forze di sicurezza, siano essi stati leader religiosi con cui abbiamo risolto, grazie al dialogo, enormi problemi legati all’atteggiamento io direi disumano di alcuni non appartenenti a forze armate, non appartenenti a uno Stato, non appartenenti a un’entità, che avevano compiuto dei gesti inconsulti nei confronti dei simboli della religione islamica.
Sono in me vivissime le immagini dell’apparente rassegnazione di quella gente: facce di adulti già logori, duramente provati da periodi di guerra, costanti tormenti, incessanti malattie e miserie, nei quali però si vede la grinta e la tenacia di chi non vuole fermarsi di fronte a nulla. Vivissimo è il ricordo della compostezza degli anziani che ho incontrato a Herat, a Kalenau, a Farah, a Chaghcharan, nei numerosi villaggi incastonati sulle montagne, negli altipiani, nelle valli, dall’area del Mirkan alla Zerkoh Valley, dal Khaki Safed a Bagua, al Gulistan. Incontri volti a una conoscenza reciproca, ma soprattutto a soddisfare le necessità primarie e, una volta soddisfatte queste, a realizzare opere semplici, di immediata fattibilità da parte della popolazione locale: un pozzo, un ponte che colleghi due città, una strada, una rete fognaria. A queste si aggiungevano opere più complesse, quali la realizzazione di infrastrutture, di strutture sanitarie, opere per l’agricoltura – basti pensare che la realizzazione di un pozzo e di un’opera di irrigazione hanno spesso portato a un aumento della produttività locale di oltre il 30%.
Devo ammettere, comunque, che la nostra presenza non è stata gradita da tutti, almeno nella fase iniziale; per altri non lo è ancora oggi, ma il dialogo fa comprendere che le nostre attività vogliono essere un aiuto a costruire un ambiente sicuro, un ambiente stabile e più prospero per il futuro. Il pieno e il totale rispetto delle peculiarità sociali, religiose e culturali delle comunità del luogo, insieme al soddisfacimento reale, concreto, hanno spesso donato alla gente uno spiraglio di fiducia, di vigore verso il cambiamento.
Inizialmente nessuno si sognava di avvisare il contingente italiano e il contingente internazionale che lungo una determinata strada, lungo un determinato itinerario, erano stati collocati degli ordigni esplosivi improvvisati, molti dei quali spesso hanno causato il decesso o il ferimento dei soldati. A seguito del dialogo, di frequente ricevevo gli anziani dei villaggi, che mi avvisavano che in una certa località era presente un ordigno esplosivo improvvisato, una minaccia. Questo vuol dire che il cuore della popolazione locale si era aperto e la nostra operazione non era un “to win the heart and mind”, un vincere i cuori e le menti. Noi dovevamo conquistare i cuori e le menti, ricevere spontaneamente il cuore della popolazione locale e con l’approccio italiano ci siamo spesso riusciti.
A questo lato della medaglia dell’ Afghanistan, caratterizzata da occhi che trasudano spossatezza e fatica di una vita vissuta tante volte in situazioni difficili, in condizioni estreme, si contrappone l’altro lato: il volto di innumerevoli e incontenibili bambini che, con faccine perennemente sporche di fango, esprimono forti emozioni.
Durante una mia visita all’ospedale da campo italiano per incontrare i nostri militari feriti, i militari afghani e il personale afgano civile che si trovava ricoverato in quel posto, era prima di Natale, in quell’occasione vidi un piccolo afgano: non aveva più di 6 anni, era disteso su una barella; aveva un volto molto triste, mi sono avvicinato ed è stato spontaneo dargli una carezza. Quel bambino ha sollevato gli occhi aprendosi in un sorriso di indimenticabile, sconfinata bellezza. Non saprei descriverlo altrimenti. In quel sorriso, nei visi di quei bambini, vi è il futuro. Questi bambini sono il futuro, così come lo sono i nostri bambini: un giorno essi si incontreranno e potranno farlo da amici o da combattenti. Tutto questo dipende da quello che oggi siamo in grado di fare di positivo per la sicurezza, per la pace e per la stabilità internazionale.
Alla luce delle esperienze fatte fuori dal territorio nazionale ma anche in patria, mi sento di dire che con la partecipazione alle missioni internazionali noi soldati, uomini e donne, lavoriamo per la pace, serviamo la pace e la stabilità internazionale e siamo consapevoli del fatto che il nostro impegno in missioni volute dalle Nazioni Unite e approvate dal Governo è finalizzato al ripristino e alla tutela di condizioni di vita degne di un essere umano laddove ce ne sia la necessità. Abbiamo anche la consapevolezza che con la nostra partecipazione alle missioni internazionali proteggiamo il nostro Paese, la nostra bellissima Italia, la nostra Europa, e contribuiamo a garantirne la sicurezza che oggi risente delle condizioni di instabilità e di crisi in aree o in Paesi che possono trovarsi a pochi chilometri di distanza, come nel caso della Libia; nel cuore dell’Europa, come i Balcani; ma anche a migliaia di chilometri di distanza, è il caso dell’Afghanistan, del Libano, della Somalia e del Mali, dove noi operiamo per ristabilire la pace, per lo sviluppo, assieme ai partners europei e internazionali.
Gli interventi sono stati pronunciati nell’ambito dell’incontro «Sicurezza ed educazione nelle missioni di pace», svoltosi durante il XXXIV Meeting per l’amicizia fra i popoli, Rimini, 21 agosto 2013.