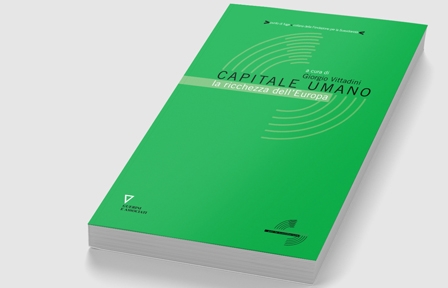Education, sostenibilità, mobilità, innovazione, lotta alle disuguaglianze. Per l’autore dell’articolo, sono i cinque elementi decisivi per un’Europa che vinca il pessimismo e motivi i suoi cittadini a guardare avanti
La mia introduzione al tema “Perché l’Europa non cresce più” vuole aprire e provocare la discussione. Se devo ragionare in termini di provocazione mi viene da dire che l’Europa sta vivendo il paradosso delle tre P: noi non abbiamo mai avuto, come in questo momento, la compresenza di tre P così diverse tra di loro. La prima P è la pace, tema che, in realtà, non scatena oggi le emozioni di un tempo. In qualunque riunione si vada a parlare di questo tema, nel giro di 20 secondi la gente comincia a farsi i fatti propri col telefonino: è talmente dato per scontato che non ci sarà più la guerra, che non soltanto non si riconosce tutto quanto accaduto per arrivare a questo punto, ma soprattutto si pensa che non sia di nessuna utilità fare alcunché in favore. È vero che non c’è mai stata nella storia dell’umanità una fase così lunga di pace all’interno di questo continente, ma anche oltre il nostro continente. Grazie all’Europa, attorno al continente, si è cercato di sviluppare percorsi positivi: è paradossale questo successo incredibile. Mai è stata una P così. Pace. Ovviamente parlando di crescita, la pace è fondamentale. Per definizione, non si cresce in guerra.
Seconda P: prosperità. Non c’è mai stato un momento di maggiore prosperità oggettiva nella vita dei popoli europei. Uno potrebbe obiettare: “Ma abbiamo avuto la crisi; siamo scesi, non siamo saliti di livello”; il mio è un ragionamento collettivo, prendo l’Europa in quanto tale, mettendoci insieme tutto.
Immaginatevi la Polonia 20 anni fa e oggi. Chi l’ha frequentata lo sa. Grazie Europa! Io cito sempre questo dato (prosperità vuol dire reddito procapite, ma anche altre cose). Pensate cosa ha significato per i due Paesi pilastri del mondo comunista europeo, Ucraina e Polonia, Paesi che al momento del crollo del muro di Berlino nel 1989, avevano gli stessi dati sulle due questioni essenziali di vita della nostra società: la differenza tra vita e morte. I dati erano sulla speranza di vita e sulla mortalità dei bambini; I due Paesi avevano lo stesso dato, molto lontano dai nostri criteri. Una mortalità infantile molto più alta della nostra e una speranza di vita molto più bassa della nostra. La Polonia è entrata nell’Ue, l’Ucraina no. Oggi, se prendete il dato di mortalità infantile e la speranza di vita di Polonia e Ucraina, i polacchi si sono avvicinati ai nostri (pochissimi bimbi morti e si muore molto più tardi), mentre l’Ucraina è lontanissima da quei dati.
Due Paesi che erano uguali, eppure uno è salito sul trono europeo, l’altro no. In questo senso, prosperità vuol dire reddito procapite, significa vivere e vivere bene. È incredibile il grado di prosperità media collettiva che noi stiamo sperimentando in questo periodo. La prosperità è associata a tante questioni, mi sembra evidente.
Al contempo, l’Europa, campione di pace e prosperità, lo è anche di pessimismo, la terza P.
C’è una grande contraddizione tra questo momento di maggiore pace e prosperità mai vissuto e, anziché essere ottimisti per esser arrivati qui, il fatto che sia anche il momento di maggior pessimismo.
Dovendo andare a vedere perché l’Europa non cresce più, la risposta è, in termini generali, la contraddizione tra questi 3 fattori, con declinazioni poi molto concrete.
Pace, prosperità e pessimismo caratterizzano la vita che stiamo vivendo in Europa e hanno una serie di conseguenze molto concrete. Col pessimismo non si guarda avanti, ma indietro. Se io penso oggi a una serie di politiche europee, alcune di queste, sia nazionali che europee, sono fatte con lo sguardo rivolto indietro. Ne prendo due: una riguarda la politica particolarmente importante di uno dei maggiori Paesi europei, l’altra è una delle politiche economiche più importanti di tutte. Parto dalla seconda: la politica della concorrenza a livello europeo. L’Europa ha avuto, da questo punto di vista, una delle intuizioni più geniali: costruire un mercato unico con regole di concorrenza che hanno spinto la competitività delle imprese. Noi consumatori per decenni abbiamo goduto di tutto questo: pensate cosa significa per noi, consumatori italiani, che vivevamo dei monopoli. Questi monopoli sono stati rotti grazie all’Europa, non grazie alla tecnologia. In realtà la gente pensa che sia l’evoluzione tecnologica che ha portato a far nascere Vueling, EasyJet, i telefonini con cinque5 diverse opzioni di operatori… Ma in verità sono scelte politiche, perché prima del mercato unico c’era il monopolio dei voli, degli operatori di telefonia e così via.
Pensiamo cosa ha voluto dire la concorrenza per noi consumatori e per la competitività del sistema. Ma la concorrenza era pensata e costruita in un mondo sostanzialmente eurocentrico. Quindi l’obiettivo principale era limitare le fusioni, non spingerle. L’obiettivo principale di qualunque commissario europeo alla concorrenza, di qualunque direttore generale della DG Concorrenza, era quello di lavorare per bloccare le fusioni, perché queste ultime avrebbero voluto dire una situazione pre-monopolistica o di dominio sul mercato. Questa è la storia dell’Ue. Un grande vantaggio per ognuno di noi, peccato che nel frattempo, negli ultimi 10 anni, il mondo sia totalmente cambiato e oggi imponga una nuova strategia sul tema della concorrenza, che deve sapere – accanto all’esigenza di tagliare, limitare e aiutare la competitività locale, domestica – ragionare in termini globali. Infatti, limitando unicaente la crescita globale delle imprese, si finisce per ritrovarsi oggi in un mondo in cui il proprio concorrente non è dentro l’Europa, ma sempre, regolarmente, fuori. È cinese, americano, coreano. Se si ha una politica di questo tipo è evidente che l’effetto è terribile; il pessimismo nasce anche da questo.
Stiamo andando avanti secondo una logica d’inerzia, su delle regole legate a un mondo che non c’è più. Questo porta ai limiti, per esempio, della grande operazione dei trasporti che avevano tentato francesi e tedeschi, Siemens-Auston, bloccata dall’Ue e dalla commissione europea, dalla DG Concorrenza. Queste politiche e queste scelte sono tipiche di chi, con un impianto direttamente legato a questa contraddizione di pace, prosperità e pessimismo, guarda indietro anziché avanti. È ovvio che, pur guardando avanti, il concorrente rimane sempre coreano, cinese o americano... ma nasce la necessità di pilotare delle strategie di fusione a livello globale (sto ovviamente parlando dei grandi operatori mondiali della cantieristica, delle telecomunicazioni, dei trasporti) e se non si va in questa direzione non ce la si farà mai.
Questo tocca moltissimo anche la questione dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico. Noi già oggi abbiamo perso dei treni legati a questa logica, giocando su mercati troppo piccoli, limitandoci ai 28 mercati nazionali. Quello dell’innovazione tecnologica, applicato alle telecomunicazioni è uno di questi: in ogni assemblea se si chiedeva, 10 anni fa, chi aveva il telefonino di marca europea, 1/3 della sala alzava la mano, oggi, alla stessa domanda, nessuno la alza e ci si divide in tre gruppi: americani, cinesi e coreani. Noi, in tutto questo, non ci siamo. Questa è una delle questioni che, secondo me, lascia veramente esterrefatti rispetto a questa nostra incapacità di guardare in prospettiva.
Quali sono le chiavi per cercare di modificare questa logica e di trasformare il pessimismo in uno sguardo lungo e in ottimismo? Ottimismo legato al fatto che il mondo come si sta costruendo non è fatto solo di minacce per noi europei e per la competitività europea, bensì è fatto in gran parte di opportunità. Il mondo come si sta sviluppando, ci sta consegnando una dimensione completamente diversa da quella con cui ci siamo confrontati quando l’Europa è stata costruita, è un mondo in cui sta crescendo a dismisura una classe media europea che ha fatto fortuna dieci anni fa. Oggi si apre nel mondo una dimensione di classi medie emergenti che tengono e possono tenere in vita la competitività dell’Europa da tutti i punti di vista: dei servizi, dei beni, strumentali e di consumo. Gli esempi sono tantissimi, il mondo vuole marchi europei. Il mondo vuole vivere con il racconto di cosa produciamo e di cosa siamo noi europei.
Aggiungo la grande minaccia di Trump all’Europa: “Voi producete molto più di quello che consumate e vivete di questo gap”. È vero, noi viviamo di questo gap. Se dovessimo produrre quello che consumiamo sostanzialmente saremmo in ginocchio. Noi europei, e noi italiani in particolare che, insieme ai tedeschi, siamo la grande industria manifatturiera d’Europa e i grandi poli esportatori d’Europa. È evidente che questo attacco al nostro modello deve vedere, da parte nostra, una reazione che deve essere di operare perché nel mondo il protezionismo non vinca e ci sia una possibilità di vivere su scala globale con mercati aperti. Il commercio libero aiuta noi europei.
C’è bisogno di un grande lavoro di leadership e culturale. Invece, non sempre questo messaggio è visto positivamente in casa nostra, anzi spesso viene visto con una certa paura e preoccupazione. Contestualmente abbiamo bisogno di cambiare alcune regole fondamentali. Ho citato il tema della concorrenza e non vado oltre, mi sembra che sia chiaro: noi abbiamo bisogno di unire a una politica di concorrenza (che ovviamente rimarrà in Europa), una politica industriale che costruisca dei campioni europei in grado di vincere a livello mondiale una partita che, invece, oggi stiamo perdendo un po’ su tutti i fronti e, se continuiamo così, questa perdita su tutti i fronti sarà veramente molto rischiosa. Questo però riguarda anche la politica.
Ho citato prima due esempi: uno questo della concorrenza, l’altro quello della Gran Bretagna. La Brexit significa esattamente scelte politiche fatte con l’occhio rivolto all’indietro, cioè al mondo com’era prima, quando la Gran Bretagna aveva una sua dimensione tale da potersi concepire da sola. Oggi la Gran Bretagna (ma lo stesso potrebbe valere per l’Italia, la Francia, la Germania) stando da sola, non ha nessuna capacità di sopravvivere nel mondo di domani, dove la Gran Bretagna sarà come l’Olanda della metà del secolo scorso. Stesso discorso per noi, cito l’Olanda perché la dimensione è quella. Il mondo in cui Cina, Corea e Giappone saranno il 50% dell’economia mondiale, il peso relativo della Gran Bretagna sarà lo stesso che aveva l’Olanda quando nel mondo c’erano 3 miliardi di persone, se sta da sola. Queste sono le dinamiche e questo stesso discorso potrei farlo per l’Italia. Quindi, il tema di fondo è capire come riusciamo a raccontare il percorso dell’Europa in una logica positiva e quindi dobbiamo rompere il tema del pessimismo, facendo scattare un meccanismo d’orgoglio e di utilità, attraverso non solo i discorsi classici “in bianco e nero” e “con la forfora” che facciamo spesso quando parliamo d’Europa, ma cercando, invece, di svilupparli sulla questione dell’innovazione e delle nuove tecnologie.
Per esempio, una questione che mi colpisce sempre molto è quella della guerra d’influenza sulla protezione dei dati, che sarà la grande partita del futuro. I dati presenti nei nostri telefonini e device sono i dati su cui in futuro si combatterà; chi li userà appropriandosene? Muovendosi tra filosofie diverse: gli americani per la deregulation totale e i cinesi invasivi perché così controllano i cittadini e noi che siamo per la protezione dei diritti della persona. Tutto questo passa anche per una cosa, il telefonino, che prima c’era solo per telefonare, mentre adesso è di fatto la nostra carta d’identità. E la mia identità non è solo la mia persona, ma ce n’è anche una nel mio cellulare, quello che c’è qui dentro è utilizzabile da qualcuno per il bene ma anche per il male.
Attorno a questo tema, per esempio, dovremmo scatenare la capacità di noi europei di combattere la buona battaglia per la protezione di quella che è la nostra identità, sapendo che questo è un disegno tipico di noi europei, non condiviso né dagli americani, né dai cinesi, i quali hanno un approccio totalmente diverso: i primi sono molto più puntati sull’hi-tech e la competitività dell’industria tecnologica e lo sono meno sulle regole da imporre per la protezione dei dati, mentre gli altri sono immersi in una logica invasiva.
Ho cercato di raccontare come questa logica dell’Europa che non cresce più, sia una logica che tocca profondi motivi di psicologia collettiva (ho citato il pessimismo) e come la logica del futuro e di uno sguardo diverso su di esso debba toccare aspetti che normalmente non abbiamo mai associato all’Europa. Cito questo esempio dei dati personali: è una cosa nuova, dobbiamo lavorarci sopra. Ma chiunque, dopo i disastri successi, comincia ad avere paura che i suoi dati siano utilizzati malamente e l’Europa diventa l’elemento che ci garantisce nel mondo, questo è il fattore fondamentale.
I 5 elementi di un ragionamento su un’Europa che vince questo pessimismo e motiva i propri cittadini a guardare avanti sono:
education, che non è mai stata una questione europea, ma sempre nazionale: i Paesi membri hanno dovuto ottenerla da sé ed è entrata nelle dinamiche europee soltanto dalla porta di servizio dell’Erasmus che, però, è una cosa minima, per minoranze di studenti universitari, non una cosa per tutti;
sostenibilità
mobilità
innovazione
lotta alle disuguaglianze
Queste sono le 5 questioni del futuro, rispetto alle quali sappiamo tutti benissimo che una dimensione solo nazionale non ci darà i risultati che il singolo vuole ottenere, mentre, invece, una dimensione comunitaria insieme agli altri ci darà la forza su tutti e 5. Sono, tra l’altro, i temi sui quali si riescono a mobilitare le giovani generazioni e le energie fino a ieri ferme.
Queste sono una serie di provocazioni e non delle risposte burocratiche, perché l’esperienza che sto facendo in questo periodo mi porta a fare ponti tra settori diversi.
Il futuro è fatto di ponti disciplinari, nel quale si lavora per evitare che le persone siano com’erano negli anni Ottanta e Novanta: monodisciplinari, ognuno nel suo solco di studi, occupandosi solo di quello. Sapete benissimo che voi oggi cercate soprattutto curricula e persone in grado di vivere questa capacità di fare ponti e non limitarsi a essere incastonati in una sola competenza. La sola competenza è sicuramente utile, ma riuscire a tenere insieme settori e competenze diverse con la flessibilità oggi necessaria è sicuramente la grande novità.
L’intervento ha avuto luogo durante il workshop intitolato “Perché l’Europa non cresce più?”, organizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà a Milano il 22 marzo 2019.