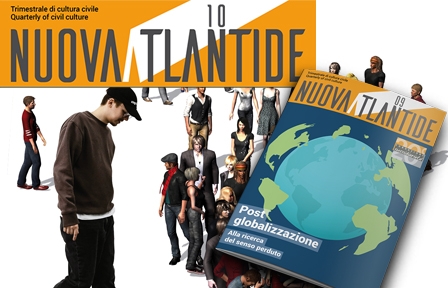La deglobalizzazione conflittuale ha fatto allargare il fossato tra il mondo delle democrazie e i regimi autoritari. Il caso più eclatante: la via della seta versus la formazione di un’area mercantile e politica sotto l’ombrello statunitense. Una situazione comunque fluida, non monolitica. Come dimostrano alcuni passaggi cruciali che hanno cadenzato, perlomeno nell’ultimo decennio, le mosse dei principali soggetti. Vedi la minor dipendenza economico/commerciale dell’area G7 (anche allargata) in primo luogo dalla Cina. Tra i due blocchi (ciascuno vale circa 1 miliardo e mezzo di persone) che si contrappongono avrà vantaggio competitivo quello che saprà essere attrattivo nelle politiche di reclutamento nei confronti di quella vastissima area grigia che assomma circa 5 miliardi di persone. Una prova importante e decisiva per le democrazie nella partita a scacchi della riglobalizzazione selettiva. Tenuto conto che, allo stato delle cose, né USA né Cina hanno interesse ad alzare la tensione fino al punto di un loro aperto scontro militare.
Nel 2013 chi scrive avviò un programma di ricerca continuativa titolato: “deglobalizzazione conflittuale e riglobalizzazione selettiva”, anticipato dal progetto Nova Pax avviato negli Anni 90 e pubblicato in Inglese (2007) e in Italiano (2006) nel libro “La grande alleanza” (Franco Angeli). Nel febbraio 2013 l’Amministrazione Obama lanciò due progetti di mercato integrato: uno verso l’area del Pacifico (Tpp) che includeva 12 nazioni e l’altro in forma di trattato bilaterale con l’Ue (Ttip). Ma ambedue escludevano Cina e Russia. Ciò fu un chiaro segnale che il mercato internazionale fino ad allora “globale” avrebbe avuto un confine tra mondo delle democrazie e regimi autoritari. Infatti il centro strategico di Pechino reagì immediatamente lanciando il progetto di Via della seta come risposta simmetrica alla formazione di un’area di mercato e politica americocentrica. La Russia cercò di sabotare il Ttip influenzando la Germania anche con cattive maniere e stimolando il sovranismo latente di Parigi in funzione antiamericana.Forse la decisione di invadere la Crimea ed assorbire i territori del Donbass nel 2014 fu conseguenza indiretta di una ri-convergenza euroamericana molto temuta da Mosca. Nei fatti, il progetto Ttip restò incompiuto nel 2016 perché i negoziatori statunitensi non avevano colto del tutto la complessità europea e quelli europei furono frenati da Francia e Germania. L’Amministrazione Trump ritirò l’America dal Tpp con il motivo che preferiva accordi economici e politici bilaterali con le nazioni del Pacifico per essere sicuro che i flussi commerciali fossero (ri)equilibrati e non penalizzassero l’America. Non interruppe formalmente il Ttip, ma lo mise nel cassetto. Tuttavia, la tendenza verso la deglobalizzazione conflittuale si inasprì: nel 2017 il Congresso statunitense votò con maggioranza bipartisan l’indicazione che la Cina era un nemico.
Questa fu una grande svolta: dal 1996 - ma con precursori dal 1973 - negli ambienti politici ed industriali-finanziari statunitensi prevaleva l’idea che ciò che andava bene per la Cina fosse anche un vantaggio per l’America. Ma l’evidenza del dumping cinese, dei furti di tecnologia e della competizione di Pechino per l’influenza in Africa e Sudamerica, iniziata con più forza nel 2007 quando l’Amministrazione Bush era distratta dalla priorità di gestire la guerra in Iraq ed Afghanistan, fecero cambiare nel 2016-17 la postura di Washington verso Pechino: dazi, contenimento e nemicizzazione.
Nei confronti dell’Europa l’Amministrazione Trump fu molto dura, in particolare verso la Germania campione di export in America, dipendente dalla Russia per l’energia e dalla Cina per i flussi commerciali. Fu molto dura anche nei confronti della Nato, a stento salvata dai funzionari della burocrazia imperiale statunitense perché si rendevano conto che senza gli europei il potere statunitense globale sarebbe stato amputato ed avevano mezzi per osservare il tentativo sia russo sia cinese (ai tempi non coordinato) di staccare l’Ue dall’America. Nell’ultimo anno dell’Amministrazione Trump l’americanismo fu ridotto dalla conduzione del Segretario di Stato Mike Pompeo che ricucì le relazioni nel G7 in funzione anticinese ed antirussa. La tendenza alla deglobalizzazione conflittuale era confermata ed iniziava quella della riglobalizzazione selettiva, cioè della compattazione dell’area delle democrazie contro Cina e Russia. Germania e Francia tentarono di salvare in extremis nel dicembre 2020 un trattato economico con tra Ue e Cina, che premeva quasi disperatamente per ottenerlo, ma l’Amministrazione Biden appena eletta fece pressione per metterlo nel cassetto.
La deglobalizzazione conflittuale si approfondiva, ma la riglobalizzazione selettiva, cioè la formazione di un mercato integrato del G7 entro un’architettura politica di convergenza strategica tra i partecipanti e nazioni affini, era ancora lontana da una strutturazione. L’Invasione dell’Ucraina da parte della Russia provocò una fluttuazione nella configurazione del sistema internazionale: blocco sinorusso – in realtà Greater China – contrapposto a quello delle democrazie guidato dall’America con gli europei in subordine e il Giappone in riarmo. In sintesi, una condizione di guerra sotto soglia, ma che può andare sopra, tra America e Cina con i rispettivi alleati.

Residui e vecchia globalizzazione
Sul piano economico la deglobalizzazione si è svolta finora come riduzione della dipendenza del G7 dal mercato russo e, tendenzialmente, da quello cinese. I flussi da e verso Mosca si sono molto ridotti per l’adozione di sanzioni con scopo di depotenziamento bellico e di destabilizzazione del regime autoritario. Al riguardo della Cina, invece, c’è un blocco tendenziale delle operazioni delle sue aziende nel perimetro G7, l’imposizione di dazi, soprattutto, statunitensi all’export cinese, e il controllo dell’export – gestito da un comitato di coordinamento tra nazioni del G7 e collegate, per esempio l’Australia, che ricorda l’antico CoCom alleato per il blocco delle tecnologie all’Urss durante la Guerra fredda - di tecnologie critiche. Ma l’analisi dei flussi – depurata dalla loro riduzione nel periodo pandemico – mostra che il commercio globale non ha ancora perso volume complessivo a seguito della creazione di un nuovo confine politico con la Cina.
Ciò è dovuto all’applicazione di una strategia flessibile nei confronti della Cina stessa, che è simile in America e nell’Ue: contenimento, competizione e cooperazione, nell’ambito di un “decoupling” economico tendenziale tra America, alleati, e Cina che comunque rompe quel sistema binario sino-americano che ha trainato la globalizzazione dagli Anni 80 fino a quasi il 2020. Probabilmente i flussi aumenteranno entro due zone separate del mercato internazionale, quella sinorussa e del dominio G7 e si ridurranno tra i due blocchi. Il “decoupling”, infatti, è più visibile nel presente come ritorno “a casa” (reshoring) o nell’area alleata (friendshoring) delle produzioni manifatturiere delocalizzate nel passato nella Cina comunista.
La fuga dalla Russia per motivi reputazionali e timore di sanzioni ha riguardato migliaia di aziende dell’area G7 e dintorni. La fuga dalla Cina è più lenta e contrastata, in particolare da parte di aziende tedesche, per la difficoltà di sostituzione delle catene logistiche e del valore. Tuttavia, la tendenza è in atto. Ciò comporta un problema finanziario: la globalizzazione può anche essere definita come acquisto di bassi costi trasformabili in efficienza e più marginalità dei prodotti venduti sui mercati ricchi. La deglobalizzazione porta al rischio di costi più alti di produzione poi trasferiti ai prezzi e, alla fine, all’inflazione. Da un lato c’è ancora molta povertà nel mondo trasformabile in efficienza: per esempio il trasferimento di produzioni dalla Cina all’India o in Vietnam o in altri luoghi dell’Asia. Dall’altro anche in questi luoghi i costi sistemici mostrano, come avvenuto in Cina, una tendenza al rialzo. Pertanto l’industria manifatturiera dovrà trovare efficienza attraverso l’impiego più massiccio di nuove tecnologie.
In sintesi, nello scenario fino al 2040 vedremo convivere un residuo della vecchia globalizzazione che compra povertà per trasformarla in ricchezza ed un’evoluzione rapida delle tecnologie produttive per mantenere margini di profitto elevati pur in aree ad alto costo. Il reshoring ed il decoupling con la Cina, inoltre, sono spinti dal fatto che le delocalizzazioni degli anni procedenti hanno prodotto un impoverimento nelle democrazie che è interesse dei governi invertire facilitando il ritorno del lavoro manifatturiero entro la loro giurisdizione. Un altro interesse correlato è quello di ridurre l’impatto della concorrenza sleale delle importazioni a basso costo, ma questo tende ad essere contrastato dal problema che costi più alti dei prodotti tendono, appunto, a generare inflazione. Pertanto la difesa dei redditi nelle nazioni ricche dovrà trovare un modello di nuovo equilibrio. Gli studi sono in corso, le nuove tecnologie il fattore chiave.
Il confronto scontro tra i due blocchi
Quale tra i due blocchi prevarrà e come? La risposta è multidimensionale. Ciascuno dei due blocchi contiene circa 1,5 miliardi di persone, ma ci sono circa 5 miliardi di persone che vivono in nazioni non allineate, l’area grigia. I recenti comportamenti di queste mostrano la tendenza ad instaurare relazioni di vantaggio con ambedue i blocchi. Pertanto la strategia di influenza sarà costosa.
La fornitura di armi evolute a qualcuna di queste nazioni sarà un fattore di reclutamento, ma per la gran parte il beneficio economico e politico di essere rilevanti per ambedue i blocchi sarà più importante. La Cina ha certo vantaggio per la capacità di fornire manufatti, infrastrutture e risorse critiche, ma il G7 allargato lo stesso e forse di più. Al momento la prevalenza su questo piano non è decidibile. Anche perché mentre il blocco sinorusso ha poche nazioni, ma grandi, e un dominus che è Pechino, il G7 allargato ha difficoltà nel trasformare la sua convergenza politica in mercato integrato dal quale possono derivare più risorse per influenzare le nazioni dell’area grigia e sostenerne alcune chiave per portarle verso la democratizzazione.
Il ritardo nella formazione di un mercato integrato delle democrazie è dovuto ad un problema interno nella politica americana: dopo decenni di impoverimento causato da un eccesso di concorrenza e deficit commerciale (che pur bilanciato finanziariamente ha provocato una deindustrializzazione impoverente) l’elettorato statunitense mostra a destra e sinistra una tendenza protezionista che impedisce ai politici di aprire il sistema ad un vero mercato integrato con gli alleati. Inoltre, la strategia imperiale statunitense ha sempre (dal 1945) preferito avere relazioni bilaterali con gli alleati piuttosto che lasciarli compattare tra loro (modello stellare) e rischiare di essere messi in minoranza nell’aggregato. Tuttavia, pur continuando questa situazione non-integrativa ed escludendo estremismi isolazionisti, lentamente l’America si adatterà alla necessità di un mercato integrato tra democrazie (che in parte già esiste).
Ciò fa prevedere un potere maggiore dell’alleanza. Ma ad un altro livello di analisi c’è da osservare il confronto di prestazioni tra capitalismo autoritario e democratico per la generazione e mantenimento del capitalismo di massa. Quello democratico sembra in crisi, ma questa è maggiore nei regimi autoritari in Cina in particolare dopo che XI Jinping, dal 2012 e con più intensità dal 2017, ha voluto riportare l’economia sotto un più stretto controllo del partito, togliendole potenziale. E’ oggetto di osservazione ed aggiornamento, ma la tendenza sembra più a favore del G7 allargato. Così come lo è il potenziale militare. Ora il ritardo cinese nelle tecnologie di superiorità è tra i 15-20 anni. Potrebbe essere colmato più la guerra si sposta verso la robotizzazione e il dominio dell’orbita (che richiede quello del sistema solare). Ma la capacità reattiva delle democrazie le farebbe mantenere il vantaggio, quindi la dissuasione.
Quanto qui ipotizzato ha un raggio temporale tra i 15 e 20 anni. In questo periodo né l’America né la Cina comunista hanno interesse nel correre il rischio di una guerra aperta. Washington punta a ridurre il potere cinese da globale a regionale e tecnologicamente degradato. Pechino punta principalmente a mantenere il potere del Partito comunista, motivo per cui spinge al multipolarismo, ritenendo che tra tanti blocchi regionali poi sarà il più grosso. Ciò è motivo per continuare la compattazione del G7, il suo allargamento ed estensione dell’influenza nell’area grigia.
Non è solo un motivo di razionalità geopolitica (o vince e comanda uno o l’altro, nella realtà), ma anche uno morale: far vincere la democrazia sulle dittature. Chi scrive amerebbe vedere che l’Italia per prima aggiungesse una bandiera delle democrazie (possibilmente una croce su sfondo bianco) accanto a quella nazionale ed europea.