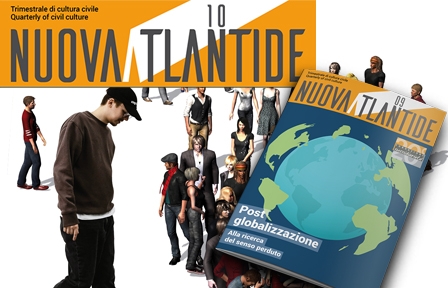Non è facile individuare soluzioni efficaci in un contesto globale di crisi permanente. Laddove si alternano e si sovrappongono crisi climatica, geopolitica, economica, energetica, produttiva, sanitaria e sociale. L’immagine è quella di un mondo in tempesta. In gioco vi è la stessa sopravvivenza dell’uomo sul pianeta. Tutto ciò ha, evidentemente, notevoli implicazioni sulla salute. Che vanno affrontate giocando in contemporanea su tre piani: quello della nostra salute individuale; quello per i nostri sistemi sanitari universalistici e quello per la salute del pianeta. “Si tratta di avere la capacità di immaginare, pianificare e costruire un futuro verso cui non transitare come passeggeri passivi”.
Il mondo è in tempesta. Non è facile individuare, nella storia dell’umanità, un periodo più denso di eventi e di crisi, alcune in grado di compromettere in modo irreversibile la stessa sopravvivenza dell’uomo sul pianeta.
Soltanto negli ultimi anni abbiamo assistito a:
- La peggiore crisi finanziaria dal 1928
- Una recessione globale
- Una crisi di debito sovrano senza precedenti dell’Eurozona
- Scoppio della guerra in Medio Oriente e Nord Africa
- Guerra civile in Siria
- Una grande crisi migratoria in Europa
- Brexit
- L’ondata di cyber-terrorismo (con l’elezione di Trump alle presidenziali americane)
- Tensione nucleare in Corea del Nord
- “Secessione” della Catalogna
- Il primo governo populista in un membro fondatore dell’UE (Italia)
- Guerra commerciale tra USA e il mondo • Pandemia
- Guerra tra Russia e Ucraina
il tutto in un deterioramento ingravescente delle condizioni ambientali e climatiche del pianeta Terra.
Ce n’è abbastanza per parlare di “permacrisis”, uno stato di crisi permanente a cui è difficile trovare soluzioni perché si alternano e sovrappongono crisi climatica, geopolitica, economica, energetica, produttiva, sanitaria e sociale. Quali sono le implicazioni di tutto ciò sulla salute?
Che dobbiamo affrontare tre sfide in contemporanea: quella per la nostra salute individuale, quella per i nostri sistemi sanitari universalistici e quelli per la salute del pianeta.
Corsa verso l’inferno
Comincerei da quest’ultima data la logica preminenza sulle altre due. Senza una Terra in salute non c’è salute per nessuno dei suoi abitanti e, se dobbiamo sintetizzare in una frase il trend in corso, vale la pena utilizzare quella recentemente gridata dal segretario generale delle Nazioni Unite: “Siamo su un’autostrada verso l’Inferno!”.
Tutti i positivi indicatori di sviluppo economico e sociale degli ultimi settant’anni sono stati infatti ottenuti dilapidando le risorse naturali della Terra e alterandone profondamente gli equilibri.
Se abbiamo migliorato in tutto il mondo l’aspettativa di vita alla nascita e ridotto la mortalità e la povertà, lo abbiamo fatto aumentando a dismisura le immissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua e in tutte le matrici ambientali, distruggendo migliaia di specie animali e compromettendo forse definitivamente, la biodiversità.
La crescita dell’anidride carbonica nell’atmosfera dovuta al massiccio uso di combustibili fossili, l’acidificazione degli oceani, l’aumentato uso di acqua, energia e fertilizzanti, la distruzione di intere foreste tropicali, sono solo alcuni degli indicatori di questa cannibalizzazione della Terra.
Il risultato è che abbiamo addirittura, dopo 11.000 anni di Olocene, cambiato era geologica. Per tutti questi anni abbiamo avuto una sorta di giardino dell’Eden in cui le condizioni ambientali erano in equilibrio grazie a una temperatura sostanzialmente stabile (+/- 1 grado centigrado), mentre solo negli ultimi cinquant’anni l’abbiamo fatta aumentare di più di un grado, in Italia addirittura di 2, con ulteriori drammatici aumenti previsti nei prossimi anni, con conseguenze drammatiche che stiamo già sperimentando.
Lo scioglimento dei ghiacci a tutte le temperature sta già provocando la sommersione di milioni di chilometri quadrati di terreno, con milioni di cittadini che stanno diventando migranti ambientali. È già il caso di Paesi come Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Isole del Pacifico, ma l’Europa e gli Stati Uniti sono le prossime nella lista.
Tutto ciò contribuisce a determinare l’alternanza, ormai quotidiana, di eventi estremi: ondate di calore, siccità, incendi giganteschi, bombe d’acqua, che hanno profonde e gravi ripercussioni, acute e croniche sulla salute umana.
15 dei 16 anni più caldi di sempre si sono verificati negli ultimi venti anni, i peggiori tre negli ultimi tre anni e le ondate di calore conseguenti, insieme alla pandemia da Covid-19, hanno provocato milioni di morti, invertendo il trend di aumento dell’aspettativa di vita alla nascita che proseguiva da decenni.
Eccoci quindi nell’Antropocene, una nuova epoca geologica in cui il destino della Terra è esclusivamente nelle mani delle scelte dell’uomo, definitivamente distruttive o in qualche modo salvifiche.
L’evidenza scientifica è ormai eclatante, così come l’apparente incapacità dei governi di prendere decisioni risolute per arrestare questa “corsa verso l’Inferno”. Come dice Tanya Steel, direttrice del World Wildlife Fund, “siamo la prima generazione a sapere che stiamo distruggendo la Terra e l’ultima che può fare ancora qualcosa”.
È chiaro che la problematica del cambiamento climatico è una sfida globale complessa, con profonde implicazioni sulla vita dell’intera umanità, che può essere affrontata solo con soluzioni globali, ma qui interviene, in modo preoccupante, la crisi geopolitica in corso
Il rischio di scelte da compiere sempre più onerose
Non vi è dubbio che il ritorno della guerra in Europa, dopo 75 anni di pace e prosperità, ha segnato una brusca inversione di tendenza e un ritorno a dinamiche che pensavamo ormai definitivamente superate.
Come sottolinea Vittorio Emanuele Parsi ne Il posto della guerra e il costo della libertà (Bompiani , 2022): “La complessità contemporanea è in fondo sintetizzabile proprio in questo: nel moltiplicarsi di sfide e problemi che, piuttosto che sostituirsi gli uni alle altre, si accumulano e, così facendo, spesso si complicano e ingigantiscono a vicenda, restringendo il campo delle risposte e delle soluzioni possibili, rendendole più onerose e facendo salire il costo delle scelte da compiere e delle decisioni da adottare”.
E non c’è dubbio che nel mondo prossimo venturo queste decisioni saranno al contempo più urgenti e indispensabili e più difficili da compiere. È difficile pensare che si possa tornare alla situazione precedente alla guerra in Ucraina, anche perché quella situazione era già caratterizzata da un equilibrio difficile. Fino all’avvento della guerra in Europa si pensava che fossimo ancora in un un’epoca di globalizzazione e convergenza, in cui la democrazia liberale potesse essere acquisita dalla maggior parte dei Paesi del mondo.
Probabilmente già da diversi anni eravamo entrati in un’epoca di disequilibrio, ma la guerra in Ucraina ci sta precipitando verso un’era di divergenza che sarà probabilmente destinata a durare fino a quando l’attacco alla democrazia da parte delle società autoritarie, in primis Russia e Cina, non sarà contenuto e, auspicabilmente, sconfitto. Questo passaggio è difficilmente reversibile perché riguarda fondamentali divergenze sulle modalità con cui il mondo deve essere governato, ma anche sui principi e sulle regole del gioco della vita di miliardi di cittadini.
Dal punto di vista operativo, come sottolinea ancora Parsi, “la consapevolezza di essere passati da un’era a un’altra implica l’abbandono delle politiche finalizzate ad accelerare la convergenza a favore di quelle orientate a gestire la divergenza, affinché sia possibile evitare, limitare o controllare il conflitto, o addirittura, la guerra e, più in generale, scongiurare che le potenze autoritarie compromettano il benessere, la sicurezza e la stessa sopravvivenza delle società aperte”.
Questo non è certamente facile, soprattutto in una società complessa e articolata caratterizzata dal diffondersi di fake news, con un aumento enorme delle percezioni errate da parte dei cittadini e dalla diminuzione della fiducia verso le istituzioni.
La crisi a cui assistiamo caratterizza contemporaneamente le relazioni politiche e, quindi, anche i rapporti di forza, innanzitutto tra le grandi potenze, le relazioni economiche che non appaiono più in grado di sostituire le prime, come per un po’ si è pensato grazie anche allo sviluppo delle imprese multinazionali, un tempo ritenute in grado di superare anche gli attori istituzionali e cioè i governi nazionali.
A tutto ciò, infine, non riesce più a dare risposte il sistema delle istituzioni internazionali che, dopo la Seconda guerra mondiale, a partire dalle Nazioni Unite, hanno cercato di migliorare la ricerca di sicurezza e la promozione dello sviluppo economico sociale in tutto il mondo.

L’avvento dell’era della divergenza nei rapporti tra i Paesi democratici e quelli autoritari riguarda tutte e tre queste dimensioni il che significa che, in particolare dal punto di vista economico, è in gioco la sopravvivenza della globalizzazione o, viceversa, l’evoluzione verso aree economiche e politiche chiuse le une rispetto alle altre e francamente rivali.
Che significa questo per la salute? Che i cittadini del mondo dovranno preoccuparsi innanzitutto della propria salute individuale, come è emerso dalla pandemia in cui milioni di persone sono morte, nei Paesi più ricchi – perché condizionate nelle loro scelte da false informazioni sui vaccini – e in quelli più poveri –per la mancanza degli stessi e poi di quella dei sistemi sanitari senza i quali sarà impossibile curarsi –.
Le onde della domanda e dell’offerta
In questo contesto, i sistemi sanitari del mondo universalistici, in particolare i Servizi Sanitari Nazionali pubblici, sono avviati a entrare in una tempesta perfetta in cui le onde della domanda e dell’offerta possono, se non spazzarli via, comprometterne profondamente la sostenibilità.
Basta guardare a quello che sta succedendo in Italia, che sta seguendo a ruota ciò che è già successo in Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda e Regno Unito dopo la crisi economica e la recessione globale del 2008.
Un invecchiamento massiccio della popolazione accoppiato a un inverno della natalità e l’aumento delle malattie croniche insieme al ritorno di quelle infettive sul versante della domanda, l’aumento di costi e la scarsità del personale sul versante dell’offerta stanno compromettendo la sostenibilità dei sistemi sanitari con un crescente numero di cittadini che non riesce più ad accedere ai servizi e che sempre più spesso rinuncia alle cure.
La risposta darwiniana è nell’aumento delle disuguaglianze a causa di una selezione sociale tra coloro che sono in grado di pagare per le prestazioni e coloro che, non avendo risorse, vedono la propria salute sempre più compromessa, ma ciò non è eticamente accettabile, perché nessun Paese può essere considerato civile se a una persona viene negata assistenza sanitaria perché non ha i mezzi per pagarla e, purtuttavia, è quello che sta, più o meno nel disinteresse generale, succedendo, anche – o forse soprattutto – in Italia.
È un futuro a cui non dovremmo rassegnarci perché sono possibili concrete ed efficaci soluzioni se solo avessimo la volontà politica e la capacità di realizzarle.
Esse consisterebbero nel fare adeguati investimenti nel settore sanitario, nel guadagnare salute da parte dei cittadini con comportamenti responsabili, nel puntare con decisione sulla prevenzione e sugli interventi precoci, sull’empowerment delle persone, sulla riorganizzazione dei servizi sanitari. Soluzioni di facile comprensibilità, ma di difficile realizzazione per il tradizionale disallineamento tra i protagonisti del sistema, con i politici propensi a investire in settori che forniscano loro più immediati consensi per essere eletti e per consolidare il loro potere, manager che sono obbligati a far quadrare i bilanci delle proprie aziende, professionisti concentrati sul proprio orizzonte tecnico, cittadini che quando sono sani vogliono pagare meno tasse possibili, ma che quando si ammalano vogliono accedere immediatamente a prestazioni sempre più costose e, infine, un’industria che vuole ritornare sui propri investimenti finalizzati a produrre tecnologie sempre più efficaci ma con costi crescenti.
Ci sono le premesse per contraddizioni e contrasti tra i diversi stakeholder a meno che non si abbia appunto la volontà politica, la capacità manageriale e l’impegno civico da parte di tutti per trovare delle soluzioni che concilino i diversi punti di vista e che siano vincenti per tutti.
Futuro armonico o distopico?
Si tratta di avere la capacità di immaginare, pianificare e costruire un futuro verso cui non transitare come passeggeri passivi perché, dato quanto abbiamo descritto, non sarebbe un futuro armonico ma alquanto distopico e avere il coraggio di impegnarsi, talvolta anche contro i pronostici che ci consegnano un mondo in tempesta e un’Italia avviata verso un inesorabile declino, fuori dai giochi importanti e sempre più indebitata, impoverita, ignorante e marginale.
Affrontare queste sfide in Italia sarà particolarmente difficile per il progressivo depauperamento del capitale umano. Anni di disinteresse e disinvestimento nei confronti della scuola e dell’università hanno prodotto una popolazione in maggioranza povera di competenze numeriche e letterarie e, conseguentemente, analfabeta scientifica e funzionale. Le classifiche di OECD e Commissione Europea ci relegano costantemente agli ultimi posti per scolarizzazione e formazione professionale, con il record assoluto di ragazzi NEET, né a scuola né in attività di addestramento lavorativo e la percentuale minore di adulti con una formazione superiore.
E invece è proprio sulle giovani generazioni che dobbiamo puntare per affrontare in modo deciso la crisi strutturale del nostro Paese, stipulando un’alleanza intergenerazionale che consenta all’Italia, se non di eccellere, almeno di non sparire dal novero dei Paesi più avanzati.
Non abbiamo tanto tempo, ma è un tentativo che dobbiamo assolutamente fare.