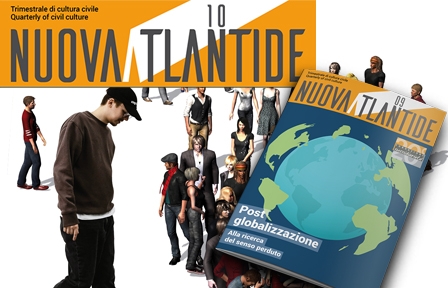Il futuro ordine mondiale non potrà fare a meno degli Stati Uniti. Ma come si sta preparando Washington alle grandi manovre? Nel disequilibrio attuale, nella scomposizione e ricomposizione di nuovi blocchi, il Paese è impegnato a recuperare la fiducia dei tradizionali alleati preoccupati per le turbolenze interne che hanno prodotto crepe nel suo modello di democrazia. La politica americana avveduta non può che ripartire dalla sua storica architrave. Perché solo una democrazia forte può consentire agli USA di tornare ad affermare la propria leadership dialogante con l’Occidente. E così trattare con la Cina, vertice di un blocco che considera l’esperienza delle democrazie un qualcosa di definitivamente superato. Spunti e riflessioni autorevoli da un forum promosso dall’università di Omaha, Nebraska.
Lo sprofondo di questo modello di globalizzazione ha avuto l’effetto trainante e problematico di aver messo in discussione quella forma di governo chiamata democrazia. In Occidente – anche in Paesi di consolidata tradizione democratica – si sono aperte vistose crepe dovute a una sempre più evidente sfiducia dei cittadini/elettori/persone verso gli “eletti”. I rappresentati hanno sfiduciato i rappresentanti e qualche rappresentante della politica ha fatto proprio quell’esplicito malcontento, orientandolo verso una soluzione del problema affrettata, a tutto svantaggio dell’idea classica di democrazia e di tradizionale gestione del potere. Una scorciatoia “populista”, una curva pericolosa.
Oggi, con il default della globalizzazione per come l’abbiamo conosciuta, l’Occidente si interroga su quali rischi reali corra la democrazia. Cioè: nonostante la criticità di questo presente, il modello democratico sarà ancora un protagonista credibile nel futuro ordine mondiale? Un competitor agguerrito?
Le indispensabili relazioni
La fase di transizione – più o meno lunga non è dato sapere – che investe un mondo in enigmatica fibrillazione, può rappresentare un’occasione da non sprecare. In chi ha a cuore le sorti della democrazia, la stagione della transizione può assumere l’architettura di laboratorio che ragioni, senza reticenze, su quel che non ha funzionato, generando scompensi e disaffezione (anche radicale) che sono sotto gli occhi di tutti. E da lì ripartire per offrire di nuovo una chance autorevole a un modello che continua a scommettere sul valore della persona, delle comunità, della politica istituzionale come ambito decisionale e sovrano, formato da soggetti eletti dal popolo attraverso l’esercizio del voto universale.
Se così non avvenisse, si aprirebbe un futuro ancora più fosco della confusione attuale. La storia insegna. È la seconda volta che la globalizzazione entra sulla scena e poi il sipario cala bruscamente. La prima volta è stata nel 1914, con il conflitto su scala mondiale che spense l’euforia, soprattutto culturale, del primo decennio del XX secolo1; la seconda nel 1989, dopo la caduta del Muro di Berlino, quando la globalizzazione riprese la corsa per poi arrestarsi per deficit strutturali. Dunque, la discussione è apertissima vista la densità del problema.
Opportuno allora richiamare l’attenzione su come la questione della democrazia, nella prospettiva di garantirsi un saldo rapporto con altri Paesi, stia interrogando gli Stati Uniti d’America. Discussione divenuta incalzante per vicende interne legate a passaggi elettorali (vedi le ultime elezioni presidenziali) che hanno lasciato il segno. Fastidiosi scricchiolii che hanno fatto rumore – e non poteva essere diversamente – visto che il Paese, storicamente, si fa forte di una primogenitura morale nel coltivarla e diffonderla e, non di rado, preoccupandosi di assicurarla in altri Paesi in una logica di possibili e strategiche partnership. La sintesi può essere questa: proteggere e rafforzare la democrazia a vantaggio degli americani e, quindi, del resto del mondo. In primis quel mondo che viene pensato come blocco aggregante nell’attuale scomposizione, conflitto fra blocchi e ricomposizione fra blocchi.
La caduta della libertà
Della scivolosa e controversa materia si è discusso all’università di Omaha (Nebraska), in un dialogo con Gerald Seib, giornalista e analista del Wall Street Journal e Chuck Hagel, politico di estrazione repubblicana, veterano di guerra, già senatore che, a suo tempo, non si peritò di entrare in contrasto con Bush non condividendo la decisione di portare la guerra in Iraq; in seguito si è ad ambienti democratici, tanto che il presidente Obama nel 2013 lo ha nominato segretario alla Difesa. Dunque, una personalità non facilmente inquadrabile secondo attribuzioni di schieramento definitive.
Si può tentare di esprimere con una domanda il leit motiv che ha scandito i lavori del forum: “Ma perché, vista la complessità della situazione globale, va sbiadendo il modello di democrazia, deficit a cui non sono estranei gli USA?” Seib spiega: “Credo che i leader autoritari stiano facendo una buona opera di convincimento quando affermano che i Paesi gestiti da una mano ferma e con un’economia controllata centralmente si stanno dimostrando più efficienti delle democrazie. Oggi le democrazie, al contrario, sono luoghi in cui le persone passano molto tempo a discutere e a litigare, senza riuscire ad assumere decisioni efficaci. Non voglio passare per melodrammatico, ma questo è il tipo di pensiero che ha contribuito a portare alla Seconda guerra mondiale, quando i leader di Germania e Giappone sostennero esplicitamente che il fascismo era superiore alla democrazia e che, inevitabilmente, l’avrebbe vinta sulle nazioni democratiche. Putin e altri autocrati ragionano e si muovono così”.

Seib, a supporto del suo pensiero, riferisce di una notizia contenuta nel nuovo rapporto di Freedom House2: “Il 2022 è stato il diciassettesimo anno consecutivo in cui la libertà nel mondo è diminuita anziché aumentare. E, come riportato in un recente articolo della rivista Foreign Affairs, ecco alcuni Paesi nei quali è più manifesta la criticità:
• Tunisia, l’unica democrazia emersa dalla Primavera araba, che si sta trasformando in una dittatura;
• Bangladesh, Ungheria e Turchia, tre Paesi in cui le elezioni stanno diventando meno democratiche, dove, anzi, si sta verificando il fenomeno dell’autocrazia elettiva, in cui gli uomini forti usano le elezioni per prendere il potere e poi iniziano a far regredire la stessa democrazia che hanno usato per entrare in carica;
• Algeria, Bielorussia, Etiopia, Sudan e Zimbabwe, dove i regimi antidemocratici stanno mantenendo il potere;
• Brasile, dove il presidente sconfitto non accetta il risultato elettorale;
• Messico, dove il presidente sta cercando di mettere a tacere chi lo critica ed eliminare gli equilibri;
• India, dove il primo ministro Modi sta provando a restringere gli spazi della libertà di stampa, i diritti delle minoranze e l’indipendenza della magistratura;
• Israele, in cui è in atto un attacco all’indipendenza del sistema giudiziario, mossa qui particolarmente grave in quanto nel Paese vige un sistema parlamentare con una sola camera legislativa controllata dalla coalizione del primo ministro, per cui l’indipendenza del sistema giudiziario rappresenta un contrappeso fondamentale e baluardo del sistema democratico.
Inoltre, immaginate un mondo gestito da autocrati e dittatori che hanno a disposizione il potere emergente dei social media, delle piattaforme di disinformazione, delle capacità di sorveglianza online e dell’Intelligenza Artificiale, e avrete un quadro piuttosto spaventoso. Però, Samantha Power, ex ambasciatrice americana alle Nazioni Unite e attuale direttrice dell’Agenzia per lo sviluppo internazionale, in un suo recente articolo ospitato su Foreign Affairs3 vede possibile un cambio di indirizzo quando afferma che l’anno scorso l’autoritarismo nel mondo potrebbe aver segnato l’apice. L’autrice sostiene che l’attrattiva dell’autoritarismo diminuirà dopo la disastrosa performance della Russia in Ucraina e l’epica gestione sbagliata del Covid da parte della Cina”.
La drammatica responsabilità degli USA
Seib riconosce che la partita con tiranni e dittatori non si risolverà mai una volta per tutte a favore della democrazia. Tuttavia, va giocata con la responsabilità degli USA di contribuire ad allargare la base di Paesi che – attratti da un modello istituzionale finalmente partecipativo dal basso – scelgono in libertà l’opzione democratica, cioè senza imposizioni e ingerenze esterne. Chiarisce con termini definitivi: “La nostra Storia è costellata di molti errori, quello più grande che abbiamo commesso in Vietnam, in Iraq, in Afghanistan, è stato il non saper o voler offrire una sponda collaborativa per aiutarli per davvero a prosperare; abbiamo colpevolmente trascurato l’occasione di accostare e conoscere la cultura di quei Paese, non ne abbiamo compreso la società, la religione, la propria legittima diversità. Già, la diversità. La loro diversità non significa che noi siamo migliori. Le relazioni nascono e si costruiscono attraverso la fiducia reciproca. Questo è mancato, questo va recuperato. In tal senso sono ottimista e speranzoso perché sono realista. Ci sono senz’altro ostacoli impegnativi da superare, ma dovremmo ricordarci che cosa significano gli Stati Uniti per il resto del mondo. Gli Stati Uniti possono ancora rivelarsi un partner autorevole, un interlocutore di primo piano. Ma perché questo sia possibile, dobbiamo noi innanzitutto avere a cuore il valore della democrazia, impegnandoci perché, costantemente, si rinnovi. I recenti fatti avvenuti negli USA, oggi come ieri, così come quelle convinzioni autarchiche e populiste che si sono negli ultimi tempi insinuate al nostro interno, ci dimostrano come non possiamo mai dare la democrazia per scontata”. Insomma, nel pensiero di Gerald Seib si riscontra un giudizio assai negativo nei confronti del concetto di democrazia da esportare, così caro alla cultura neocon. Una visione che ha fallito, come attestato dalla ritirata USA dall’Afghanistan e il ritorno al potere dei talebani.
Gli anticorpi della democrazia
Adesso gli USA sono impegnati a capire. Soprattutto quando la democrazia mostra anticorpi deboli. Chuck Hagel invita a riflettere: “In questo momento è difficile per gli Stati Uniti essere un partner credibile a livello globale, quando il nostro Paese è diviso, lacerato, polarizzato. Oggi democratici e repubblicani, anziché adoperarsi per ricomporre fratture dolorose in uno spirito di comune, riconoscimento del bene supremo, praticano una politica divisiva che, nei fatti, nuoce a quel che viene prima: le nostre istituzioni democratiche”. Hagel, a supporto del suo ragionamento, ricorda di aver parlato con ambasciatori di tutto il mondo raccogliendo solo commenti preoccupati, ovvero la sopraggiunta impossibilità a fidarsi degli Stati Uniti. E ha aggiunto: “Siamo a questo punto non solo per la politica e le mosse adottate da Donald Trump, le difficoltà vi erano anche prima. Lui ha dato voce e amplificato una diffusa irrequietezza in larga misura motivata. Ora la politica ha il compito di smaltire la sbornia e capire cosa per davvero sta succedendo. Solo avviandoci con risolutezza riusciremo a invertire la rotta, incominciando a venire a capo delle più vistose criticità, così da recuperare credibilità e autorevolezza a livello internazionale.
Con gli storici alleati e con nuove alleanze sempre più importanti da realizzare in questa fase di drammatica tensione con l’incubo del nucleare e di una tecnologia sempre più sofisticata”. In pratica il navigato politico americano avverte quanto è pericoloso per gli USA e, più in generale per l’Occidente, accettare che il predominio su scala globale delle armi nucleari e della tecnologia al servizio della sicurezza appartenga a Stati coalizzati che ritengono la democrazia un modello superato e quindi da combattere. “In un mondo squilibrato nel quale ciò che è conosciuto è sempre meno, il nostro compito non può che essere quello di contribuire a generare stabilità, investendo sul metodo delle relazioni. Ne va della nostra storia, dei nostri interessi. Oggi, trattare con la Cina non è semplice. Eppure, è doveroso farlo. Ma quel dialogo può essere per gli USA soddisfacente, se saremo capaci di presentarci con il volto di un Paese unito, tornato a esprimere la sua vocazione di realtà fedele ai valori della democrazia e, di conseguenza, soggetto leader di quel mondo che continua a riconoscersi nella centralità del modello democratico”.
L’impossibile solitudine americana
La guerra ha prodotto accelerazioni, e qualcosa si sta vedendo del possibile ridisegno. Ma, infine, come ne uscirà il mondo? Quali allineamenti andranno a comporsi? E quale ruolo vi avranno gli Stati Uniti? Hagel prova a guardare in là: “Il mondo è totalmente interconnesso. Nonostante le criticità che ci attraversano, siamo in condizioni migliori di quasi tutti i Paesi della Terra. Ma non possiamo pensare di fare da soli, in un modo o nell’altro dipendiamo da altri Paesi. Come ex Segretario alla difesa posso dire che la nostra potenza e autorevolezza militare le abbiamo costruite negli ultimi 75 anni, grazie alle nostre alleanze. Questo ci ha permesso di avere nostre basi per far stazionare truppe, navi, aerei. La nostra potenza è anche un’assicurazione. Per l’interesse globale americano. Per l’interesse globale del mondo che vuole continuare a essere libero”. E solo un Paese saldamente ancorato al suo modello di democrazia, lascia intendere Hagel, può essere un fattore di equilibrio duraturo. Un Paese mediatore.
NOTE
1. Florian Illies, 1913. L’anno prima della tempesta, Feltrinelli, Milano 2023.
2. Freedom House, Freedom in the World 2023, marzo 2023, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2023-03/FIW_World_2023_DigtalPDF.pdf
3. S. Power, How Democracy Can Win. The Right Way to Counter Autocracy, in Foreign Affairs, 16 febbraio 2023.