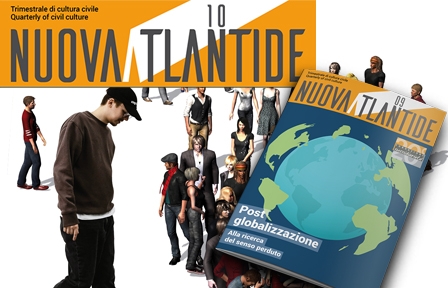Il rumoroso declino dell’attuale modello di globalizzazione è il risultato di oltre quarant’anni di paradigma dominante neoliberista. Un pensiero che ha puntato tutto sulla centralità del mercato “fa da sé”. Sregolato. Totalizzante. Che si è retto su una malintesa concezione di libertà. Ma ora che il vaso di Pandora – espressione di quella visione di globalizzazione mercatista – è andato in frantumi senza che le scuole di pensiero che l’hanno alimentato abbiano intenzione di arrendersi all’evidenza, si tratta di avviare una ripartenza di segno diverso. Là al centro il mercato. Qui l’uomo. Occorre una ripartenza sensata. Per aprire la strada alla costruzione di una globalizzazione della relazione.
Infine, il vaso di Pandora della globalizzazione è finito in frantumi. Da oltre quarant’anni stava collocato su un tavolo appena, appena inclinato. In principio ne occupava, tenuto a lucido, il centro. Ma era già un’illusione in partenza. La visione distorta impediva di cogliere la realtà: appunto, l’instabilità della superficie su cui era stato posto il vaso. Perché, quasi in modo impercettibile, si muoveva e non poteva che essere così. Pericolosamente avanzava verso il momento dello shock, della rovinosa caduta. Negli anni, qualcuno metteva in guardia dalla deriva rifacendosi a richiami keynesiani; così come acquistavano interesse gli inviti di papa Francesco a prendere coscienza dell’assoluto stato di calamità in cui versa il mondo per via di un invasivo e irragionevole paradigma dominante (in particolare: Laudato si’ e Fratelli tutti). Avvertimenti opportuni per richiamare l’attenzione sull’inevitabilità del crollo, perché il vaso di Pandora della globalizzazione poggiava su un modello di tavolo dalle fondamenta disequilibrate. Ci ha messo il suo tempo a rotolare giù: le illusioni, quando ben coltivate e assecondate, dimostrano sempre una forte capacità attrattiva.
Le “distrazioni” del neoliberismo
Oltre quarant’anni fa, veniva dato il via libera all’economia di mercato neoliberista; una dottrina dove si afferma che il motore di una società libera consiste nel personale accumulo di ricchezza; e il benessere collettivo appartiene alla “mano invisibile” del mercato e l’alternarsi dei cicli economici. Ecco che, su quelle basi, veniva a formarsi un modello di liberismo globalizzato. Disequilibrato già in partenza. L’entusiastica visione di quel pensiero, fortemente connotato su una malintesa concezione della libertà dell’individuo, non gli ha permesso di riconoscere problemi che esso stesso aveva generato. I più evidenti e drammatici: il non essere in grado di superare cicli economici di segno negativo e l’aver disconosciuto la centralità dell’economia reale. La conseguenza di tali “distrazioni” ha determinato una crescente disuguaglianza sociale (il fenomeno ha coinvolto in misura assai rilevante le cosiddette economie mature) e una disoccupazione sempre più preoccupante. E, non certo elemento trascurabile, quel modello di crescita sovranazionale ha portato con sé la progressiva erosione delle risorse naturali ritenute, a torto, illimitate. Tutto ciò senza, tuttavia, voler disconoscere il fatto che nei decenni della globalizzazione sono stati raggiunti anche risultati lusinghieri, pensiamo solo alla riduzione della povertà assoluta in aree critiche del sud del mondo, ad esempio.
Il mito della crescita illimitata
L’iperglobalizzazione, frutto dell’egoismo neoliberista, ha stravolto il rapporto tra economia nazionale ed economia globale. L’economista turco Dani Rodrik, che insegna ad Harvard, ha spiegato così tale stravolgimento: “Erano le economie e le società nazionali a doversi adattare ai requisiti del libero flusso di finanza, capitali e beni. Ciò ha creato tensioni, con un aumento delle disuguaglianze e un senso di perdita di controllo da parte di ampi segmenti della società, che hanno portato un contraccolpo contro la globalizzazione». (Corriere della Sera, 15 maggio 2023). Dunque, in discussione non è la natura della globalizzazione, bensì le distorsioni che ne hanno modificato il volto relazionale e collaborativo, producendo quel tavolo disequilibrato che ha mandato in frantumi il vaso di pandora.
Va detto che il pensiero neoliberista non si è certo perso d’animo, pur davanti alla drammatica crisi finanziaria del 2008, esempio eclatante della fiducia incontrastata del mercato che si autoregola e del mito della crescita senza limiti. Vi sono ambiti istituzionali, anche accademici e think tank che perseguono nell’alimentarne la centralità innovativa. Il vaso di Pandora è finito in mille pezzi? Non importa. Lo si rimette insieme nella convinzione che il mercato, quale giudice supremo, abbia gli anticorpi necessari per continuare a veicolare un modello “salvifico” di per sé. Cioè: il fine dell’economia è interno all’economia stessa. Dunque, non può esserne messa in discussione l’ipotesi fondativa, vale a dire che i mercati sono razionali e non sbagliano mai nel collocare la ricchezza. È la realtà a essere sbagliata. L’uomo? Uno strumento. Un individuo che non comanda il gioco pur illudendosi di governarlo. Non è lui la “mano invisibile”, non è lui il croupier che fa girare la roulette. È un mezzo.

Blocchi e controblocchi
Certo, il presente, cioè lo stato delle cose, la realtà per quello che è, porta a dire che il modello di globalizzazione sotto il sigillo del neoliberismo ha fallito la sua missione. Evento testimoniato dal sopraggiungere su larga scala di misure protezionistiche che sono la spia di un malessere diffuso, di una forma di difesa dettata dalla sfiducia e dalla paura. Con annesse varianti di populismo. Fenomeni venutisi ad accentuare con gli anni Venti del XXI secolo, a causa dell’intreccio fra quattro grandi crisi foriere di incertezza globale: crisi pandemica, crisi geopolitica, crisi economico-sociale, crisi climatico-ambientale. Sono emergenze che si intrecciano. Per dire: la crisi geopolitica impatta su quella ambientale, la pandemia sul modo di lavorare.
Il 2022 è stato l’anno simbolo e di sintesi di questi incroci pericolosi, “scioccanti”, con il punto più acuto coinciso con la guerra d’aggressione della Russia all’Ucraina. Scrive l’economista Mario Deaglio: “Nell’aprile-maggio 2022, il problema delle catene globali del valore si trasferì sul piano geopolitico: i blocchi e controblocchi al commercio da e verso la Russia cominciarono a distorcere i flussi commerciali, dal settore del gas a quello del petrolio”.Il mondo post globale, Guerini e Associati, Milano 2022). La scomposizione dei blocchi e la ricomposizione possibile sono fenomeni destinati a produrre un nuovo ordine mondiale assai disordinato. Siamo attesi da una lunga fase di transizione scandita da alleanze, tensioni e sospetti. L’epoca della post globalizzazione non partirebbe (parte) secondo buoni auspici.
Limiti del modello antropologico dell’homo oeconomicus
Eppure, tra il palesarsi di una post globalizzazione densa di incognite e un egoismo neoliberista che non intende uscire definitivamente di scena – e perciò ancora volontaristicamente implicato nel riaggiornare la propria leadership “sregolata” e quindi ricomporre il “suo” vaso di Pandora (non sarà faticoso e forse impegno improduttivo come l’esercizio di far rientrare nel tubetto il dentifricio fuoriuscito?) – viene da domandarsi se le quattro grandi crisi in essere non appartengano piuttosto a una condizione di deficit ancora più strutturale: una crisi di tipo antropologico e, di concerto, culturale. Una crisi attribuibile all’infatuazione per il modello antropologico dell’homo oeconomicus. Un uomo cristallizzato, mercatista, stagnante, imprigionato nella morta gora dell’ingordigia finanziaria. Iperindividualistico. Ipertecnicizzato. Un uomo “insensato”.
Ecco allora che il muoversi – qui e ora – alla ricerca del senso perduto (come da richiamo esplicito sulla copertina di questo numero di Nuova Atlantide) significa mettere in moto un percorso di ritorno alla centralità della persona nella sua ricchezza più autentica e dunque finalmente sganciata dai miti dell’individualismo radicale.
Questo può essere il tempo prezioso per far crescere la domanda di un metodo relazionale affinché la post globalizzazione assuma le caratteristiche virtuose di una vera globalizzazione, di una globalizzazione della reciprocità.
Si tratta di svolta culturale che verrebbe a costruire un’economia ancillare, ovvero al servizio dell’uomo. Come esprime il sociologo Mauro Magatti, “un’economia capace di tornare a puntare sull’investimento, la qualità complessiva della vita economica, istituzionale e ambientale, la coesione sociale, lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità personali». (Prefazione, in G. Giraud, Transizione ecologica, Emi, 2016).
Un vero e proprio shock, ma questa volta di segno positivo. Laddove l’esperienza di benessere troverebbe soddisfazione nel profitto che non ha mercato: la felicità.