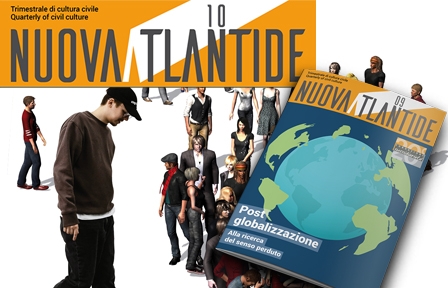La lezione del presidente Luciano Violante alla scuola di formazione politica “Conoscere per decidere”, quest’anno intitolata: “Ma cosa è la politica oggi?”. Un’ampia riflessione su argomenti di grande attualità. Tra gli altri: il rapporto nel mondo tra democrazie e non democrazie; la maggiore partecipazione al voto nei Paesi autoritari; quali problemi pongono le tirannie elettive; perché sono malviste le Corti Costituzionali. “Le democrazie hanno bisogno di cittadini democratici, non solo di leader democratici. Bisogna riabituarsi a incontrarsi, a vedersi e parlare di cose profonde, quelle che riguardano la radice della vita, dello stare insieme”.
A volte accadono cose straordinarie e non ce ne accorgiamo. Come mostrano, plasticamente, due dipinti di Bruegel il vecchio, pittore della seconda metà del Cinquecento, Caduta di Icaro e Salita al Calvario, soprattutto quando si attraversano periodi di grande ricchezza e non ci si rende conto di quello che succede attorno.
Ci sono altri esempi eclatanti, come l’intervista del 1923 di Giulio De Benedetti ad Adolf Hitler per la Gazzetta del Popolo, in cui il futuro fuhrer espresse con chiarezza il suo programma, ma il giornalista concluse che non gli pareva un dittatore troppo pericoloso.
Conoscere per deliberare vuol dire guardarsi attorno, accorgerci di quello che accade, osservarlo con maggiore attenzione e spirito critico. Che non significa essere aggressivi, ma discernere, distinguere, avere la capacità di capire meglio ciò che avviene.
La partecipazione al voto
Oggi il 60% della popolazione mondiale è guidata da governi non democratici. In vent’anni il rapporto tra democrazie e non democrazie si è invertito e il 20% della popolazione mondiale che viveva in Paesi democratici, ora non ci vive più.
Uno dei fenomeni su cui portare l’attenzione è il fatto che, nelle democrazie, le persone partecipano sempre meno al voto. L’unica eccezione sono gli Stati Uniti, dove grandi conflitti aperti da figure divisive hanno motivato gli elettori a votare. Qui negli anni 1980-2000, l’affluenza è stata del 52,1%, mentre negli anni 2000-2022 è salita arrivando al 57,23%.
In tutta l’Europa continentale si riscontra invece un calo. In Gran Bretagna l’affluenza negli anni 1980-2000 è stata del 75,4%, negli anni 2000-2022 del 65,4%, il 10% in meno. In Germania, negli stessi periodi, si passa dall’82,45% al 75,26%. In Francia, dall’81,86% al 78,94%, un calo minore, ma sempre calo. In Italia la percentuale di voto è passata dall’87,31 al 76,19%.
Osserviamo invece quanto succede in alcuni Paesi gestiti in modo autoritario. L’affluenza nelle ultime tornate elettorali è stata: India 67%, Turchia 86%, Ungheria 69%, Iran 75% nel 2017. Nel 2022 in Iran è andato a votare meno del 50% degli aventi diritto, perché il collegio degli autodefiniti “saggi” ha scartato molti candidati determinando così l’astensione dei loro sostenitori.
Nei Paesi autoritari, quindi, si verifica una maggiore partecipazione al voto rispetto ai Paesi europei democratici. Questo è il paradosso della democrazia: essere criticata dove c’è e desiderata dove manca. Laddove c’è democrazia, e i cambiamenti possono avvenire pacificamente, c’è un minore interesse alla partecipazione.

In realtà, non in tutte le democrazie vivono società pacificate. Queste sono quelle società, come l’Italia, la Germania, la Gran Bretagna, in cui il risultato elettorale non viene contestato. In esse vige un principio di accettazione. Cosa che non avviene, ad esempio, negli Stati Uniti e in Francia. Oltralpe, la votazione diretta del Presidente della Repubblica in due turni fa in modo che possa essere eletto qualcuno che non gode di un grande consenso tra i cittadini, pur possedendo per legge grandi poteri (il Parlamento può costringere la maggioranza a votare). È il caso di Emmanuel Macron, votato al primo turno solo dal 26% dei francesi. Questo spiega la forte opposizione popolare a cui spesso assistiamo. Negli Stati Uniti, pensiamo al rifiuto di accettare la sconfitta di Donald Trump dopo l’elezione di Joe Biden e la sua proposta di cambiare chi è incaricato di controllare la legittimità del voto. Pensiamo anche al braccio di ferro continuo che si sta verificando: Biden, che non ha più la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, dove è stata proposta un’inchiesta su suo figlio, risponde con la richiesta in Senato, dove ha la maggioranza, di un’indagine aggiuntiva nei confronti di Donald Trump. Oltre al fatto che risolvere i problemi politici rivolgendosi all’autorità giudiziaria è generalmente sbagliato, è importante sottolineare che nelle società non pacificate avere un arbitro che dirima i conflitti è fondamentale.
I nostri costituenti: nelle difficoltà un capo dello Stato ago della bilancia
La grande intelligenza dei nostri costituenti ha previsto la figura di un capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, che fosse l’ago della bilancia nei momenti di difficoltà. Questa scelta si è rivelata utilissima nei momenti di crisi degli ultimi decenni. Quando la trama politica si rompe, ci vuole qualcuno che la rimetta insieme. Nei sistemi presidenziali questo non avviene, e per questo funzionano solo quando le società sono tranquille.
Veniamo alle tirannie elettive. Come accade che un sistema elegga un suo rappresentante e poi questi abusi dei suoi poteri? Ciò succede quando c’è una frattura nella società, tale che una sua parte maggioritaria riconosce come leader chi ha eletto, anche quando assume un profilo autoritario, anche quando non si assume la responsabilità pedagogica che gli spetterebbe come leader, ma si limita a seguire le tendenze della maggioranza. In India c’è una fortissima ostilità contro gli islamici. Il primo ministro, Narendra Modi, indù, ha sollecitato questo scontro e gran parte della popolazione lo ha votato per questo. Victor Orban si muove in modo analogo. E così Recep Erdoan.
Fare leva su argomenti “viscerali” per guadagnare consenso non costruisce una società che guarda avanti dal punto di vista dei valori umani. Un dato importante di cui tener conto è che questi leader non sono votati nelle città, ma nelle campagne, dove non è presente un dibattito pubblico, dove manca un confronto di idee e dove arriva solo la comunicazione ufficiale.
Quale il ruolo delle Corti Costituzionali
In questo quadro rientra un altro elemento di grande interesse: il ruolo delle Corti costituzionali. Queste istituzioni hanno il compito di porre un limite al potere politico, avendo facoltà di cancellare una legge giudicata contraria alla Costituzione, anche contro il parere di chi rappresenta la volontà popolare perché è stato eletto. Adesso, le Corti Costituzionali sono in difficoltà in Ungheria, in Polonia, in Repubblica Ceca e, recentemente, anche in Israele, dove si sta cercando di far prevalere la volontà del Parlamento sulla Corte. Anche Orban ha depotenziato la Corte costituzionale ungherese, cambiando i membri su indicazione del governo.
Quello che caratterizza le tirannie elettive è una certa insofferenza per i controlli sulle maggioranze politiche.
Le architetture istituzionali possono essere diverse, anche nei Paesi democratici. Il sistema nato dalla rivoluzione americana è molto diverso da quello nato dalla rivoluzione francese. La prima è stata fatta contro il sovrano e il suo Parlamento che aveva imposto tasse ingiuste sulle colonie e quindi la rivolta è contro la politica. Per questo la Corte suprema negli Stati Uniti ha la funzione di assicurare che le maggioranze politiche non travalichino i diritti dei cittadini. La rivoluzione francese, invece, è una rivoluzione contro il sovrano e i suoi giudici ai quali il re firmava “mandati di cattura” in bianco. Quindi la rivolta è stata fatta contro la monarchia e i suoi giudici e, pertanto, la garanzia dei diritti è stata assegnata al Parlamento. Negli Stati Uniti la sfiducia è nei confronti della politica e il potere è dato ai giudici; in Europa la sfiducia è nei confronti dei giudici e il potere è dato alla politica.

Dopo la Seconda guerra mondiale, per scongiurare che attraverso legittime elezioni tornassero al potere altri tiranni, vennero introdotte le Corti costituzionali, per primo in Germania e in Italia e a seguire negli altri Paesi. Per ultimo in Francia, vista la convinzione radicata che chi garantisce i diritti è la politica, non il giudice.
Ma è giusto che una Corte costituita di magistrati, sia pure di altissimo livello, possa cancellare una legge fatta dalla maggioranza parlamentare? Una chiave per rispondere alla domanda è constatare che in democrazia non ci sono poteri assoluti, né diritti assoluti. Il potere del Parlamento e quello della Corte costituzionale trovano un equilibrio reciproco nel loro funzionamento. I sistemi democratici rifiutano i poteri assoluti cercando un bilanciamento continuo tra potere e contropotere. È un sistema fatto di checks and balances, pesi e contrappesi. I sistemi autoritari o le culture autoritarie, invece, rifiutano il contrappeso e si fondano sullo strapotere delle maggioranze parlamentari.
Un punto critico riguarda il fatto che i sistemi democratici, nell’attuale contesto caratterizzato dalla velocità, sono lenti, mentre le decisioni dei poteri autoritari sono molto più rapide. La democrazia si deve confrontare, deve sentire e valutare le obiezioni, accettare le correzioni. Le autocrazie, al contrario, decidono peggio, ma in modo più celere.
Questo è uno dei motivi per cui oggi i regimi autoritari vengono apprezzati. Un altro motivo è che qualunque maggioranza considera un fastidio il confronto con l’opposizione. Così come considera fastidiosa una Corte costituzionale che cancella una sua legge. Questo capita quando manca una sensibilità alla politica, il confronto non è percepito come un valore in sé e il fatto che un giudice possa cancellare una legge non è considerata una garanzia per tutti.
Maturare questa mentalità richiede un lungo processo. La democrazia non esiste in natura, va coltivata, va seguita, va rispettata e quando non si coltiva deperisce. Non esistono democrazie costruite pacificamente, perché per ottenerle è stato necessario togliere il potere assoluto a chi l’aveva. Le lotte di liberazione, la resistenza, la Seconda guerra mondiale hanno portato alla democrazia a prezzo del sangue. Le democrazie non muoiono per omicidio, ma per suicidio, quando perdono la propria ragione d’essere, quando i cittadini cominciano a pensare che, in fondo, non faccia una grande differenza il fatto che ci sia o meno. A quel punto le concezioni autoritarie prendono piede.
Ma in che cosa risiede il valore della democrazia? Innanzitutto, il rispetto verso l’opinione dell’altro, della persona dell’altro, che sia maggioranza o minoranza, che sia alto, basso, nero o bianco. Il rispetto non affatto è innato, anzi, è quasi più normale l’aggressività verso ciò che è diverso.
Quindi il rispetto è frutto di un processo pedagogico. Perciò, la professione da cui riprendere il filo di questa educazione è quella degli insegnanti. Il problema, però, è che la società italiana affida i propri figli a un ceto professionale che stima poco e a cui chiede di trasmettere dei valori che essa stessa disconosce. Il patto educativo tra scuola e famiglia è un problema democratico, non solo scolastico. La democrazia è un complesso di comportamenti, non solo di regole. I comportamenti non si apprendono leggendo un codice.
Le democrazie sanno di essere imperfette e continuano a correggersi. Sanno che esiste sempre una diseguaglianza che va colmata, delle sacche di violenza che vanno superate. La democrazia è una condizione mobile, non statica. In questo risiede il suo fascino. Non c’è quiete in democrazia. C’è un movimento continuo per garantire diritti non riconosciuti, possibilità non viste. Un sistema di questo tipo impegna le forze vive di un Paese a modificare lo stato delle cose, a far crescere alcune posizioni piuttosto che altre, a riconoscere più diritti, a esercitare i doveri.
I doveri non sono l’altra faccia dei diritti, sono il frutto della comunità. Se una società rispetta i propri doveri, rispetta anche i diritti dell’altro. È difficile esercitare i diritti se non rispettiamo i nostri doveri. Un leader deve anche dire che cosa è necessario, far capire che il rispetto dei doveri è essenziale per una comunità democratica perché, altrimenti, si sfalderebbe, perderebbe il senso di sé e quindi andrebbe in crisi. Le organizzazioni di massa dovrebbero concepire il proprio ruolo non solo come tutrici dei diritti, ma anche come promotrici di una cultura dei doveri.
Il discorso politico e i cittadini democratici
Il nostro Paese ha avuto maestri importanti. Io ho avuto tanti maestri. Quando dovetti occuparmi di terrorismo, il mio partito mi diede una scorta. Erano giovani uomini che uscivano dalla fabbrica alle 18.00, con la loro macchina facevano chilometri per venire a prendermi, portarmi nella città in cui avevo un impegno e poi mi riaccompagnavano a casa. Capitava di tornare anche alle 3 del mattino e loro alle 5 rientravano in fabbrica a lavorare. Questa è stata per me una grande lezione.
Altri maestri mi hanno insegnato che è statisticamente improbabile avere sempre ragione e che è ugualmente improbabile che l’altro abbia sempre torto, anzi, è impossibile.
C’è una tecnica del discorso politico che non è quella dell’aggressione, ma consiste nel partire dal punto su cui si potrebbe essere d’accordo con l’avversario. Ciò implica sapere ascoltare, valutare quale sia il punto di interesse di ciò che viene detto, anche se non è convincente, e richiedere approfondimenti in merito. Saper far presente che, mentre su altri punti non si è d’accordo, su questo ci sono margini per andare avanti a confrontarsi. Così è possibile costruire un rapporto perché l’altro vede che non ha di fronte a sé un avversario ideologico, ma qualcuno che cerca di capire.
Il discorso politico è un racconto che fa sentire il destinatario protagonista di quello che stai dicendo. Il discorso politico costruisce delle comunità, quanto più le persone che ascoltano si sentono coinvolte in un ragionamento. Non è quindi una serie di slogan, non sono urla, è racconto. Sembra strano, ma è racconto che rispetta chi ascolta e anche gli avversari. Attraverso quel racconto emerge come ci si rapporta con l’avversario. Quello che sto dicendo è abbastanza semplice, difficile ma semplice.
Un altro mio maestro, Aldo Moro, con cui mi laureai, mi insegnò che è importante sapere distinguere tra sintetizzare e banalizzare. E mi spiegò che chi sintetizza toglie consapevolmente il superfluo, chi banalizza toglie inconsapevolmente l’essenziale. Troppo spesso la banalizzazione supera la semplificazione. E troppo spesso viene usata per colpire l’emotività. Dobbiamo sfuggire alla trappola dello stupore suscitato da messaggi banali ed emotivi, e occuparci dello stupore generato dalla qualità delle cose.
In conclusione, a che cosa serve una scuola di politica? Serve a riprendere in mano i fili di un pensiero e di un comportamento democratico. Le democrazie hanno bisogno di cittadini democratici, non solo di leader democratici. Bisogna riabituarsi a incontrarsi, a vedersi e parlare di cose profonde, quelle che riguardano la radice della vita, dello stare insieme. Più moltiplichiamo questi sforzi, più cominciamo a creare le basi di un sistema, quelle in cui il senso del valore della democrazia cresce, e cresce anche l’allarme che la democrazia ci sfugga di mano.
L’inaugurazione della scuola di formazione politica organizzata da Fondazione per la Sussidiarietà, Società Umanitaria e Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine si è svolta il 16 marzo 2023 presso la Società Umanitaria di Milano.